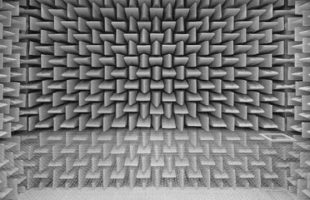Non riesco a fare a meno di pensare ad un articolo letto qualche mese fa e a quanto pare la mia memoria ogni tanto si diverte a farmi ricordare cose insignificanti e non così interessanti in merito a quante volte al giorno prendiamo in mano il cellulare per controllare le dieci, cento, mille notifiche che ci rendono incapaci di stare disconessi dal mondo. In effetti, ho provato a contare le volte in cui consulto il telefono, per lo più nei momenti di ozio, e devo ammettere che un po’ di imbarazzo l’ho provato. L’articolo parlava di qualcosa come 2600 volte, dico duemilaseicento volte al giorno. Certo, non sono arrivata a tanto, ma a circa 40 volte, sì. In realtà non mi reputo un individuo espressamente succube della tecnologia, anzi. Se posso evito, come si evita il contatto con il corrimano dell’autobus, il telefono e i social network. Fino a qualche mese fa, forse, lo potevo ritenere improbabile, se non addirittura impossibile. Poi però ho dovuto fare un confronto con il mio io qui ed ora ed il mio io online e ovunque-altrove-ma-non-qui, l’io che mostra spesso e volentieri solo una parte, quella più piacevole e accattivante, in cui tralascio odissee personali e imprese certamente più snervanti e meno intriganti per un pubblico che vuole mettere un “mi piace” più per noia che per interesse. Lo trovo avvilente. Avvilente perché in verità quei “legami” virtuali, perlopiù, sono chimere sgraziate prive di qualsivoglia forma di sensibilità e di cui siamo bulimici.
Sigmund Bauman, nel 2006, parlava di una “società liquida” dove i legami, sempre più fragili ed effimeri, tendono ad essere non solo interscambiabili, ma anche e soprattutto irrinunciabili. Una società dove siamo assuefatti ai legami virtuali, dove non possiamo permetterci di non essere reperibili e tracciabili. Vogliamo la nostra privacy, in fondo la nostra solitudine ci manca, ma abbiamo bisogno degli altri. E internet soddisfa questa nostra aspettativa. Riuscire a fermarsi, mettersi nella sala d’attesa del mondo, è un’epopea auspicabile per chiunque, soprattutto per coloro che in realtà non riuscirebbero mai a fare a meno di una vita virtuale, di una memoria digitale.
Una memoria a portata di mano, estensione della nostra corteccia cerebrale, dove ci sentiamo costretti o, ancora peggio, autorizzati a immortalare (rendere immortale, da “immortalis”, in – mortalis, non mortale) qualsiasi forma, spazio, attimo, segreto, vendetta, ricordo, oggetto che ci capiti sotto mano. Lo priviamo dell’anima, lo incassiamo in questo feretro di contenuti binari e ce ne dimentichiamo.
Riempiamo gli archivi digitali di ricordi di cui spesso perdiamo memoria eppure, paradosso dei paradossi, sono lì proprio per farci rimembrare. Dovreste provare a scorrere le immagini del vostro telefono per capire se ogni singola foto, da quella fatta in montagna dove puntualmente si piazza davanti all’obbiettivo, quasi facendolo apposta, un individuo di passaggio che non si sposta fin quando, avviliti, vi arrendete ad una foto con un estraneo, a quella scattata al cartello del menù di quel ristorante in cui siete stati la scorsa estate e che poi vi siete dimenticati di eliminare. Lo so che avete preso il telefono in mano e vi siete messi a controllare! E spero che vi abbia anche fatto riflettere su una piccola, insignificante ma rilevante cosa. Che cosa voglio ricordare, veramente? Sono sicuro di voler posare, in futuro, gli occhi su questo contenuto che in realtà mi dà fastidio, ma che tengo per… non lo so nemmeno io perché lo tengo ancora lì.
Perché ora vi porto con me alla scoperta di una memoria che io preferisco trasportare leggera, come uno zaino che ha dentro l’essenziale e di cui so dove ho posto esattamente le cose, le cose a me più care e che proprio non voglio dimenticare. Di recente ho terminato una lettura che mi ha stravolto il corredo esistenziale, fatto di ricordi vecchi e decrepiti, di rado indossati, tenuti in un armadio avendo cura di non tirarli mai fuori perché terribili, ma che sono riposti lì per un horror vacui che temo, per la paura di non riuscire a vivere senza uno spazio libero molestato dal dolce non pensare a nulla. Anche questo è un paradosso. Proprio non posso permettermi di non pensare o di non ricordare nulla, anche se la mia memoria, come inizialmente accennato, talvolta si prende gioco di me rimuovendo dai miei pensieri episodi di frivolezza compulsiva e attimi di piacevole arrendevolezza.
“Ricordati di me”, del Filosofo e Tanatologo Davide Sisto, analizza il mondo del web come fosse un enorme camposanto virtuale, destinato a incubare fantasmi di persone che, oggettivamente, prima o dopo (e come del resto ognuno di noi è universalmente portato) moriranno. Non farò la descrizione del testo, che per me ha significato il restiling del mio io digitale e del mio modo di rapportarmi alla tecnologia e ai miei ricordi, bensì mi concentrerò su un film, citato nel testo, che ha, parimenti, la forza di far riflettere il lettore sulla memoria e su ciò che vorremmo che gli altri ricordassero di noi. Noi siamo archivi di memoria, siamo contenitori di carne che quotidianamente vagano per la città con mille pensieri, ricordi, altrettante immagini, relazioni e gesti riposti con cura, ma senza assenso, in ogni minuscolo e recondito angolo delle nostre membra. “The final cut” non è solo il dodicesimo album dei Pink Floyd, bensì il titolo di un film del 2004 e indecentemente attuale. Il protagonista è “un becchino, o un prete, un imbalsamatore. O forse tutti insieme”, così viene descritto in una scena, ovvero colui che è addetto al taglio (the cut) di sezioni di vita contenute entro la scatola nera innestata nel cervello sin da neonati e che per tutta la vita li accompagna. Il motivo è semplice: in questa realtà fittizia, nel giorno del commiato, viene proposto un “Rememory”, un filmato dove la vita del defunto viene ricostruita tagliando – con l’aiuto di un addetto specializzato – alcune porzioni di vita, come se si utilizzasse una ghigliottina che, con un taglio netto e preciso, stacca una parte dal corpo. Un’esistenza peraltro registrata oggettivamente in ogni singolo momento della quotidianità. Dal lavarsi i denti al camminare per andare al supermercato, dal tagliare l’erba a farsi un bagno in mare… Sì, insomma, rimembranze di cui si può tranquillamente fare a meno, ma che qui, con la scatola nera, vengono comunque immortalate. In modo assurdo, non si ha nemmeno bisogno di incarcerare le immagini in un telefono cellulare. C’è già il cervello piuttosto pieno di file e di contenuti da ricordare una pentola a pressione destinata di lì a poco ad esplodere. Il lato positivo è il poter rivedere la propria vita, ri-viverla (che assurdità) in modo oggettivo, essendo ogni emozione e pensiero omessi in questa registrazione per come i fatti sono dunque oggettivamente accaduti. Puoi rivedere il momento in cui vieni al mondo, l’attimo in cui ti sei innamorato per la prima volta o, addirittura, quella volta in cui sei caduto dalle scale spaccandoti il braccio. Le emozioni sono però soffocate e trascurate, mostrando solo una verità sterile di sfumature e dunque relegata a mera scatola di registrazione. L’individuo viene posto sullo stesso piano di un file scaricabile su un portatile: un corpo che respira, di carne, rimpicciolito nelle dimensioni di un microbo, vagante nell’etere. E l’assurdità sta nel mezzo, perché il filmato per il Rememory viene confezionato secondo le disposizioni dei dolenti che ne richiedono la costruzione e, questo, a discapito di una parte di verità, anche la più brutale e disdicevole, seppur vera. In tal modo, a pensarci bene, appariremmo al mondo, tutti, nella nostra veste migliore, intonsa, senza peccato alcuno. Ed è un po’ quel che accade quando ci presentiamo agli altri sui social, attraverso particolari fotografici in cui il contesto viene escluso, proponendo una facciata perfetta e invidiabile. La mia riflessione si è posata anche sul mio modo di voler ricordare. Voglio davvero ricordare ogni singolo attimo, ogni singolo particolare? Creare macerie di reminescenze fastidiose come una scottatura fortuita? Voglio davvero gestire tutto questo materiale sino a farlo sviluppare come un feto le cui sembianze mi ricordano più un automa? Perché ci sono cose che io so di non voler ricordare, cose che involontariamente e volontariamente dimentico e che non accetto possano far ritorno nei miei pensieri. Voglio pensare di essere io, solo io, il feretro della mia memoria, preferisco selezionare da me le immagini che custodisco gelosamente nella mia mente. Ma, soprattutto, nel mio telefono. Il processo di eliminazione di video, immagini, audio e vocali è già iniziato e, lo ammetto, ho ricominciato a vivere per il gusto genuino di farlo, non per immortalare spezzoni da pubblicare in bacheca.
Beatrice Roncato Villa