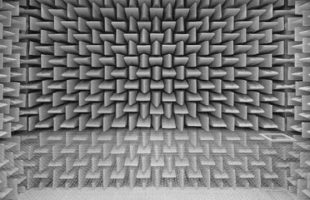Da quando ne ho memoria, ogni Estate si è presentata a me e alla mia famiglia nella sua più presuntuosa veste tanatocratica. Sì, proprio nel periodo dell’anno in cui la spensieratezza dovrebbe spogliarsi di quel mantello pesante ed un poco impolverato della primavera e, ancor prima, dei mesi più grigi e pietrificanti. Letizia che si spoglia sempre a metà o che, anzi, non si denuda per nulla. Nel suo essere arida e asfissiante, l’estate ha portato sempre con sé un velo nero, un drappo vittoriano che non riserva accoglienza all’aurora estiva facendo rimanere sepolte certe melodie che un tempo segnavano i mesi più placidi. L’estate è una spugna che, se la spremo, fa uscire tutto ciò che ho trattenuto e che in cuor mio trattengo appena iniziano i primi aliti di calura che ti appiccicano la pelle agli abiti dandoti quel senso disagevole e poco simpatico tipico di una umidità capricciosa.
Orbene, preferisco da sempre l’inverno, più avaro di lutti – ma questo è soggettivo – e più conforme alla mia natura, dove tutto sembra assopito nel tepore di un maglione che ti culla quando fuori il vento, troppo violento e freddo, ti prende a schiaffi, ma gentilmente, senza chiedere scusa.
Da quando sono al mondo, al mio fianco ho sempre avuto un amico a 4 zampe. Sempre. Che fosse il criceto Ozzy, o le tartarughe, o il topino ballerino Pepe, ma, soprattutto, i miei due primi cani Lilly e Franz, il mio legame con creature altre non umane e, proprio per questo, innocenti, è sempre stato costante. Altresì, fossero i gatti di campagna di mio zio, o i gatti incontrati nelle località estive, ho adottato con piacere e dispiacere certe bestiole di cui mi chiedo se l’esistenza sia ancora testimone di questa terra o se siano finiti sotto mani sbagliate, prive di civiltà.
Certo che no, non sono solo animali. Certo che no, non sono stati gli unici lutti vissuti nei giorni d’estate, quando c’è sempre la speranza che il sole porti con sé giorni migliori, scarnificatori dell’assopimento invernale. Pochi giorni fa, la Signora in nero è venuta a bussare alla nostra porta, portando via con sé un caro Amico. Ma una parentesi ai miei animali, perché miei furono e io di loro fui, la dedico con il cuore aperto e, talvolta, ancora sanguinante.
Negli ultimi decenni stiamo assistendo ad un incremento lapalissiano di animali da compagnia nelle famiglie di tutto il mondo. Seppur siano compagni e testimoni di una vita, il loro lutto non viene riconosciuto o, perlomeno, non totalmente e quanto si vorrebbe. Loro ci sono, quando hai il morale sepolto sotto terra per una giornata non proprio appagante, quando torni a casa e li trovi lì con quella coda che a volte sembra l’elica di un elicottero pronta a decollare, quando mangi e te li trovi davanti con gli occhi imploranti tipici di chi non mangia da… 10 secondi. E condividi dunque il pasto, allungando – togliendoti di bocca – l’ultimo boccone mandato ovviamente di traverso, ma poco importa. Loro sono felici così, per così poco. Loro sono lì, incapaci di parlare, ma con così tanto da esprimere. Che so, magari nella loro creazione, la parola non gli fu conferita per non far vergognare noi, umani talvolta incompetenti nel gestire e nel dosare parole di cui non siamo degni. Eppure, a volte, essi sono il primo lutto che i bambini vivono nel corso della loro vita, il primo lutto di chi magari non ha trovato mai un affetto tanto generoso e devoto da parte di altri esseri umani. Ma la morte di un compagno a quattro zampe è sempre un dolore violento e dubbioso. Il mio primo cane fu una maltesina, color neve, grande poco più di un pezzo di pane. Era Natale ed i miei la nascosero entro una confezione di cartone del pandoro (ovviamente bucherellata) perché io il pandoro lo preferisco al panettone. Ma questa è un’altra storia. A dir la verità il primo impatto che ebbi fu di incapacità diffusa nel comprendere in qual modo comportarmi di fronte ad un’anima priva di parola, così piccola che con un soffio avrebbe potuto scomparire come una bolla di sapone. Ci fu compagna sino ai miei 18 anni, lei invecchiava ed io crescevo insieme a lei, sempre presente nelle cene di famiglia, alle feste, alle visite alla nonna con cui, in particolare, passò i mesi più acuti in cui iniziò a perdere la vista e la capacità di riconoscere me e la mia famiglia. Ed io soffrivo amaramente, perché non essere riconosciuti da lei era per me sintomo di fallimento, di incapacità nel dimostrarle tutto l’amore che provavo per quei suoi ciuffi di pelo sempre arruffati: c’era sempre un po’ di noia nel pettinarli, ma la sua forma in tal modo pareva quella di un piccolo orsetto e io la adoravo così. La malattia, gemella alla vecchiaia, la consumò sino a renderla uno scricciolo pelle ed ossa incapace di vedere e di camminare per la casa, dove i suoi passi erano ormai stampati sul pavimento. Ho un senso di colpa che mi rode. Quando morì, io non ero presente a casa. E l’aver perso quella sua partenza senza ritorno, a distanza di anni ogni tanto riaffiora nella mia mente come quelle piantine che, nella convinzione di averle falciate via dal prato, ricompaiono vendicative sbucando dove meno te lo aspetti. Se ne andò, piccola come quando me la trovai dentro la scatola del pandoro 15 anni prima. Fu un dono nudo e, inizialmente, insignificante per me: non avevo ancora consapevolezza di ciò che morte e morire fossero intorno a me. Un dono, quello della cura e dell’empatia – seppur nella disperazione – che dovetti accogliere alcuni anni dopo con l’altro nostro cane di famiglia, Franz.
Pastore tedesco fabbricatore seriale di tonnellate di pelo sparse per la casa, e di cui a distanza di 11 anni troviamo ancora qualche rimasuglio sepolto negli angoli più impervi, era una creatura tanto dolce ed incapace di mordere anche solo per gioco. Mantenne sempre quell’odore tipico dei cuccioli, dolciastro e di buono, su quella testa morbida con le orecchie sempre dritte e che stringevo tra le mani. Soleva dormire nel corridoio dell’entrata, un angolo fresco della casa: disinteressato al fatto che vi fosse il via vai dei passi nostri, lui rimaneva lì. Ci sono abitudini e gesti che con il proprio cane si costruiscono negli anni. Quando dormiva, amavo disturbarlo: acquattandomi al fianco suo, iniziavo a soffiargli sul musetto, delicatamente, ma con l’intento di averne una reazione. Il suo lamento, un verso che ancora a pensarci mi fa sorridere, era accompagnato da uno strofinamento delle zampe anteriori sul muso, in segno di fastidio. Non passava molto tempo perché si girasse a pancia in su con la bocca semi aperta e la lingua a penzoloni, in segno di “grattami e non recarmi disturbo”. Quanti baci gli ho dato in testa, quante volte l’ho sgridato per avermi rubato un pupazzo per mutilarlo incresciosamente e lasciarne qualche pezzo per la casa. Li scoprivo così, io, i suoi omicidi nei confronti dei miei malcapitati peluches: teste mordicchiate, ancora pregne di saliva e arti scomparsi finiti direttamente nel suo stomaco. Le arrabbiature le ricordo tutte, certamente i suoi occhi potevano sciogliere anche un cuore di pietra. Dunque, i nostri battibecchi duravano un batter d’occhio, nulla più.
Ma fu con lui che ebbi modo di scoprire, mio malgrado, sin dove si possa spingere la più becera forma di cattiveria umana. La sua perdita fu una scissione, tra un prima degno di forme smussate di benevolenza e di innocenza ed un mondo a me conosciuto solo nei peggiori incubi, o in qualche pellicola. Franz venne avvelenato. Per lo meno, questo è ciò di cui siamo convinti e, si sa, le convinzioni sono dure a morire, molto spesso immortali e perciò spietate. Se ne andò in un pomeriggio di giugno, giusto il tempo di attendere il ritorno di mio padre a casa. Non resse, ma attese che fossimo tutti li, intorno a lui. Ed io il tonfo sul pavimento, giuro, posso sentirlo ancora. Un rumore sordo, di ferro, un rumore che non voleva disturbare, ma capace di svegliare anche la terra. Il perché di quel gesto non lo sapemmo, nè lo sapremo mai. Se ne andò in un giorno d’estate, tra l’incredulità e l’incapacità di comprendere cosa si provi a giocare a fare Dio con le vite degli altri.
Non passarono più di sei mesi che in famiglia arrivò una peste sotto forma di bassotto: una razza a parte, tanto orgogliosa quanto amabile, il piccolo lord della casa. Dovete sapere che il piccolo tornado è stato ed è tuttora un supporto alle perdite familiari che nemmeno decenni di terapie potrebbero tamponare. Perché era lì con noi, fuori dal parcheggio dell’ospedale di Frosinone, durante il ricovero di mio zio; era lì, sotto il feretro, durante la veglia in casa di mia nonna e, sì, era lì anche quando la mia nonna materna viveva le sue ultime due settimane a casa nostra, sedendosi sotto il letto dell’Ulss, fissandola e facendo cenno di salire, senza poter accogliere questa sua richiesta muta. Era con me al parcheggio dell’obitorio, che grattava alla porta dove al di là vi era il nostro Amico di famiglia, passato all’Oltre due giorni prima. Abbiamo passato silenzi e sguardi oltre ogni possibilità umana, tutt’ora mi chiedo come sia possibile che questa creatura riesca a captare dolori e sentimenti che gli stessi umani sono incapaci di decifrare. E questo pensiero, questa confidenza che si suol fare solo a chi ha forza per comprendere e maestria nell’accogliere, lo dedico ai miei Compagni del Corso sull’Addio all’animale domestico.
A Frida, a Mirtillo, ad Alec, a Rose e Gioia, a Bignè, Blu e Mirtillo, a Connie Love, a Peggy, e alle mascotte dolcissime Zara e Franco e ai loro umani Marco, Flavia, Leonardo, Federica, Chiara, Maria Angela, Pietro, Barbara e alla dolce Sara. Capaci di cogliere e di accogliere l’anima di chi parola non ha.
Beatrice Roncato Villa