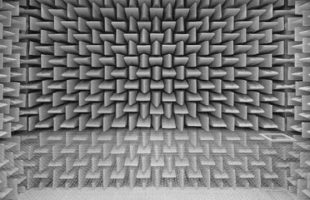Quando sei un infante, poco importa chi siano le persone che incontri per strada mentre cammini con i tuoi genitori. A dir la verità, provi anche un certo fastidio nel doverti fermare, dover dire il tuo nome a questi estranei di cui ti chiedi che interesse abbiano a sapere chi tu sia e sentire discorsi che non riguardino certe misere, ma così appaganti, semplicità. Come l’umiltà di un gelato, o di un palloncino di quelli che il vecchio signore, davanti al Pedrocchi, vestito da pagliaccio senza parrucca soleva creare nelle più svariate forme: fosse il cane, che cane non sembrava, o un fiore prostrato, che di un fiore poco aveva la forma, o una spada che non avrebbe fatto paura nemmeno a una pietra, tra viandanti accidentali e ambulanti capaci di venderti l’aria che respiri. Eppure, quelle persone ti hanno vista crescere per poi non riconoscerti nel sempre troppo fugace passaggio davanti alle loro vetrine. Ogni via della città possiede un pezzo di me, come io ne possiedo ogni singolo sanpietrino, testimone di anni e anni di passi, da quelli più leggiadri a quelli più pesanti ed arrabbiati; testimone delle mie forme e delle mie metamorfosi per cui le impronte del mio piede ora ne calpesta due, e non più uno, a misura di bambino. La città finisce sempre col possederti, si nutre di tutti i tuoi ricordi legati ad ogni via ed angolo, anche quelli più nascosti e dimenticati, quelli sepolti sotto tre dita di polvere che si rianimano al passaggio di un soffio di vento. Molte sono le piccole botteghe scomparse insieme ai loro vecchi proprietari, generazioni di uomini le cui mani potevano raccontarne il mestiere, senza nulla chiedere: i rudi macellai, dietro quei banconi osceni che non ho mai sopportato, sempre con la traversa sporca di macchie rapprese e compiaciute di aver infamato quel candore, che non provavano terrore nello sporcarsi le dita tra le viscere; i pescivendoli con il loro acquario sotto Palazzo della Ragione, dimora temporanea di anguille sonnacchiose e attorcigliate, e quelle casse di legno, e i baccalà, mummie rinsecchite impilate nei cesti di vimini. L’emporio dei profumi, eccolo lì, con le sue mensole a specchio impolverate, e la commessa dalle dita color perla tanto erano lisce e immacolate, sempre ben curate, laccate, impaurite nel maneggiare quelle confezioni meticolosamente esposte per far gola ai più sopraffini gusti di Signora. Di molte botteghe non rimane nulla. Le insegne talvolta scrostate lasciano intendere il passaggio di qualcun altro, che per anni vi ha dimorato per qualche ora prima del tanto atteso ritorno a casa.
Nel tempo la città ha iniziato a riempirsi di rughe di negozi vecchi e dalle insegne sbiadite, con quei caratteri deliziosamente retrò. Botteghe chiuse, quasi fossero portatrici di qualche convulso peccato, per lasciare il trono a ristoranti e fast food a “buon” mercato le cui insegne, eccessivamente luminose per attirare, come insetti, gli occhi che han visto poche primavere, altro non sono che la promessa di qualche ora di trastullo e di chiacchiere, a caro prezzo. Ma riemergono fantasmi rigurgitati dalle intercapedini di quei palazzi stanchi dei secoli, delle genti e delle chirurgie per rimodernarne l’aspetto. Come ogni cosa che il tempo tende a portar via con sé, anche gli inquilini delle botteghe vengono strappati dalle loro abitudini, che siano esse clienti abituali o il semplice inserimento della chiave nella toppa delle porte in ferro e vetro, per aprire un negozio rimasto a bocca asciutta nei giorni di luglio. Le nostre abitudini in fondo ci plasmano, facendoci adeguare a ritmi scomodi che, nel loro disagio, ci rendono schiavi, in alternanze sadomasochistiche. Non molto distante dal negozio di cappelli, dalle bombette ai cilindri, dai bastoni da passeggio alle borse in pelle di eccelsa qualità, la piccola bottega di un gioielliere, incastonato tra due negozi storici. Quel piccolo fondaco, tanto elegante e raffinato, presenta ancora una vetrina piccina, ma estremamente vanitosa: le mensoline adornate da velluto blu oltremare sono sempre state stanze da veglia di gioie e di gingilli preziosi, nutrimento essenziale per certe signore altolocate, ma di poco interesse per i più frettolosi e assorti nel rimuginio di pensieri insaziabili. Ed il suo commesso, sempre presente più davanti alla vetrina che dietro al bancone, era un incontro a me consueto, nonostante lui non riconoscesse in me quella creaturina, nipote della signora che a pochi passi dimorava nelle piazze, un po’ imbronciata e lamentosa.
L’ho sempre osservato, senza però farmi riconoscere. Più per negligenza nel non voler rispondere a domande scomode che per ostilità. Con il suo sigaro, amato compagno di pause che lo soffocavano, spezzandolo sempre a metà, il Signor Adriano ha costruito un compromesso in questi anni, che fosse primavera o estate, autunno o inverno. Quelle campane di fumo in cui veniva avvolto sembrava non volessero abbandonarlo nemmeno quando rientrava in negozio, ma rimanevano lì, come uno spettro scocciato nell’esser lasciato davanti alla vetrina, per di più scomposto dal gesto che si fa per spazzare via le nuvole prodotte dall’espirazione di un buon Toscano. Pareva che quel sigaro avesse trovato una conca, forse predisposta dalla nascita, tra il suo indice ed il medio i quali con mestizia e con un gioco tra dita nel passaggio tra l’indice ed il pollice, spegnevano con la velocità di un picchio il mozzicone che, nell’asfissia, rimarcava quell’odore tipico e troppo intenso per me, da cui un piccolo alito di fumo si strozzava. I suoi capelli canuti, che da quando ho memoria ricordo così, cortesemente tirati indietro e imbrillantinati, mi hanno sempre ricordato gentiluomini di tempi che furono, a me noti solo per certi nastri in bianco e nero. Con il tempo i volti si dissolvono, si consumano, marcati dall’insofferenza nel prendersi cura di un’attività soffocata da altri negozi che, seppur non di concorrenza, si propagano come metastasi tra i palazzi accatastati. Un’inquietudine che inizia a riflettersi sulle movenze del corpo, più incurvato, meno interessato alla visita di qualche potenziale cliente. E chi può sapere mai che, scegliendo di fare una strada anzichè un’altra, perché sì quella strada la preferisco, è più breve e più luminosa, o semplicemente perché mi va di farla mi sarei imbattuta, già da lontano, in uno scontro tra i miei occhi e due cartelli bianchi su quella saracinesca abbassata? Come per ogni cosa turbante, ho puntato i piedi, mi son fermata, e per alcuni secondi mi sono rifiutata di avvicinarmi a quella serranda. Eh sì, proprio quella della gioielleria. La breve pausa fu ripagata con una lettura ben poco accogliente, ma veritiera. Proprio l’epigrafe del Signor Adriano. Ma no, ma dai. Ma non è vero! A conferma di questa logica di epitaffi sempre scomodi, ma necessari, il secondo foglio affisso era dedicato ad una serie di ringraziamenti di cura, a quanto pare mi ero perduta questa parentesi terribile del Signor A., ma non avevo riconosciuto in lui ed in quel suo piegamento alla vita quel male ed il suo sottile terrore. E sì che di quelle serrande abbassate, Padova è rigurgitante.
Dal piccolo orologiaio claustrofobico di Piazza delle Erbe, alla bottega del cuoio di piazza dei Signori, al riparatore di occhiali nelle piazze universitarie, sino ad una merceria di Canton del Gallo: sono tutti cenotafi di mestieri ormai riposti nel dimenticatoio, che muoiono insieme ai loro “padroni” perché di altre mani non ne vogliono sapere. Molte memorie se ne vanno con la morte di coloro che hanno lasciato un pezzo di storia tra le mura e i vicoli di una città che va a letto sempre troppo presto per non perdersi mai la nascita di ogni aurora. Ma il fumo dei braceri per cuocere le castagne in inverno è un piccolo piacere che, in queste piazze, non ci si permetterebbe mai di prendere a schiaffi per scemarlo nel vuoto, così come il fumo che danza tra le bancarelle dei dolciumi a Natale, con il profumo delle mandorle caramellate che ti annegano il cuore, o la vanità dei vapori del carro dei folpetti davanti alla Torre degli Anziani. In fondo di queste nebbie, che d’inverno sembrano tanto spettrali, non potrei mai fare a meno: è come se fossero il passaggio armonico, mai tetro, di fantasmi che si consumano.
Beatrice Roncato Villa