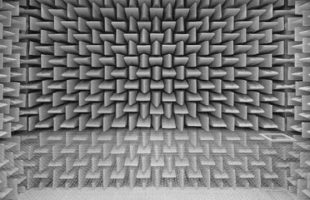Inizia oggi la collaborazione con la nostra testata di Beatrice Roncato Villa cui, anche a nome di tutta la Redazione, porgo il più caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro. Beatrice gestirà una rubrica settimanale, “Spazi di Riflessione”, nella quale affronterà argomenti di sicuro interesse per la crescita professionale e culturale degli Operatori Funerari italiani.
Nata a Padova, dopo il diploma di Maestro d’Arte ha conseguito presso l’Università degli Studi di Padova la laurea triennale in Scienze Sociologiche con una tesi sulla Morte nell’Islam, proseguendo poi il proprio percorso con la Laurea Specialistica in Sociologia e Ricerca Sociale. Nel 2018 ha scelto la strada che le ha cambiato la vita: il corso di Formazione Specialistica in Tanatoestetica, presso la Scuola Superiore di Formazione per la Funeraria, e, pochi mesi dopo, quello sul Cerimoniere Funebre. Attualmente frequenta il Master in “Death Studies & the End of Life” presso l’Università di Padova, lavorando al contempo come Tanatoesteta, professione che porta avanti con il cuore.
Carmelo Pezzino
Direttore TGFuneral24
È un pomeriggio di pioggia, uno di quelli in cui l’umidità ti ammanta tanto da volerti togliere la pelle come fosse un cappotto scomodo e inospitale. E allora, per rincuorarti, ti fermi. Tra le innumerevoli possibilità e sollecitazioni, ti fermi. Cerchi dunque un posto comodo nel mondo, senza troppe pretese, ma senza nemmeno accontentarti di un qualsiasi passatempo.
Da un breve passo sentito a lezione cerchi disperatamente un collegamento con un libro chiuso da poco, e di cui provi nostalgia, nonostante quei personaggi, oltre all’anima di carta, in realtà di ossa e di carne non ne abbiano. Il passo era di Omero. Un passo dove, a tu per tu, inizia a raccontarti tra le mura di casa come, sin dai testi più antichi, nell’Odissea il senso della morte e del morire sia stato rappresentato attraverso le allegorie del sonno eterno e delle ombre.
Questa idea del sonno eterno, non lo nascondo, mi ha sempre affascinata, ma al contempo avvolta nell’ansia. Sarà anche per quello che soffro d’insonnia. Del resto, la Morte cos’è, se non un eterno riposo? Perlomeno, allegoricamente, si ritiene giustificato usare termini impropri per evitare a tutti i costi di nominarla attraverso attributi meno severi, magari più poetici e melodici, e che in realtà con la Morte non c’entrano alcunché. Si parla di “bella morte” dei giovani in battaglia, caratterizzante cioè la società omerica per la quale un corpo giovane, seppur adornato di ferite inflitte in battaglia, riesce in qualche modo a scongiurare il tramonto dell’esistenza. Il tramonto, invero, legato ad un fine vita in carni logore e consunte dal tempo. Come si deduce in Pindaro (Pitica, VIII, vv. 95-96), invece, gli uomini sono “Esseri della durata d’un giorno. Che cosa siamo? Che cosa non siamo? Sogno d’un’ombra l’uomo”. Ed è qui che trovo un collegamento ancora più incalzante con la contemporaneità.
Nel 1866, un bel po’ di tempo dopo, un classico della letteratura, “La morte di Ivàn Il’Ic” (1866), continua il tema della morte attraverso le parole di Lev Tolstoj. Non basterebbe una vita per trovare collegamenti, cordoni ombelicali letterari in merito a questo tema. Ma sono sempre stata convinta che i testi classici possano insegnarci molto su ciò che abbiamo perduto nella strada del tempo, dei secoli e dei millenni, e di come molti fantasmi della letteratura continuino a ripresentarsi seppur in forme altre, soprattutto per quanto concerne la morte.
Ivàn Il’Ic, medio borghese membro della Corte d’Appello, è un uomo inizialmente (e tendenzialmente) soddisfatto della propria esistenza. Si, una vita vissuta “come si deve” che un giorno, improvvisamente, viene compromessa dal dolore e dalla malattia. Proprio il dolore è il protagonista del testo: il dolore fisico, certo, ma soprattutto il dolore nel rapporto con il proprio corpo, incapace di seguire i ritmi abitudinali di una vita vissuta tra la Corte d’Appello, la famiglia e gli amici, il whist e la percezione di sentire il corpo stesso come un peso per sé stessi, ma soprattutto per gli altri. Un corpo che si preferisce non guardare, ma coprire, lontano dagli specchi, indiscreti, ma sempre fedeli. Un corpo che da solo non si sostiene, che si stenta a riconoscere e che necessita di mani altrui, di forza d’altri, per essere accudito e gestito dignitosamente, se possibile. Il corpo che è nostro biglietto da visita al mondo. E che, improvvisamente, si macera come carta bagnata.
Non solo: evidente è l’incapacità di decodificare il linguaggio medico, troppo tecnico e assolutamente privo di empatia, la tristezza del mondo alla notizia della prognosi infausta che in realtà non verrà mai detta ad Ivàn. Ed il ritornare alle memorie passate per ritrovarvi l’innocenza e la semplicità della vita da fanciulli. Qui troviamo anche la congiura del silenzio che tormenta la figura dei pazienti, dei malati e dei morenti nella contemporaneità. Il pensiero di Ivan Il’Ic è un fluire di rabbia, di incomprensione, di perdita di affetti appesi al filo del proprio respiro; basti pensare ai brevi passi, chiari e concisi, che vengono proposti nel testo: “Il dolore continuava a straziarlo […]. Era solo ad accorgersene, tutti quelli che erano intorno non capivano o non volevano capire, credevano che tutto andasse secondo il solito […]. Quel che più lo affliggeva, era che le persone di casa provavan fastidio di vederlo sempre ingrugnato, pieno di esigenze, quasi che di star male ci avesse colpa lui”.
Penso siano parole più che mai annoverabili ai giorni odierni in cui abbiamo in qualche modo dimenticato che un corpo malato, o “diversamente” sano, in realtà nasconde un individuo unico ed insostituibile. Non è vero, forse, che il pensiero comune attribuisca agli infermi l’incapacità di stare al passo con i tempi, in un circuito che vuole le persone sempre produttive, possibilmente belle, prestanti e senza acciacchi, rincorse dal tempo? O forse siamo noi a rincorrere lui? Ecco, quindi, come questo pensiero si discosta da quello della bella morte omerica.
Atul Gawande (2016), in un testo potente quanto crudo, sostiene una verità antica quanto il pensiero cullato in Tolstoj: “Nelle società contemporanee, la vecchiaia e l’infermità hanno smesso di costituire una responsabilità multi generazionale condivisa, per acquisire lo status di condizione più o meno privata: sono diventate realtà da vivere in gran parte soli, oppure con l’aiuto di medici e istituzioni…”.
Vorrei quindi che noi tutti ci soffermassimo sulla pazienza, quella che siamo capaci di offrire, di sopportare o di elemosinare, quando in realtà siamo troppo presi dal scorrere frenetico di una giornata per cui 24 ore non bastano mai. La pazienza di un silenzio, dell’esserci, di essere presenti ascoltando senza dare colpa alcuna a chi le forze le ha perse per strada con il fluire del tempo. E penso che questa emergenza sanitaria, di cui temiamo lo spettro di ritorno, ci abbia in qualche modo educati alla nostra fragilità, alla fragilità cristallina dei nostri corpi che altro non sono che involucri di carne sottile e ossa delicate. Come fossero origami.
Dedico questo breve articolo anche a mia nonna, che se ne andò via in un giorno di giugno tra il caldo, l’odore dei medicinali, dei disinfettanti aperti e delle pietanze rese quasi pulviscolo. Una richiesta di perdono, per non aver accolto in pieno il dolore che provava in quel contenitore, stanco e fragile, per cui potevo riconoscere le vene quanto trasparenti erano le carni del suo corpo. Per non averla ascoltata abbastanza e per aver vissuto con lei più silenzi che parole.
Beatrice Roncato Villa