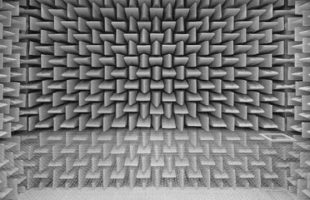Ci ho messo un po’ per dare un titolo a questo pensiero. Io che ai pensieri, solitamente, non riconosco né un nome né una forma. Fluttuano, rimbalzano, impazziscono, da un momento all’altro si confondono ed io non riesco a seguirli, perdo la strada, distrattamente. Perché talvolta all’insensatezza, alla inconcludenza e al senso di incredulità non riesco a dare una catalogazione. Pochi giorni fa, un messaggio. Nemmeno una chiamata, un messaggio. Solitamente, il mezzo attraverso il quale si danno notizie brevi, concise, di avviso e di conferma. O di negazione. In questo caso, oserei dire, di negazione, concisa, spietata, incapace. Enrico è morto.
Negata la delicatezza nell’annunciarne la Morte, negata la speranza che essa possa entrare in punta di piedi, e non rozza, nel suo spalancare la porta per mostrarsi. Un avviso di morte che, suppongo simile a quelli di trincea, effettivamente mi ha lasciato un buco nello stomaco che potrei giurare di vedere se mi guardassi allo specchio. Più che una raffica di proiettili, è stata una cannonata. L’incredulità si è congiunta alla spietatezza di quelle tre parole gettate come si fa con le sementi, peccatrici di insensibilità e di non volersi dare noia nello sprecare una parola di più. Una parola scritta, peraltro. Perché, si sa, una telefonata sarebbe stata troppo imbarazzante: le parole mancano sempre. Non si sa mai cosa dire in questi casi, come dirlo, se sia effettivamente necessario parlare o se sia meglio stare in silenzio, forma fantasma di comunicazione educata. Perché se a morire, poi, è un ragazzo giovane, per una malattia che falcia solo al sentirne il nome, allora è pure peggio. Perché non reggi il confronto con una natura malevola incapace di mantenere fede ai propri schemi, di un Chronos passato decisamente troppo presto a riscattare il proprio tributo. Ma il silenzio sa anche essere gladiatore. E io negli anni ho imparato a schivarlo, perché per me è diventato troppo impegnativo. Ho imparato, ma sarebbe più corretto ammettere che sto imparando, a non trattenerlo qui, in gola, qualora mai avessi l’impeto di rigurgitare fuori un vezzo di parole, se spingono impazzite come api chiuse in una gabbia da cui vogliono evadere.
Oggi è un mese che se n’è andato. Ed io, quel messaggio, ce l’ho ancora nel telefono, come per ricordarmi ancora una volta che i piani quotidiani vanno calibrati come si fa con il respiro: piano, secondo per secondo, senza proiezioni distratte e distanti dal qui ed ora. Enrico lo conobbi entro le mura di facoltà, collega di studi del mio compagno, e lo incrociavo ogni qualvolta mi capitasse di allungare la strada del ritorno verso casa andando in quelle aule, brulicanti di studenti in solitaria o ammassati a generare tutt’altro che la preparazione per l’esame del giorno seguente. Erano però sempre volti di speranza, di euforia contagiosa nel manicomio universitario fatto di scadenze, dispense, bocciature, fotocopie clandestine e macchinette del caffè sempre affollate, nonostante la qualità fosse eccelsa come quella di un sorso d’acqua sporca raccolto da una pozzanghera dopo una giornata di pioggia estiva. C’era molta spensieratezza, le pause per una sigaretta tra un capitolo e un altro, e qualche commento sulle uniche ragazze della facoltà di Ingegneria che Enrico frequentava. Io quella spensieratezza, giuro, la potrei ricordare ancora se solo mi fermassi un attimo. Ma è uno di quei pensieri che tendo ad evitare, poiché ho sempre reso mia – custodendola gelosamente – quella frase di Wilde “colui che si volge a guardare il suo passato, non merita di avere futuro avanti a sè”. Col senno di poi, però, un’analisi più accorta sorge spontanea: un individuo passa la propria vita a crearsi un futuro, a plasmarlo nel modo più saggio e conveniente, quando gli riesce, tra incidenti di percorso e aspettative che con il tempo appaiono meno titaniche. Dunque, insegue la propria vita abitando il mondo e talvolta facendo molti sacrifici: e per sacrificio intendo anche la semplice e mancata decisione di “non uscire questa sera con gli amici perché devo studiare per l’esame di domani”. Le rinunce in gioventù costano sempre una fatica doppia: la fatica del qui ed ora ed il rammarico, in vecchiaia, di non aver osato quando si aveva l’energia di un plotone. Questo pensiero mi bussa alla porta molto spesso, tendente come sono a riflettere a lungo per poi pentirmi, comunque, di certe decisioni assunte. Inoltre, lo so per certo, se avessi modo e potere di sapere cosa accadrà da qui a vent’anni, non sbircerei nemmeno se mi sezionassero l’anima.
E come poteva Enrico sapere che, a due anni dalla laurea, in modo fortuito e irruento, quella malattia gli avrebbe ammaliato il corpo sino a farlo mutare in un esile burattino? Perché ricordo bene, sapete, il “prima” ed il “dopo”. Di quel corpo un po’ robusto, come fosse una roccia di montagna su cui trovare ristoro dopo una lunga camminata, non riconobbi la forma la prima volta che andrai a trovarlo in ospedale. Non lo vidi in piedi se non per una manciata di minuti: il tempo di fare un giro su sé stesso e tornare, in modo obbediente, su quel letto. Giusto il tempo di scorgerne le forme, esili e frangibili, sotto una vestaglia troppo grande per lui da apparire di molte taglie più grande. Era come se avesse perso la sua ombra. Non la notai, nonostante la luce entrasse, un poco introversa, ma misericordiosa, da quelle lapidi di vetro della sua stanza, finestre appannate dai detergenti ripuliti in modo poco cortese. La struttura ospedaliera in cui era ospitato, un enorme utero in cemento armato e vetrate troppo fastidiose per gli occhi più delicati, non suscitava in me quella sensazione di “normalità” per cui lì, in quell’ospedale, Enrico fosse nel posto giusto. Non doveva esserci. Doveva essere altrove, magari a godersi una passeggiata con la sua compagna o a giocare al pc come gli piaceva fare.
Non vi nascondo che lì per lì la sensazione sulla soglia della stanza, quella sensazione maledetta che si prova nel trovare un conoscente in un luogo a noi non familiare, mi stravolse le viscere facendomi sentire in trappola, con la conseguente necessità di scappare, di correre via alla velocità di un fulmine. Sapevo che sarei entrata, giusto un po’, per sapere come stesse, nonostante la mia non fosse una confidenza tale da poterlo avvolgere in un abbraccio. Sapevo anche che, dopo quella visita, sarei uscita in poco tempo. Mentre il suo corpo, stremato dal post operatorio e dalla chemio, sarebbe rimasto lì, cullato e in fasce in quel letto, senza lode né infamia, che ogni struttura sanitaria offre in serie, perché in serie diventa chi vi giace. Lo sguardo di sua madre, che vidi in ospedale per la prima volta, fu di riconoscenza e di gioia, mista a quella sensazione “è bello vedersi. Ma non è bello vedersi qui, così”, si posò subito su quella scatola di gelè che decidemmo di portare ad Enrico. Gli piaceranno? Ma le può mangiare? Al massimo le butterà via, però lì a mani vuote non ci andiamo. O un libro? Si, ma che libro? Nel mentre osservavo quella donna muoversi nella stanza con un senso di impotenza e di smarrimento: quegli armadietti, custodi di ben poche cose, tra cui pigiami, biancheria, effetti personali, ed il carrello di fianco al letto, non permettevano – e non è quello l’intento – di abituarsi a quell’arredamento. Anzi, rigettano un qualsivoglia invito a rimanervi.
C’è sempre un caos nel riporre, e ricordare, dove le cose vengono custodite quando si è in ospedale. Sistemare, ordinare, ma cosa? Ché non vi è nemmeno un termine, poi, per un genitore che vede sfumarsi un figlio tra le mani. Non vi è un termine preciso, un riconoscimento linguistico per un dolore senza interpretazione alcuna. Un solo etimo: contronatura. Di tutto questo discorso. Io non saprò mai, non l’ho mai saputo, se quelle caramelle le abbia mangiate. So solo che le ultime sue parole, il suo discorso più lungo scaturito da quella visita, fu la sua fermezza nel confermare che sì, di li a poco, dall’ospedale sarebbe uscito, che avrebbe ricominciato a mangiare e ad andare in montagna. Che nonostante quella porzione di fegato in meno, le cose sarebbero tornate come prima, se non meglio. E ricordo ancora gli occhi di sua madre, che ogni tanto tornava in stanza per sfiorare la caviglia o il polso del figlio. Li ricordo come se mi appartenessero. Uscire da lì, uscire da un ospedale dopo una visita, comporta sempre una crisi, un senso di colpa che si preferirebbe volentieri cedere al proprio peggior nemico. Il divorare i lunghi corridoi, come se le luci si spegnessero dietro ad ogni passo verso l’uscita, su pavimenti sempre lucidi e rigati dalle ruote dei lettini, premette un bulimico senso di impotenza, di mancanza, di incredulità. Non passò molto tempo da quando ebbe una ricaduta che lo trascinò in qualcosa a me indefinibile. Ma quei particolari li custodisco in me. Alla tua paura dell’ignoto e alle tue speranze mal riposte. A te, Enrico.
Beatrice Roncato Villa