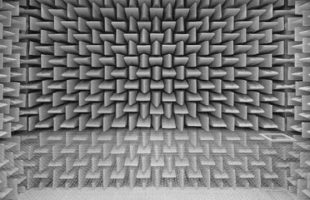In effetti, è solo luglio. Anzi, è già luglio. Dalla clausura forzata dovuta all’emergenza sanitaria dei primi mesi dell’anno ad oggi il tempo sembra esser stato divorato in modo ingordo, senza lasciare traccia alcuna di questo banchetto smisurato. Un po’ mi ricorda la veemenza raffigurata nel dipinto “Saturno che divora i suoi figli”, un’opera di Goya che spesso mi accade di paragonare al tempo tiranno, per l’appunto vorace e immerso nell’ignoto oltre ogni mia capacità di coglierne il senso che verrà. È un dipinto antico, vecchio, molto vecchio: proprio da tale accezione proverò a spiegare il rapporto che la società contemporanea ha con i corpi non più giovani, con il tabù della vecchiaia e, dunque, con la Morte. In questi mesi siamo stati testimoni di una perdita inestimabile, incalcolabile, di cifre insolite e spietate in merito alla scomparsa di quella parte di comunità che tendenzialmente abbiamo fretta di relegare in un angolo perché troppo lenta, perché non più operativa, non più giovane. “Giovane” secondo chi? E soprattutto, “vecchia” secondo chi? I nostri corpi non sono mai scindibili dalle cornici sociali e dalle portate storiche che intervengono, in modo tutt’altro che umile, al loro modellamento. Il corpo è un prodotto storico, una costruzione culturale per la quale adottiamo differenti sistemi di riferimento a seconda di un approccio fenomenologico (la percezione del corpo che si è, vissuta soggettivamente) o cognitivo (la figurazione del corpo che si ha, il corpo cioè oggettivato, ragionato, narrato nei molteplici ambiti della cultura). Ma cosa si intende per invecchiamento? Un insieme di processi che hanno luogo in un organismo vivente e che, con il passare del tempo, ne ridimensionano la probabilità di sopravvivenza, in cui vengono coinvolti i mutamenti sociali, fisici, cognitivi, emotivi e motivazionali. “Ageism” è il preconcetto occulto che si ha sull’età, fondato su idee che possediamo e su alcuni errori cognitivi sistematici. È tutto nella nostra testa. L’idea di vecchiaia è difficile da digerire rispetto all’idea stessa di Morte: riteniamo che sia impossibile, per noi, invecchiare e che questa performance maldestra possa coinvolgere anche noi, la generazione dei “per sempre giovani”.
Un concetto fondamentale a cui fare riferimento è quello enunciato da Greenberg, ovvero la Terror Management Theory (TMT), fondamento della Death Education e in cui ogni singolo individuo è chiamato a gestire la propria ansia di morte attraverso dei “tamponi”, i cosiddetti “anxiety buffers”. In parole povere, mettiamo in atto difese distali e prossimali attraverso cui il nostro inconscio cerca di rassicurarci e di negare l’evento-morte. La vecchiaia è “sintomo” nonché sinonimo di avvicinamento a questo evento universale e naturale e va in qualche modo scacciata in primis dal nostro volto – biglietto da visita al mondo – e dal nostro corpo, che cerchiamo di far apparire più giovane (e dunque ancora capace di utilità e di produttività). Questo, per soffocare la percezione definita da Carstensen (1998) nella sua teoria socio-selettiva del tempo come limitato. Non sopportiamo le rughette, i capelli bianchi, il cedimento dei nostri muscoli né tantomeno il fatto di poter essere catalogati come “morti che camminano”, espressione che sento dire più spesso di quanto vorrei quando si parla di persone diversamente giovani. Non possiamo permetterci di perdere tempo, dobbiamo correre e stare al passo con esso, sentirci utili e dimostrare agli altri di esserlo. Ma il tempo corre lo stesso. Il disagio che proviamo nel non riuscire ad indossare oltre questo abito epidermico che, in qualche modo, non riesce a stare al passo con la nostra idea di io-non-cambio-mai-sono-sempre-lo-stesso ci allontana dalla possibilità di acquisire maggiori consapevolezza e ottimizzazione delle nostre capacità e delle nostre risorse.
Non siamo più capaci di accogliere gli insegnamenti del passato di cui i nostri anziani sono portatori privilegiati e insostituibili: lo abbiamo appurato soprattutto attraverso i media che, alla notizia del decesso per Covid19, facevano a gara nell’affermare con tranquillità che “sono soprattutto gli anziani ad andarsene”. Rassicurante e rispettoso, vero? Come se questo potesse rendere le notizie meno logoranti, come se questo potesse in qualche modo affievolire il senso di lutto soffocato da parte di coloro che hanno perso un proprio caro senza magari averlo più visto a causa delle restrizioni dovute all’emergenza.
Io ho imparato molto dai “miei” anziani. Ho imparato molto da coloro che oggi non ci sono più, da coloro che distrattamente ho incontrato in sala d’attesa dal medico e che, nel loro raccontare le proprie anamnesi talvolta alquanto ardimentose, mi hanno sempre dato la percezione di essere degli Higlanders, degli immortali, visto l’elevato numero di acciacchi in corpo, ma con una forza di vivere degna di un supereroe della Marvel. Un antico proverbio di origine africana dice: “un anziano che muore è come una biblioteca che brucia”. Quest’immagine di una enorme biblioteca in fiamme provoca in me un dolore simile a quello provato quando mi taglio, negligentemente, con la carta. Ed è proprio vero: i nostri anziani sono un’enciclopedia, seppur in rovina (ma a me le cose antiche piacciono così tanto!) dove poter attingere quando manchiamo di saggezza e di buonsenso. Da quando abbiamo smesso di viverli come una risorsa? Da quando abbiamo deciso di relegarli altrove, magari lontani dai nostri occhi per paura di essere “contaminati”? Da quando abbiamo perso la voglia e il tempo di ascoltare le loro storie e i loro insegnamenti? Vi porgo una riflessione nata da una lettura che ebbi modo di affrontare qualche tempo fa, ma che rimane impressa in quella sezione della mia mente (“questo vedi di ricordartelo, grazie, non fargli fare la fine di un pensiero pari a quello di quando, controvoglia, stai andando a buttare le immondizie”) e che proprio la mia mente si rifiuta di abortire.
L’antropologo e biologo Jared Diamond ha affrontato, facendo ricerca sul campo in alcune zone della Papua Nuova Guinea (e non solo), la questione degli anziani e della loro cura, del prendersi cura di una condizione di fragilità. In un villaggio situato nell’Isola di Viti Levu, nelle Fiji, vi fu un dialogo con un autoctono il quale ebbe modo di visitare, a sua volta, gli Stati Uniti – paese natìo di Diamond – e dal cui viaggio scaturirono pensieri positivi, ma anche sgradevoli. Vi fu uno scambio interculturale di straordinaria portata: secondo questo tale, infatti, il trattamento riservato agli anziani negli States era scandaloso, relegati come sono negli ospizi dal momento che a Viti Levu questa parte della comunità continua a vivere tra i parenti e gli amici, spesso nelle dimore dei figli, che “si prendono cura di loro tanto da premasticargli ed ammorbidirgli il cibo se hanno i denti troppo consumati”. Un gesto così semplice, così elementare. Nella nostra corazza occidentale potremmo addirittura rabbrividire dinnanzi a un gesto simile. Eppure in me suscita tenerezza. Altresì, sentenziava a Diamond: “Voi i vecchi li gettate via, e che importa se sono i vostri genitori?”. Certamente, si tenga sempre conto delle circostanze sociali, politiche, culturali ed economiche: ma, a parer mio, si può imparare davvero molto da queste differenti prospettive, soprattutto quando siamo coscienti di aver perso per strada, come il corpo inanimato e distratto di un fazzoletto, alcune strategie sociali legate alle ritualità e alla saggezza.
In altre società tradizionali agli anziani vengono riconosciuti status ben più potenti e prevaricanti sui propri figli adulti, di controllare i possedimenti della cerchia sociale e di “impedire agli uomini di sposarsi prima dei 40 anni”. Per i !kung (presenti in Namibia, Botswana e in Angola Meridionale) il valore sociale degli anziani è comprovabile nelle diverse attività in cui vengono coinvolti, dall’elevata utilità per la comunità. Essi infatti, dopo i 60 anni, “assistono i più giovani nelle battute di caccia, lavorano mediamente sette ore al giorno raccogliendo tuberi e frutti […]; badano ai più piccoli, possono fabbricare oggetti utili; ostetriche e guaritori sono spesso figure anziane, lo stesso vale per maghi e sacerdoti, profeti e stregoni”. Insomma, vere e proprie risorse, fonti orali, depositari di esperienze e di conoscenze da cui si attingono miti e canzoni della tribù, nomi di diverse specie animali e vegetali, dove trovar cibo nei periodi più difficili. Per i !kung, i più anziani sono meritevoli di rispetto semplicemente per il fatto di essere sopravvissuti a incidenti, malattie, leoni e offensive nemiche, ma anche e soprattutto per la dottrina confuciana che vede i figli in una posizione di totale deferenza nei confronti dei genitori. La mancanza di rispetto è un disonore, ed il dovere di sostenere i genitori nella parte della loro vita più delicata è a tutt’oggi molto sentita.
Questa forma di rispetto e di cura è ben distante dal tessuto valoriale saturo di individualismo, di indipendenza e di privacy a noi familiari: così come negli States, anche in Italia il principio cardine che stigmatizza le persone anziane è il culto della giovinezza, la sua venerazione più becera. L’impero della pubblicità ha infatti stabilito che sia più appetibile una testa bionda, non canuta, un corpo privo di rughe o di smagliature, possibilmente ritoccato da siliconi e da masse di plastica, per presenziare alla reclamizzazione di bibite, vestiti o automobili. La longevità ha dato spazio sì ad una maggiore aspettativa di vita, ma al contempo al rapporto direttamente proporzionale tra “inutilità” sociale e “infelicità” sociale. Come restituire, dunque, senso e ristabilire un equilibrio con i nostri archivi viventi? Fare tesoro delle loro esperienze, dei loro racconti, con la consapevolezza che il tempo investito in queste chiacchierate sia prezioso; valorizzare ed accogliere i cambiamenti che con il passare delle albe e dei tramonti avvengono e ci coinvolgono (tutti, nessuno escluso) per gestire al meglio il nostro tempo e le nostre relazioni. Concludo con una citazione a mio parere esauriente ed assiomatica: “La sfida importante che attende la nostra società consiste dunque nel reinventare un nuovo stile di vita per le persone avanti negli anni, che si dimostri più adatto ai rapidi cambiamenti del mondo contemporaneo. Se tante società del passato riuscivano a fare un uso migliore dei loro anziani e ad offrire loro vite più soddisfacenti di oggi, è nostro dovere cercare soluzioni più gratificanti per tutti” (Diamond, 2012).
Beatrice Roncato Villa