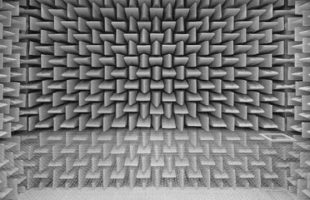In realtà non sono poi così tanti anni che, a ben riflettere, siamo stati testimoni di una piccola strage urbana tra le nostre sviste e il nostro modo di comunicare con gli altri. Penso siano rari infatti gli incontri, del tutto casuali, con delle cabine telefoniche. Sì, quei prefabbricati antiestetici e quelle postazioni, spesso situate in luoghi di passaggio, che ornavano le città in modo del tutto improprio e straordinario. Per molti anni sono stati non-luoghi colmi di promesse, di frasi non dette, di esitazioni e di litigi, ma anche di buone notizie e di ritorni inaspettati, impronte di anime mescolate sino a creare una pellicola di passaggio su quelle cornette violentate dalle orecchie di chi non aveva altri modi per comunicare. Comunicare agli altri, con gli altri, il proprio sé, il proprio esserci nel mondo.
Un telefono in centro città? Un telefono all’entrata della stazione? Ah, quindi posso chiamare per annunciare il mio arrivo o semplicemente per, in base agli spiccioli, comunicare un “sento la tua mancanza”, concentrando poche parole prima che la linea spirasse senza preavviso. E poi il nulla, lo sgomento per non aver detto tutto prima di quella caduta. Era il primo passo per comunicare il proprio dinamismo fatto di spostamenti in altre città, di comunicazioni fugaci e ben calibrate. Non c’era già più il bisogno di essere rinchiusi tra le mura domestiche per fare una telefonata. Il primo timido passo verso quella che poi è divenuta la nostra normalità, ciò che per noi è divenuto abituale e, non si neghi, alla stregua di una schiavitù. Quelle cabine hanno iniziato ad offendersi, a non sentire più la propria utilità, soppiantata dalla telefonia mobile, sovrana della costante reperibilità in ogni luogo. Per mesi mi sono imbattuta in carcasse di lamiera e di vetro, depositi di foglie, rifiuti, guanti probabilmente caduti ad un passante distratto, adesivi di gruppi musicali undergound che, probabilmente, oggi non esistono nemmeno più, ed un divieto di accesso delineato da una sottile linea in pvc bianca e rossa. Un muro sì tanto fine, ma il cui messaggio era lapalissiano e autoritario: “vietato entrare”.
Già dal 2010 in Giappone è stato posto un telefono in un giardino immenso, su una collina. Un passo indietro, anacronistico, contrastante con l’ovunque io posso chiamarti, ovunque, io, posso farmi trovare. Ma non è un telefono come gli altri, no. Niente fili, niente wireless, niente circuiti di ritorno. Un telefono nero come il carbone, nel classico modello a rotella, adornato da quei numeri che aspettano solo un dito per essere sedotti, con una cornetta e con un filo posto più per ornamento che per logica. È il telefono del vento, “Kaze no Denwa” per essere precisi. Racchiuso in una cabina di legno dipinta di bianco, come fosse una sposa intagliata, e di vetro, quello scrigno dal tettuccio color acqua marina custodisce gelosamente il telefono, ma anche una penna, un quaderno di carta, un calendario di legno, dei quadretti e una cornice con un articolo di giornale. Forse la notizia della comparsa di questo strano e minuscolo tempio delle parole.
Era il 2010 quando Itaru Sasaki perse il suo affezionatissimo cugino al quale era molto legato. Dopo il terremoto e lo tsunami del marzo 2011, nella catastrofe che, oltre a violentare la terra, i raccolti, i palazzi e la vita inanimata in calcestruzzo, portò via con sé circa ventimila anime, tra dispersi e corpi ritrovati, questo telefono trovò vita nuova. Trovò nuova genesi in quella cabina bianca, colore del lutto. Ora è un luogo di passaggio dove chiunque può (come nelle obsolete cabine telefoniche a noi familiari) fermarsi dal caos del mondo e chiamare l’altrove attraverso il vento. Far giungere le proprie parole in un modo tenero e colmo di speranza, laddove solo il respiro del cielo può arrivare. Quella cabina si è riappropriata di un ruolo audace e materno, un utero di legno e vetro dove potersi sentire protetti ed accettati nel proprio dolore, con la speranza di un contatto – seppur attraverso un monologo – con le proprie assenze e con le proprie perdite. Un po’, quel telefono, lo invidio. Se pensiamo che la telefonia da quando è nata (caspita, già a fine ‘800!) non ha fatto che accorciare le distanze, facendoci connettere per chilometri di attese geografiche, oggi più che altro le distanze le ha create.
Il primissimo telefono mi venne donato in un’occasione ben particolare: la Cresima. Sinceramente, non sapevo bene cosa farmene: era una creatura a me aliena, abituata com’ero ancora agli appuntamenti con i compagni di scuola scritti sui diari, o via telefono fisso, quando invero si aveva a che fare con quei bei telefoni cellulari che pesavano come sassi troppo scomodi per portarseli dentro le tasche ed il cui apice era il gioco di un serpente che non doveva autodivorarsi. Io, invece, lo facevo morire sempre.
Con il tempo, negli anni, sono cresciuta con l’evolversi di telefoni sempre più all’avanguardia, tra fotocamere, videochiamate, ordini vocali, cartine geografiche grandi come spilli e che si diramano con il semplice tocco di un dito, manca solo che inizino a preparare la cena al posto mio, poi posso anche lasciare il palcoscenico del mondo. La vita online, avidamente ingoiata dai social network, per un certo periodo della mia esistenza mi ha fatto stordire e scivolare nel non comprendere che, no, la vita nell’etere non era vita reale. E che le relazioni erano qui, negli odori della città, nelle strade dissestate e con i sanpietrini sempre esposti e pronti a farti inciampare, nei colori ormai sempre spenti del cielo patavino. La contemporaneità ha portato con sé questi embrioni tecnologici mostruosi e arroganti: il telefono cellulare, capace non solo di offrire telefonate illimitate (addio spiccioli per ingravidare le cabine), a qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, ha offerto la possibilità di generare il proprio alter ego virtuale rendendoci schiavi della presenza-assenza perenne di noi stessi. Fisicamente non ci siamo, ma col telefono possiamo dare segnale della nostra presenza. Io, questo lo trovo mostruoso.
Non sono poi così sicura di voler essere ovunque, ed altrove. Ma qui, ed ora. Ho iniziato a conviverci, ho iniziato a rapportarmi al telefono come si fa con un vecchio amico per il quale, però, si nutre una certa diffidenza nonostante l’intimità. Ma negli anni la rubrica si alimentava di nomi, di nomignoli, di soprannomi o di iniziali di persone che alla fine non sentivo mai. Invece di altre ricordo ancora la voce. Nonostante gli anni, appassiti e marciti come terreno per troppo tempo nascosto dalle foglie, io quelle voci le ricordo bene. Ma non le ho più potute sentire. E quei nomi, quei numeri, li ho dovuti cancellare. Dalla rubrica, dalla mia mente, dai miei giorni a venire. Mi manca la voce di mia nonna. Il suo modo di chiamarmi, il suo modo di riprendermi se prendevo un biscotto dalla credenza senza chiedere per cortesia. Il suo tono roco, seppure sempre giocoso, nella risata corrosa dal quel vizio del tabacco che si è portata in tomba. Ricordo le sue chiamate, ricordo il suo tono nel mio risponderle “ciao, Nonna!”. Ricordo anche le sue pause, quando dicevo che no, non sarei potuta passare da lei per quel pranzo che poi non è mai più avvenuto. E quelle pause sono macigni che ingoio, ogni tanto, quando il pensiero cerca di prendersi gioco di me e di ricordarmi le mie mancanze. Ma io quella voce me ricordo ancora. Come ricordo quella del mio adorato zio, dalla cadenza decisamente laziale, con cui mia madre poi rimaneva per ore e ore al telefono: “beh, ma come stai? Ma le analisi? Eh no, qui le cose vanno come al solito” e via discorrendo. A me piaceva ascoltare quelle telefonate perché sapevo che alla fine della chiacchierata partiva un urlo dall’altra parte della cornetta, con il suo saluto. La distanza, lì, era accorciata come si fa con un abito che compri, di cui ti rendi conto solo dopo che è troppo lungo, ma che, con un po’ di astuzia, riesci a rendere accettabile, seppure non proprio perfetto. Così come le distanze riescono, con la stessa arguzia, ad essere accorciate dai telefoni.
Questo, sin quando dall’altra parte hai una risposta. Ma arriva un tempo in cui quelle risposte, quei ritorni, smetti di permetterteli. Perché nessuno ti può più rispondere. Per alcuni mesi ho tenuto per me quei numeri di telefono salvati, scorrendoli sempre troppo velocemente per far finta di non leggerli. Come si fa con certi biglietti di auguri che col tempo ingialliscono, ma che riportano la firma di mani tremolanti che non possono più scrivere. Si, io quel telefono, a Itaru Susaki, lo invidio. Perché ha fatto proprio il vento. Perché dona a lui quelle parole che nemmeno la carta può ingoiare. Dove le parole si disperdono, si dissolvono in una danza così rumorosa che fai fatica a starci dietro e ti fermi perché non riesci a stare al passo. Quello del vento è un privilegio, in fondo. Accarezza, scompigliandole, le teste, senza essere visto, come un ladro notturno. Spazza via le nubi con arroganza, ma promettendo sempre un sole. Porta via le parole, le parole più dolci, quelle più violente, quelle più dolorose e quelle più nostalgiche. Senza lasciare traccia alcuna. E se io potessi prendere in mano quel telefono, so per certo molto bene cosa vorrei dire. E come dirlo. Senza bisogno di un volto davanti, perché quei connotati sono impressi nella mia memoria come scolpiti nelle mie ossa. Chissà, magari un giorno farò un salto in Giappone. Per ora, però, mi accontento di scrivere lettere che poi non porto mai al camposanto.
E tu? Se potessi far arrivare le tue parole donandole al vento, a Chi le dedicheresti?
Beatrice Roncato Villa