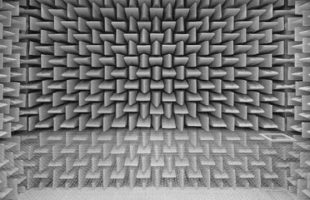Accade che, spesso controvoglia o spesso per necessità, le case d’altri debbano essere svuotate. E penso sia una delle cose più odiose, dolorose e ostiche che un dolente debba gestire nel corso della propria vita. La gestione dell’assenza altrui. La gestione di un futuro incerto in cui l’altro significativo non è considerato. La gestione del distacco eterno o, perlomeno, indeterminato. In Svezia esiste una locuzione ben precisa, “dostadning” (fare le pulizie della morte), riferita in particolare alle abitazioni dei propri genitori. Magari è la casa dove si è vissuta l’infanzia nei suoi giorni più innocenti o quella in cui si è cresciuti, cambiati, dove sono germogliati i primi passi. E dove poi i passi hanno iniziato a diminuire, per calpestare altrove.
Fosse per me, potrebbe rimanere tutto lì, come quando lasci l’abitazione delle vacanze, con i piatti riposti con cura nella credenza, il vaso con i fiori che sì, anche se sono veri che importa, li toglierai con pazienza l’anno a venire. Questo, accertandoti che i petali non si sgretolino come sabbia. Potrebbero rimanere lì anche quei vestiti che, forse, troverebbero utilità nell’eventualità che magari d’inverno al mare ci torni e non vuoi essere colto alla sprovvista. No: svuotare una casa senza più padrone non è la stessa cosa. È una casa dove si farà di tutto pur di non tornare. Soprattutto quando il padrone di casa era un parente, un amico, un nonno acquisito, una zia che non vedevi da ere e con cui neppure le telefonate riuscivano a rilegare, come libri, i rapporti. Quei libri che compri ai mercatini dell’usato la domenica pomeriggio, che si sdruciolano tra le mani impolverandole fastidiosamente. E, dunque, devi decidere se riporli nella teca così, lasciandoli marcire per noia, o se prendertene cura, o provarci almeno, per dar loro una seconda possibilità. Ma si ha davvero la pazienza e la cura di occuparsi di qualcosa che non sembra avere tutta questa importanza?
Nella nostra visione immortale del “tanto c’è sempre tempo. Tanto ci sono cose più rilevanti a cui badare”, no, questa pazienza non c’è. Spesso le relazioni non sono tanto facilmente restaurabili come un vecchio volume. E, quindi, si preferisce lasciarle guastare, sino alla data di scadenza. Come quella prevista e segnata sotto i barattoli o sotto il cartone del latte. Fosse per me, vorrei che il tempo portasse via da sé tutte quelle cose facendole sparire attraverso qualche strano meccanismo di prestidigitazione. Invece ti vesti di coraggio, levighi quelle spinose sensazioni di dissenso in corpo e fai quello che devi. Ed ecco che la pazienza a cui prima non davi molta rilevanza, bussa alla porta per non essere più respinta.
Le case vuote, che vuote poi non sono, portano con loro un fascino straziante, intriso di aria asfissiante, di buio e di polvere dolcemente adagiata ovunque. Adagiata sui vasi, sugli specchi che mille volte ti hanno visto entrare e su cui ti sei posata distrattamente. Si appoggia sulle matriosche, sul telefono all’ingresso e sulle lampade delle stanze da letto, ancora con la carta da parati ingiallita dal fumo di sigaretta. La polvere è lì, timida, discreta, senza chiedere permesso entra e rimane sgradita ospite sino a quando apri gli scuri e la luce inizia a rivelarla in tutta la sua volgarità. Le case vuote sono questo: odori incastonati tra le mura, profumi antichi di pietanze preparate con amore, oggetti degli anni ‘50 che come totem si appropriano degli spazi e altrove non potrebbero mai stare. Sono i vecchi giocattoli custoditi gelosamente nel sottoscala dove i ragni fanno da guardiani. Le case vuote sono capaci di ingurgitarti in un modo tanto ingordo da farti sentire rivoltato come un calzino spaiato di cui non trovi, per l’appunto, il compagno.
Ti rendi conto che gli armadi altro non sono che sarcofagi di tessuti di qualità eccelsa, ricamati con una tale delicatezza da commuoverti. Vestiti, cinture, giacche e camicie ancora intrise di profumo, su cui scorgi un capello chi si è lasciato abbandonare sulle spalle. “Quel maglione sì, glielo regalammo a Natale, ma non lo mise mai. E questa sciarpa? Pensavo l’avesse persa, invece era proprio qui”. Chissà se su quegli indumenti posso trovare ancora i passaggi di quelle mani, di quelle dita che sembravano di carta, nello scegliere con cura cosa indossare per uscire a fare spese, per mostrarsi timidamente al mondo. E le scarpe. Le scarpe dai dieci, cento, mille passi. Portano ancora la forma di quei piedi stanchi e che non trovavano la loro comodità, che uscivano di casa, ma che avrebbero sicuramente preferito dimorare in quelle pantofole color lillà, certo più comode e invitanti. Gli oggetti personali, poi. No, non parliamone proprio. Una spazzola, anch’essa accoccolata tra capelli ancora aggrappati come sanguisughe, o le creme con ancora i segni decisi, ma sempre delicati, delle dita nel barattolo. Il profumo di una vita e mai cambiato, foto di vecchi amori mai dimenticati o spille utilizzate nelle occasioni mondane.
Talvolta mi chiedo come mai un semplice oggetto possa essere così rilevante per noi che rimaniamo. Mi chiedo cosa speriamo di trovarvi, forse l’ingenua speranza di un ritorno. Del resto, l’oggetto è qui. Tornerà prima o poi a riprenderlo, no? Sono quei conti del lutto che paghiamo alla fine di questi lunghi convivi con coloro che amiamo, con coloro che come noi sono solo di passaggio. Che a un certo punto, senza preavviso, si alzano da tavola e senza salutare si assentano.
Pochi giorni fa, a pensieri tersi, dovetti scendere nel garage del mio nonno acquisito, il Signor G. Un uomo inossidabile se non per quei polmoni che a un certo punto iniziarono a spegnersi come un cero lasciato acceso per un’intera notte, sino alle luci dell’alba. Fui immersa nei suoi affari. Immersa nelle sue storie di vita di cui ogni tanto mi parlava e di cui conoscevo i volti amati solo tramite le fotografie che mi mostrava. Non è affare facile trovarsi nelle sfumature private altrui. Mobili desueti, specchi antichi, di quelli opachi, ma preziosi, che sarebbe un sacrilegio buttarli. Scatoloni con scritto “fragile”, con quella calligrafia che mai più ritroverai per mano d’altri. Le decorazioni natalizie, di cui qualcuna scheggiata, che chissà quante feste e cenoni hanno vissuto. Santini, per lo più un Cristo severo, e un manifesto appeso al muro per il centenario della (bis)nonna Vittoria. E rimangono lì, a ricordarti di un passaggio, del passaggio d’altri. Attrezzi da lavoro consunti per il troppo utilizzo, barattoli di vernici ormai essiccate come prugne e qualche rivista, qualche libro, tre almanacchi. Fu lì che feci un incontro inaspettato, e per questo tanto piacevole, con un libro.
Fu lui a chiamare me, e non il contrario. Come spesso mi accade quando metto i piedi in libreria, i libri “mi chiamano” e se non mi va di affrontare un corridoio gravido di romanzi gialli so per certo che è perché lì non troverei ciò che cerco. Così, il libro di Allende, “Paula”, mi trovò. Fu una danza strana, un incontro ricco di esitazioni e di cedimenti: “lo prendo o no? Ma no dai, meglio comprarlo… cosa mi salta in testa di prendere quel libro come fosse un assaggio ai banconi della fiera campionaria!”. Ebbene, bastò chiedere il permesso al mio compagno, nipote invero del Signor G., e quel libro me lo trovai tra le mani in un batter d’occhio. Con la tacita promessa del ritorno in quel garage. È strano prendere in prestito un libro che non è tuo. Né più di alcuno. Le pagine, ingiallite, mi fecero pensare che quel libro in casa non avesse motivo di rimanere o che non aveva un posto per sé in mezzo a tutte quelle raccolte di lampadine, giornali, dischi in vinile e cioccolatini ormai scaduti, ma che hanno trovato tomba sul tavolo del salotto.
Pagine attaccate tra di loro, dall’odore tipico di chiuso e di muffa che a me piace conservare tra le collezioni di cose che mi provocano una compiacenza ancestrale. “Paula” non è una storia qualunque. Si parla di morte, si parla di fine vita. Di “inganno alla morte” e no, forse non lo avrei mai comprato. Perché mi sarei persa come in un negozio di dolciumi e, nel poterne prendere solo uno, non avrei scelto quello. Il periodo di osservazione che ne derivò da parte mia, su quelle pagine ruvide esposte come un corpo seminudo, fu frettoloso, ma eterno, con la solita cautela di quando prendi in mano i bicchieri di cristallo delle occasioni speciali che, poi, non avvengono mai. Quella piccola, insignificante, ma spavalda, piega, a pagina 51, fatta da altre dita e che a me sembrava di violare in modo vergognoso, cosa avrà significato mai?
Potevo, io, tormentarne la pagina e farla tornare dritta, come quando cerchi di aggiustare una pianta che proprio non vuole saperne di rimanere eretta come un soldatino di piombo sull’attenti? La lasciai lì, non era compito mio, sebbene abbia provato a trovare tra quelle parole un motivo, un collegamento, un perché. Quel libro ha nuova casa, una libreria di passaggio visto che, prima o poi, tornerà nella sua vera culla. C’è sempre uno strano non-so-che nel toccare cose che non ti appartengono, ma che per anni hai avuto cautela di proteggere proprio perché della nonna, del nonno o di chi per loro. Faccio ancora fatica a gestire le assenze, talvolta. Perché non reggo a certi odori pregni di colori e di suoni, di ricordi e di parole che probabilmente girano ancora tra quelle quattro mura. Molte cose non ci sono più, altre aspettano il loro momento per andarsene, per essere portate altrove. Per ora, rimangono lì, come guardiani silenziosi ed immobili. Ma io quel motivo, nella piega, non lo trovai. Mi troverà lui, quando sarà pronto.
Beatrice Roncato Villa