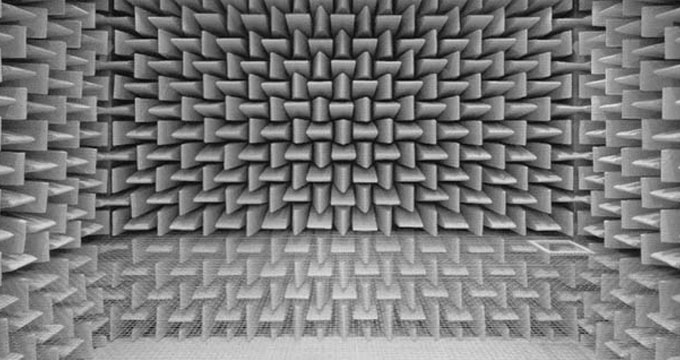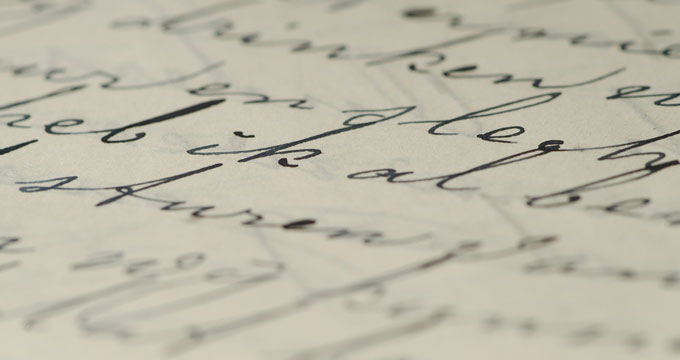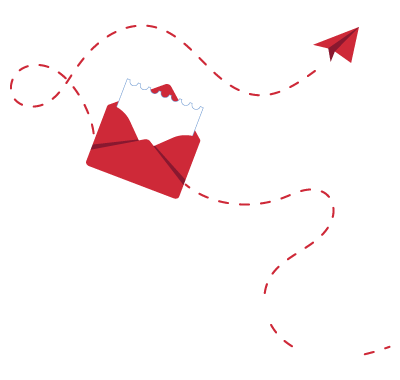Oltre la notte.
Sono le ultime attese dell’anno. Gli ultimi giorni, quelli che si fanno attendere dopo un intero anno, donando quella stessa emozione di quando si aspetta qualcuno la cui importanza va oltre le nostre corde, la nostra pelle d’oca pulsante. Le attese ai binari della stazione, in macchina scrutando tra la folla, o quella gentile alla fermata del bus che prima o poi arriva, con calma, ma arriva. Si attende dicembre in modo sempre affannato, come se a lui fossero destinate le colpe e le mancanze di ciò che è stato o che non è stato, forse già proiettati nei mesi del nuovo anno in cui riporremo con cura il velo dei dolori portati sulle spalle nei mesi divorati dal tempo passato. E dicembre non ha risparmiato i miei affetti, anzi. Ne ha divorati molti, come fossero su una tavola imbandita tipica dei cenoni natalizi che, a quanto pare, quest’anno saranno poveri di animo, e di anime.
La città è una enorme casa vuota, di quelle diroccate e erose dal tempo maligno, da un sole audace e dalla pioggia fastidiosa, ma gentile. Una casa vuota con stanze piene, luminose, dove le decorazioni natalizie non lasciano spazio neppure per pochi attimi a tutto il buio che tocca le carni di una città soffocata dalle luminarie; e stanze vuote, ovvero i negozi chiusi con un necrologio affisso quale “vendesi”, o “cedesi attività”, la morte dell’urbe che giunge come una metastasi bombardata da crisi e da decreti.
Mostre temporanee temporaneamente chiuse, Musei scettici seduti sulle proprie fondamenta nell’attesa di una riapertura che tarda ad arrivare soffocando i quadri nel buio delle stanze che li portano in grembo. Addirittura, i cartelloni pubblicitari della mostra di Van Gogh paiono sciogliersi con le intemperie, come se qualcuno vi avesse gettato sopra dell’acido: quest’anno solo pochi banchetti nelle piazze danno l’idea che le feste siano già passate, in un anno che ha ben poche cose per cui provare gaudente tripudio.
Trovo conforto solo quando riesco a portare a passeggio il mio piccolo quadrupede, in mezzo al fogliame calpestato da altri prima di me dei quali non scorgo le impronte nitide, ma solo orme violente fastidiose alla vista. E mi rendo conto di come il tempo in realtà pare non andare avanti. E di come si sia fermato, di come sia in costante attesa. Proprio l’altra notte infatti, ben lontano dall’inopportuno riflesso dei lampioni, in mezzo all’erba già ebbra di brina trovai un riccio a cui diedi il nome di Ermete. Poco più grande del palmo della mia mano, mi ritrovai a tu per tu con una creaturina che in realtà non avrebbe proprio dovuto essere lì. Il temerario, fuggevole al letargo, stava probabilmente tentando il suicidio nella strada vicina, non lasciandomi altra scelta dallo spostarlo da lì, senza nascondere il disappunto per questo suo modo di scappare al ciclo naturale del sonno invernale. Evidentemente ha seguito quello di un dicembre capriccioso e insolente, troppo caldo e baciato dal sole quasi fosse marzo! Non dormii quella notte: i miei pensieri erano proiettati al giorno dopo, a che fine avesse fatto la bestiola oltre la notte, se l’avesse passata, se avesse oltrepassato quella strada dove le macchine corrono come carri armati rabbiosi. In questi ultimi mesi fatico a comprendere il ciclo delle cose che hanno preso una piega simile a quella che si crea sui vestiti poco prima di un evento importante. Una fissazione che di lì a poco svanisce, ma che gratta come un cane alla porta. Manca poco alla fine dell’anno e, forse, una cosa dovrei imparare. Dovrei capire quando è ora di andarsene, quando è ora di lasciare andare e di fermarsi, di fermare i pensieri e lasciare andare i propri fantasmi. Seppur invisibili, costantemente presenti, anche se sentiamo il ghiaccio nelle vene. Così come il riccio, noncurante del tempo, che continua sulla propria strada alla ricerca del tepore che dicembre sembra negargli, ma che non può domare.
Beatrice Roncato Villa
Oltre la notte.
Sono le ultime attese dell’anno. Gli ultimi giorni, quelli che si fanno attendere dopo un intero anno, donando quella stessa emozione di quando si aspetta qualcuno la cui importanza va oltre le nostre corde, la nostra pelle d’oca pulsante. Le attese ai binari della stazione, in macchina scrutando tra la folla, o quella gentile alla fermata del bus che prima o poi arriva, con calma, ma arriva. Si attende dicembre in modo sempre affannato, come se a lui fossero destinate le colpe e le mancanze di ciò che è stato o che non è stato, forse già proiettati nei mesi del nuovo anno in cui riporremo con cura il velo dei dolori portati sulle spalle nei mesi divorati dal tempo passato. E dicembre non ha risparmiato i miei affetti, anzi. Ne ha divorati molti, come fossero su una tavola imbandita tipica dei cenoni natalizi che, a quanto pare, quest’anno saranno poveri di animo, e di anime.
La città è una enorme casa vuota, di quelle diroccate e erose dal tempo maligno, da un sole audace e dalla pioggia fastidiosa, ma gentile. Una casa vuota con stanze piene, luminose, dove le decorazioni natalizie non lasciano spazio neppure per pochi attimi a tutto il buio che tocca le carni di una città soffocata dalle luminarie; e stanze vuote, ovvero i negozi chiusi con un necrologio affisso quale “vendesi”, o “cedesi attività”, la morte dell’urbe che giunge come una metastasi bombardata da crisi e da decreti.
Mostre temporanee temporaneamente chiuse, Musei scettici seduti sulle proprie fondamenta nell’attesa di una riapertura che tarda ad arrivare soffocando i quadri nel buio delle stanze che li portano in grembo. Addirittura, i cartelloni pubblicitari della mostra di Van Gogh paiono sciogliersi con le intemperie, come se qualcuno vi avesse gettato sopra dell’acido: quest’anno solo pochi banchetti nelle piazze danno l’idea che le feste siano già passate, in un anno che ha ben poche cose per cui provare gaudente tripudio.
Trovo conforto solo quando riesco a portare a passeggio il mio piccolo quadrupede, in mezzo al fogliame calpestato da altri prima di me dei quali non scorgo le impronte nitide, ma solo orme violente fastidiose alla vista. E mi rendo conto di come il tempo in realtà pare non andare avanti. E di come si sia fermato, di come sia in costante attesa. Proprio l’altra notte infatti, ben lontano dall’inopportuno riflesso dei lampioni, in mezzo all’erba già ebbra di brina trovai un riccio a cui diedi il nome di Ermete. Poco più grande del palmo della mia mano, mi ritrovai a tu per tu con una creaturina che in realtà non avrebbe proprio dovuto essere lì. Il temerario, fuggevole al letargo, stava probabilmente tentando il suicidio nella strada vicina, non lasciandomi altra scelta dallo spostarlo da lì, senza nascondere il disappunto per questo suo modo di scappare al ciclo naturale del sonno invernale. Evidentemente ha seguito quello di un dicembre capriccioso e insolente, troppo caldo e baciato dal sole quasi fosse marzo! Non dormii quella notte: i miei pensieri erano proiettati al giorno dopo, a che fine avesse fatto la bestiola oltre la notte, se l’avesse passata, se avesse oltrepassato quella strada dove le macchine corrono come carri armati rabbiosi. In questi ultimi mesi fatico a comprendere il ciclo delle cose che hanno preso una piega simile a quella che si crea sui vestiti poco prima di un evento importante. Una fissazione che di lì a poco svanisce, ma che gratta come un cane alla porta. Manca poco alla fine dell’anno e, forse, una cosa dovrei imparare. Dovrei capire quando è ora di andarsene, quando è ora di lasciare andare e di fermarsi, di fermare i pensieri e lasciare andare i propri fantasmi. Seppur invisibili, costantemente presenti, anche se sentiamo il ghiaccio nelle vene. Così come il riccio, noncurante del tempo, che continua sulla propria strada alla ricerca del tepore che dicembre sembra negargli, ma che non può domare.
Beatrice Roncato Villa