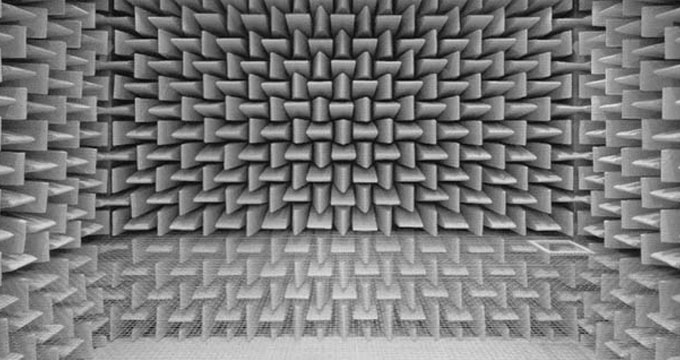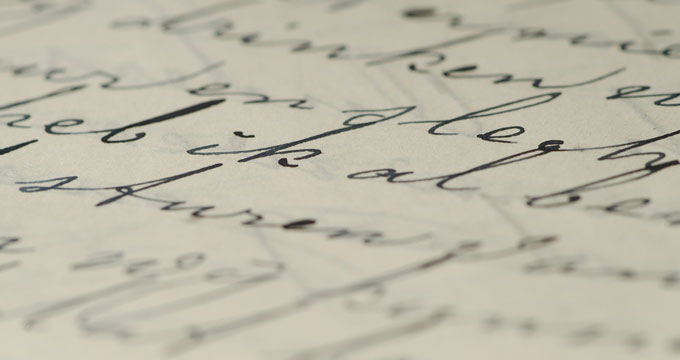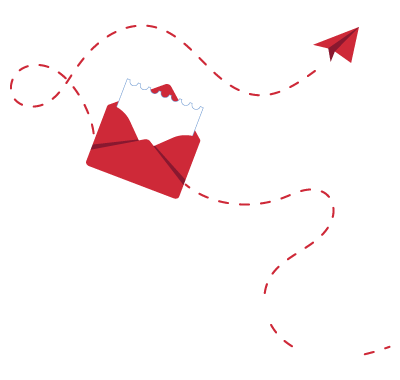L’ultimo atto degli altri.
La sacrosanta volta in cui presi la decisione di avvicinarmi al corso per Cerimoniere Funebre nemmeno potevo immaginare che mi avrebbe stravolto la vita, stravolto le morti. Fu come quando finalmente decisi di accostarmi al mondo della tanatoestetica: per molti anni, ero poco più che ventenne, evitai di osare per paura del giudizio altrui, sempre troppo tagliente e poco alleato, che nel corso del tempo mi ha fatto credere che tutto ciò fosse solo per menti non proprio stereotipate secondo le sacre leggi della massa. Ebbene, c’è sempre un momento nella propria esistenza, una scintilla ghiacciata, in cui ci si rende conto di “non vivere” per accontentare gli altri o di “non vivere proprio” ragionando in tal modo. I passi misurati al millimetro quando feci il corso di tanatoprassi si sono poi rivelati una piacevole spinta in avanti, facendomi recuperare speranze e fatiche in un mondo tanto particolare quanto delicato. Però non mi bastava, no. Lavorare “dietro le quinte” mette in ombra gli occhi degli altri davanti a ciò che è il lavoro che si fa per non disturbarne la vista: chi è del mestiere comprende che dialogare con la morte altrui è affare spiacevole allo sguardo accusatore di quegli umani che non accettano, né sanno accogliere, l’ultimo atto degli altri. Un pensiero si è impresso nella mia mente da un po’ di anni. Passiamo una vita intera a costruirci, a erigere la nostra immagine e la nostra identità, nel bene e nel male, giusta o sbagliata che sia. Viviamo di particolari, siamo ossessionati nell’apparire perfetti prototipi quando passeggiamo per quelle lunghe e affollate strade tra corpi incapaci di stare fermi e luci accattivanti che ci invitano ad entrare nei negozi solo per invogliarci ad adornare quella stessa nostra identità quando in realtà altro non siamo che prodotti di catene di montaggio. Insomma, l’esistenza pare ridursi ad una proposta seducente del sé e sempre eterna, mai imperfetta. Eppure, pochi di noi pensano a… cosa vorrei lasciare, di me? Cosa vorrei che gli altri ricordassero di me? Per quanto sottile, questo pensiero non si aggrappa se non a quelle menti più avezze al pensiero della propria impermanenza: spesso e volentieri, infatti, la maggior parte delle persone non si cura di cosa vorrebbe fosse detto… il giorno del proprio funerale. A tale proposito, vista la mia deliziosa sete di curiosità, mi accade di dialogare (anche) con estranei in merito al proprio ultimo spettacolo su quel palcoscenico che è l’esistenza. Molti rimangono inghiottiti in una spirale di ammutolimento indecoroso o si lasciano andare alle più spietate conclusioni, evidenziando in realtà disagi e rimorsi. Pochi, invero, capiscono che nella loro unicità le persone trovano non difetti quanto pregi o virtù. Sarà mia premura raccontare, entro il sottile limite del rispetto altrui, qualche episodio a me rimasto intaccato come calcare sul cuore legato alle cerimonie, agli ultimi atti di cui mi sono presa cura. E inizio con L., moglie devota, madre severa, ma sincera, che mi parlò del marito, mancato dopo una lunga malattia nella quale trovava conforto, rifugio e mai noia. Mai. Dopo diversi anni di matrimonio, giusto il tempo di dissolversi nell’altro tanto da non distinguere più chi fosse l’uno e chi fosse l’altra, i piccoli difetti sono divenuti enormi mancanze nella vita quotidiana. E ne elenco alcuni che mi trovai a proferire ad alta voce, con il cuore in mano da una parte e un viscerale ammonimento dall’altra, il giorno della cerimonia. Non mi abituerò mai a fare miei, a tenere tra le mani i gesti più intimi e sinceri della vita delle persone: quel giorno, e me ne resi conto solo mentre leggevo e non mentre preparavo il discorso, capii che ci si può aggrappare, nel più profondo buio dello sconforto, a quei fastidi e a quei meccanismi anche legati a circostanze spiacevoli per cercare il vuoto assente di chi se ne va. Così L., che volle evidenziare come in quegli anni anche i panni sporchi del marito, lasciati barbaramente adagiati sul pavimento e mai nel cesto apposito, potessero lasciare la mancanza e il rammarico di non doverli più raccogliere dopo la sua dipartita. Che i baffi tagliati, lasciati sempre sul lavandino dopo la rasatura, erano solo un piccolo neo che sporcava il bianco candido della ceramica senza il quale, ora, L. non sente più la necessità di farsi accecare da quel candore dove non ritrova più le tracce del consorte. E la cenere sparsa sul tavolo, dove spesso le sue mani tremanti non erano più in grado di controllare la giusta distanza tra il posacenere ed il sigaro, che reclamava il proprio spazio nel solco tra l’indice ed il medio, ormai di cartapesta. Vi ho anche raccontato troppo, ma la Signora L. sa che, in fondo, ora le sue memorie sono anche un po’ mie. E le custodisco gelosamente nel mio cuore.
Beatrice Roncato Villa
L’ultimo atto degli altri.
La sacrosanta volta in cui presi la decisione di avvicinarmi al corso per Cerimoniere Funebre nemmeno potevo immaginare che mi avrebbe stravolto la vita, stravolto le morti. Fu come quando finalmente decisi di accostarmi al mondo della tanatoestetica: per molti anni, ero poco più che ventenne, evitai di osare per paura del giudizio altrui, sempre troppo tagliente e poco alleato, che nel corso del tempo mi ha fatto credere che tutto ciò fosse solo per menti non proprio stereotipate secondo le sacre leggi della massa. Ebbene, c’è sempre un momento nella propria esistenza, una scintilla ghiacciata, in cui ci si rende conto di “non vivere” per accontentare gli altri o di “non vivere proprio” ragionando in tal modo. I passi misurati al millimetro quando feci il corso di tanatoprassi si sono poi rivelati una piacevole spinta in avanti, facendomi recuperare speranze e fatiche in un mondo tanto particolare quanto delicato. Però non mi bastava, no. Lavorare “dietro le quinte” mette in ombra gli occhi degli altri davanti a ciò che è il lavoro che si fa per non disturbarne la vista: chi è del mestiere comprende che dialogare con la morte altrui è affare spiacevole allo sguardo accusatore di quegli umani che non accettano, né sanno accogliere, l’ultimo atto degli altri. Un pensiero si è impresso nella mia mente da un po’ di anni. Passiamo una vita intera a costruirci, a erigere la nostra immagine e la nostra identità, nel bene e nel male, giusta o sbagliata che sia. Viviamo di particolari, siamo ossessionati nell’apparire perfetti prototipi quando passeggiamo per quelle lunghe e affollate strade tra corpi incapaci di stare fermi e luci accattivanti che ci invitano ad entrare nei negozi solo per invogliarci ad adornare quella stessa nostra identità quando in realtà altro non siamo che prodotti di catene di montaggio. Insomma, l’esistenza pare ridursi ad una proposta seducente del sé e sempre eterna, mai imperfetta. Eppure, pochi di noi pensano a… cosa vorrei lasciare, di me? Cosa vorrei che gli altri ricordassero di me? Per quanto sottile, questo pensiero non si aggrappa se non a quelle menti più avezze al pensiero della propria impermanenza: spesso e volentieri, infatti, la maggior parte delle persone non si cura di cosa vorrebbe fosse detto… il giorno del proprio funerale. A tale proposito, vista la mia deliziosa sete di curiosità, mi accade di dialogare (anche) con estranei in merito al proprio ultimo spettacolo su quel palcoscenico che è l’esistenza. Molti rimangono inghiottiti in una spirale di ammutolimento indecoroso o si lasciano andare alle più spietate conclusioni, evidenziando in realtà disagi e rimorsi. Pochi, invero, capiscono che nella loro unicità le persone trovano non difetti quanto pregi o virtù. Sarà mia premura raccontare, entro il sottile limite del rispetto altrui, qualche episodio a me rimasto intaccato come calcare sul cuore legato alle cerimonie, agli ultimi atti di cui mi sono presa cura. E inizio con L., moglie devota, madre severa, ma sincera, che mi parlò del marito, mancato dopo una lunga malattia nella quale trovava conforto, rifugio e mai noia. Mai. Dopo diversi anni di matrimonio, giusto il tempo di dissolversi nell’altro tanto da non distinguere più chi fosse l’uno e chi fosse l’altra, i piccoli difetti sono divenuti enormi mancanze nella vita quotidiana. E ne elenco alcuni che mi trovai a proferire ad alta voce, con il cuore in mano da una parte e un viscerale ammonimento dall’altra, il giorno della cerimonia. Non mi abituerò mai a fare miei, a tenere tra le mani i gesti più intimi e sinceri della vita delle persone: quel giorno, e me ne resi conto solo mentre leggevo e non mentre preparavo il discorso, capii che ci si può aggrappare, nel più profondo buio dello sconforto, a quei fastidi e a quei meccanismi anche legati a circostanze spiacevoli per cercare il vuoto assente di chi se ne va. Così L., che volle evidenziare come in quegli anni anche i panni sporchi del marito, lasciati barbaramente adagiati sul pavimento e mai nel cesto apposito, potessero lasciare la mancanza e il rammarico di non doverli più raccogliere dopo la sua dipartita. Che i baffi tagliati, lasciati sempre sul lavandino dopo la rasatura, erano solo un piccolo neo che sporcava il bianco candido della ceramica senza il quale, ora, L. non sente più la necessità di farsi accecare da quel candore dove non ritrova più le tracce del consorte. E la cenere sparsa sul tavolo, dove spesso le sue mani tremanti non erano più in grado di controllare la giusta distanza tra il posacenere ed il sigaro, che reclamava il proprio spazio nel solco tra l’indice ed il medio, ormai di cartapesta. Vi ho anche raccontato troppo, ma la Signora L. sa che, in fondo, ora le sue memorie sono anche un po’ mie. E le custodisco gelosamente nel mio cuore.
Beatrice Roncato Villa