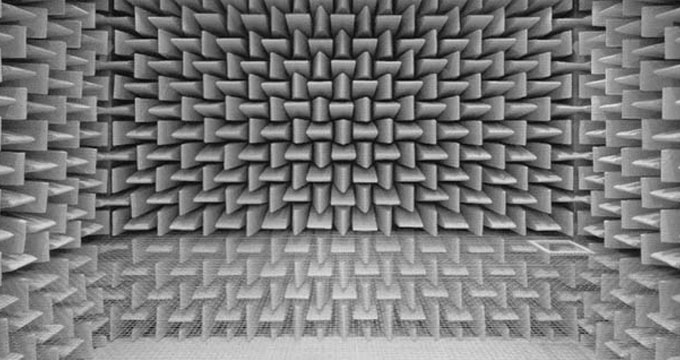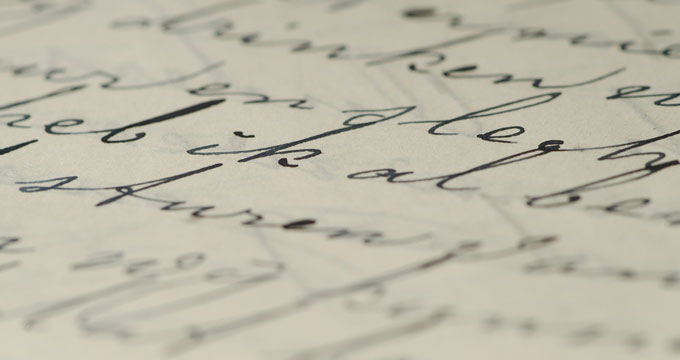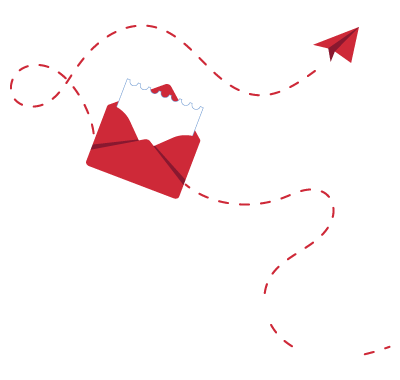La morte solitaria.
“Il modo in cui si muore dipende in non poca misura anche dalle possibilità che un individuo ha avuto di porsi, e di raggiungere, delle mete durante la sua vita. Dipende da quanto una persona, in punto di morte, sente d’aver trascorso una vita piena e sensata o vuota e senza senso” (Norbert Elias, 1982).
Mi imbatto talvolta in testi nei quali ritrovo alcuni pensieri e parole combinati alla perfezione che vorrei trasmettere parlando e che solo dal nulla, secondo scelte intutive basate sulla sola copertina o sul titolo del testo, si presentano a me come un ospite gradito, ma inaspettato, che devi far entrare in casa nonostante il caos che occupa ogni spazio. Avete presente, quando andate in libreria, ronzate intorno allo scaffale di quel libro che, alla fine, non comprate mai. Magari aspettate che ve lo regali qualcuno. Magari passano anni e lo spazio vergine della biblioteca di casa dove starebbe proprio bene rimane vuoto, solitario.
Talvolta mi accade di scontrarmi con pensieri anch’essi solitari, nel petrolio della notte, su quanto effettivamente io mi sia posta o mi stia ponendo nei confronti della vita. La solitudine, il Tu per tu con assenze dettate da Dpcm illogici e imbarazzanti, ha messo a dura prova la pazienza che ciascuno di noi nutre nei confronti del sé, del mondo e della vita con gli altri. Forse a distanza di un anno, come uno schiaffo in faccia certamente non meritato, abbiamo compreso l’importanza dell’addio o dell’arrivederci, visti i numeri ormai innominabili, gli innumerevoli abbracci troncati dalla distanza e dal contatto impossibile, il divieto di incontrarsi.
Ci siamo mai posti nei panni di coloro che soffrono rinchiusi tra vetrate e stanze dozzinali, dove l’odore di alcol e di mensa ormai ha soppiantato quello degli affetti e dell’intimità? Mi capitò sotto mano questa frase, ma non ricordo in quale libro: “ci sono solo due giorni in cui non viviamo 24 ore: quando veniamo al mondo e quando moriamo”. Alt! Fermi tutti! La consapevolezza ti salta addosso come una pulce in un campo dove sono appena passate orde di agnelli. Veniamo al mondo soli, strappati dal calore di una placenta che è stata dimora temporanea solo nostra, di nessun altro, e ce ne andiamo altrettanto soli, perché riguarda solo noi e l’Oltre. Questo aspetto mi ha fatto riflettere non poco: in realtà, in epoca contemporanea abbiamo sviluppato una sorta di ambivalenza: riusciamo ad identificarci un po’ di più con chi se ne sta andando e con chi soffre, ma, ed è qui che cadiamo nel vuoto, rimuoviamo lo spettacolo della morte dagli aspetti pubblici, se non in forma ironica o evidenziandone esclusivamente la sfumatura asettica della dimensione sanitaria. Dimenticandoci, dunque, di quella sua parte più umana e naturale, universale. La civilizzazione ha comportato tutto ciò: il morente, sempre più isolato dai suoi affetti più teneri, è a sua volta protagonista di quel controllo affettivo e delle pulsioni che dipende da un processo di pacificazione interna. Viviamo entro una cornice di senso dove dobbiamo controllare i nostri impulsi, valicando però i nostri limiti come e quanto vogliamo. Tutto ciò è paradossale: siamo smaniosi di libertà talvolta immeritate. Cerchiamo la passione sfrenata, quella che ci fa sentire vivi non per il gusto di farlo, per imparare, bensì per soffocare il disagio nei confronti della morte stessa: controlliamo i nostri sentimenti, evitiamo di mostrarci in lacrime davanti agli altri, soffochiamo la nostra ancestrale umanità. Evitiamo per lo più i contatti umani, non vogliamo soffrire. Ci dedichiamo alla felicità imposta, sterile di condanne emozionali. Tutto questo si riversa sullo sviluppo di una incapacità meccanica nell’identificarci con gli altri individui: ci ritiriamo dinnanzi all’immagine di un moribondo, delle sofferenze che indossa; e chi è al di fuori della professione evita quando accade di doversi prendere cura della salma, preferendo semmai visite sporadiche presso il camposanto. Penso sia quindi più che doveroso chiedersi se tutta la congiura del silenzio in cui siamo coinvolti, e in cui piace immergerci come in una vasca calda, nel lungo periodo non sia tanto inopportuna quanto pericolosa, soprattutto per le ripercussioni nella vita collettiva. A rifletterci bene, però, ci renderemmo conto che non è tanto la morte quanto la sua rappresentazione anticipatoria ad incutere terrore. Ed è da qui che dobbiamo partire per comprendere se abbiamo perso importanza davanti agli occhi degli altri. Solo attraverso tale consapevolezza riusciremo a sviluppare vortici empatici nei confronti della vita nostra e altrui.
Beatrice Roncato Villa
La morte solitaria.
“Il modo in cui si muore dipende in non poca misura anche dalle possibilità che un individuo ha avuto di porsi, e di raggiungere, delle mete durante la sua vita. Dipende da quanto una persona, in punto di morte, sente d’aver trascorso una vita piena e sensata o vuota e senza senso” (Norbert Elias, 1982).
Mi imbatto talvolta in testi nei quali ritrovo alcuni pensieri e parole combinati alla perfezione che vorrei trasmettere parlando e che solo dal nulla, secondo scelte intutive basate sulla sola copertina o sul titolo del testo, si presentano a me come un ospite gradito, ma inaspettato, che devi far entrare in casa nonostante il caos che occupa ogni spazio. Avete presente, quando andate in libreria, ronzate intorno allo scaffale di quel libro che, alla fine, non comprate mai. Magari aspettate che ve lo regali qualcuno. Magari passano anni e lo spazio vergine della biblioteca di casa dove starebbe proprio bene rimane vuoto, solitario.
Talvolta mi accade di scontrarmi con pensieri anch’essi solitari, nel petrolio della notte, su quanto effettivamente io mi sia posta o mi stia ponendo nei confronti della vita. La solitudine, il Tu per tu con assenze dettate da Dpcm illogici e imbarazzanti, ha messo a dura prova la pazienza che ciascuno di noi nutre nei confronti del sé, del mondo e della vita con gli altri. Forse a distanza di un anno, come uno schiaffo in faccia certamente non meritato, abbiamo compreso l’importanza dell’addio o dell’arrivederci, visti i numeri ormai innominabili, gli innumerevoli abbracci troncati dalla distanza e dal contatto impossibile, il divieto di incontrarsi.
Ci siamo mai posti nei panni di coloro che soffrono rinchiusi tra vetrate e stanze dozzinali, dove l’odore di alcol e di mensa ormai ha soppiantato quello degli affetti e dell’intimità? Mi capitò sotto mano questa frase, ma non ricordo in quale libro: “ci sono solo due giorni in cui non viviamo 24 ore: quando veniamo al mondo e quando moriamo”. Alt! Fermi tutti! La consapevolezza ti salta addosso come una pulce in un campo dove sono appena passate orde di agnelli. Veniamo al mondo soli, strappati dal calore di una placenta che è stata dimora temporanea solo nostra, di nessun altro, e ce ne andiamo altrettanto soli, perché riguarda solo noi e l’Oltre. Questo aspetto mi ha fatto riflettere non poco: in realtà, in epoca contemporanea abbiamo sviluppato una sorta di ambivalenza: riusciamo ad identificarci un po’ di più con chi se ne sta andando e con chi soffre, ma, ed è qui che cadiamo nel vuoto, rimuoviamo lo spettacolo della morte dagli aspetti pubblici, se non in forma ironica o evidenziandone esclusivamente la sfumatura asettica della dimensione sanitaria. Dimenticandoci, dunque, di quella sua parte più umana e naturale, universale. La civilizzazione ha comportato tutto ciò: il morente, sempre più isolato dai suoi affetti più teneri, è a sua volta protagonista di quel controllo affettivo e delle pulsioni che dipende da un processo di pacificazione interna. Viviamo entro una cornice di senso dove dobbiamo controllare i nostri impulsi, valicando però i nostri limiti come e quanto vogliamo. Tutto ciò è paradossale: siamo smaniosi di libertà talvolta immeritate. Cerchiamo la passione sfrenata, quella che ci fa sentire vivi non per il gusto di farlo, per imparare, bensì per soffocare il disagio nei confronti della morte stessa: controlliamo i nostri sentimenti, evitiamo di mostrarci in lacrime davanti agli altri, soffochiamo la nostra ancestrale umanità. Evitiamo per lo più i contatti umani, non vogliamo soffrire. Ci dedichiamo alla felicità imposta, sterile di condanne emozionali. Tutto questo si riversa sullo sviluppo di una incapacità meccanica nell’identificarci con gli altri individui: ci ritiriamo dinnanzi all’immagine di un moribondo, delle sofferenze che indossa; e chi è al di fuori della professione evita quando accade di doversi prendere cura della salma, preferendo semmai visite sporadiche presso il camposanto. Penso sia quindi più che doveroso chiedersi se tutta la congiura del silenzio in cui siamo coinvolti, e in cui piace immergerci come in una vasca calda, nel lungo periodo non sia tanto inopportuna quanto pericolosa, soprattutto per le ripercussioni nella vita collettiva. A rifletterci bene, però, ci renderemmo conto che non è tanto la morte quanto la sua rappresentazione anticipatoria ad incutere terrore. Ed è da qui che dobbiamo partire per comprendere se abbiamo perso importanza davanti agli occhi degli altri. Solo attraverso tale consapevolezza riusciremo a sviluppare vortici empatici nei confronti della vita nostra e altrui.
Beatrice Roncato Villa