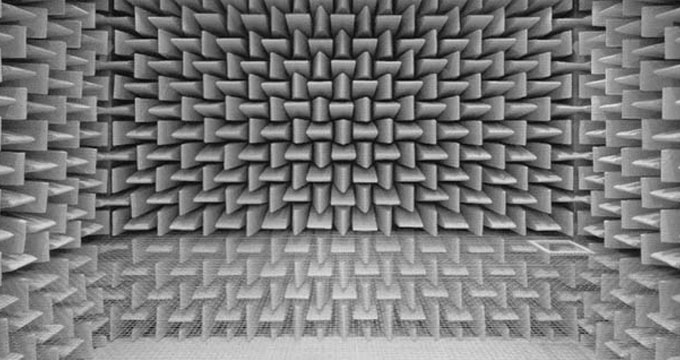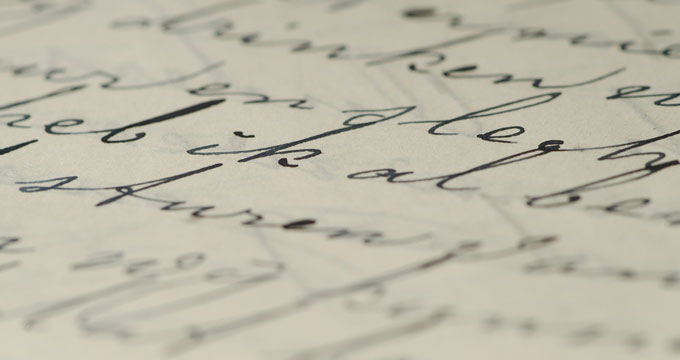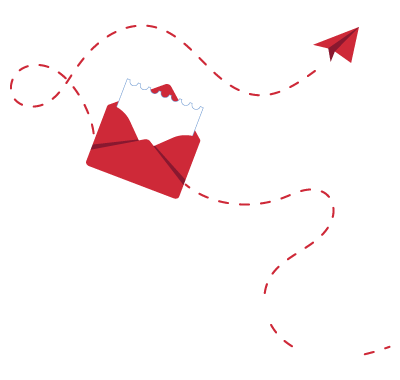La giusta distanza.
Bollettino di dicembre: mese adornato e accolto con una lacrima di neve.
La neve che non attacca, quella che passa troppo gentilmente per lasciare traccia di sé, giusto per rendere tutto più sporco e appiccicaticcio sotto le scarpe, sopra le macchine, tra le dita delle mani, sui balconi mai sazi di coltre bianca.
L’ultimo mese dell’anno è sempre quello della gestazione, lunghissima, dei mesi passati: si fa un confronto con l’inizio e si tirano le somme del tempo tiranno. Solo che di questo 2020 più che somme sono numeri dislocati, sfrattati, per niente certi, cifre mai definitive per lo più legate alla perdita degli altri, ma anche al ritrovamento di noi stessi. La circostanza ci ha resi più vulnerabili nei confronti del mondo, degli altri e, soprattutto, del sè: da quanto non eravamo a tu per tu con il nostro essere, con la nostra solitudine? Osservo le parole che non riescono più a trattenersi nel salotto delle labbra e delle voci di chi mi circonda: “no, io ho bisogno degli altri, non riesco a stare da solo”, e “no, a stare da solo impazzisco”.
A nessuno fa piacere fare i conti con sé stesso, impegnati come siamo a non accorgerci mai della nostra presenza nel mondo, troppo presi dall’assenza degli altri che, nella loro mancanza, ci rendono vulnerabili ed incapaci di fare quattro chiacchiere con il nostro, solo nostro, “Io”. Che dire, dunque, della solitudine di dicembre? Mese che deve fare i conti con il passato, che non ha mai una propria identità e che viene dimenticato, poi, con il parto di gennaio, mese prepotente ricolmo di speranze che si auspica vengano esaudite nell’anno a venire.
Ma chi può avere la testa già proiettata all’anno venturo? Da poche ore il nuovo decreto ha emesso sentenza: Natale (non) con i Tuoi (affetti). Abbiamo perso molto, c’è chi ha perso tutto, ma nonostante le perdite continuiamo a comportarci come vasi da cui straripa acqua che non possiedono. L’idea della solitudine cammina sgomitando nei pensieri di chi non vede i parenti da mesi, viste le restrizioni e visto un lockdown dispotico e incapace di governare branchi di persone che l’attesa non hanno mai imparato a domarla. Tra coloro che hanno perduto qualcuno non ha molta importanza passare il Natale o il Capodanno (si, è un danno) tra festoni, luci disturbanti e cenoni degni di un plotone ingordo. Non ha importanza alcuna. Il 2020 si porta lo strascico di un abito da sposa nero, di velluto pesante, che lascia una scia dal rumore troppo frastornante, da cui urge un divorzio propizio con l’avvento del nuovo anno. Basta fare un giro in cimitero per comprendere come i legami terreni siano dissolubili e pregni di connessioni con l’altrove, soprattutto durante queste feste. I piccoli alberi di Natale posti sulle lapidi, i minuscoli pacchetti di carta lucida che in realtà cullano cubetti di polistirolo, giusto per far scena, e le ghirlande collocate sul ghiaino delle tombe. Non ci si dimentica mai dei propri morti nei giorni di Natale: le sedie e i posti a tavola vuoti, le decorazioni comprate in quel mercatino tanti anni fa e le statuine del presepe ormai mutilate dai troppi tirarle fuori/riporle dentro la scatola apposita sono una costante richiesta di attenzione da parte di chi, quegli addobbi, li ha tenuti tra le mani per aiutarci a fare l’albero, a preparare il presepe, a adornare la casa come fosse una bomboniera dorata, rossa, luccicante. C’è chi inizia a detestarlo, il Natale, c’è altresì chi ingozza il proprio horror vacui con tanti addobbi quanti ne basterebbero per ornare un buco nero. Non siamo mai capaci di ottemperare alla giusta distanza. Di quella capacità di goderci l’esistenza qui e adesso nell’attesa di ottenere di più, sempre di più, per poi ricordarci in quei giorni in cui andiamo a cambiare l’acqua ai fiori al camposanto che avremmo dovuto assaporare i secondi, i minuti e le ore come un frutto tanto dolce, ma subito pronto a marcire.
Beatrice Roncato Villa
La giusta distanza.
Bollettino di dicembre: mese adornato e accolto con una lacrima di neve.
La neve che non attacca, quella che passa troppo gentilmente per lasciare traccia di sé, giusto per rendere tutto più sporco e appiccicaticcio sotto le scarpe, sopra le macchine, tra le dita delle mani, sui balconi mai sazi di coltre bianca.
L’ultimo mese dell’anno è sempre quello della gestazione, lunghissima, dei mesi passati: si fa un confronto con l’inizio e si tirano le somme del tempo tiranno. Solo che di questo 2020 più che somme sono numeri dislocati, sfrattati, per niente certi, cifre mai definitive per lo più legate alla perdita degli altri, ma anche al ritrovamento di noi stessi. La circostanza ci ha resi più vulnerabili nei confronti del mondo, degli altri e, soprattutto, del sè: da quanto non eravamo a tu per tu con il nostro essere, con la nostra solitudine? Osservo le parole che non riescono più a trattenersi nel salotto delle labbra e delle voci di chi mi circonda: “no, io ho bisogno degli altri, non riesco a stare da solo”, e “no, a stare da solo impazzisco”.
A nessuno fa piacere fare i conti con sé stesso, impegnati come siamo a non accorgerci mai della nostra presenza nel mondo, troppo presi dall’assenza degli altri che, nella loro mancanza, ci rendono vulnerabili ed incapaci di fare quattro chiacchiere con il nostro, solo nostro, “Io”. Che dire, dunque, della solitudine di dicembre? Mese che deve fare i conti con il passato, che non ha mai una propria identità e che viene dimenticato, poi, con il parto di gennaio, mese prepotente ricolmo di speranze che si auspica vengano esaudite nell’anno a venire.
Ma chi può avere la testa già proiettata all’anno venturo? Da poche ore il nuovo decreto ha emesso sentenza: Natale (non) con i Tuoi (affetti). Abbiamo perso molto, c’è chi ha perso tutto, ma nonostante le perdite continuiamo a comportarci come vasi da cui straripa acqua che non possiedono. L’idea della solitudine cammina sgomitando nei pensieri di chi non vede i parenti da mesi, viste le restrizioni e visto un lockdown dispotico e incapace di governare branchi di persone che l’attesa non hanno mai imparato a domarla. Tra coloro che hanno perduto qualcuno non ha molta importanza passare il Natale o il Capodanno (si, è un danno) tra festoni, luci disturbanti e cenoni degni di un plotone ingordo. Non ha importanza alcuna. Il 2020 si porta lo strascico di un abito da sposa nero, di velluto pesante, che lascia una scia dal rumore troppo frastornante, da cui urge un divorzio propizio con l’avvento del nuovo anno. Basta fare un giro in cimitero per comprendere come i legami terreni siano dissolubili e pregni di connessioni con l’altrove, soprattutto durante queste feste. I piccoli alberi di Natale posti sulle lapidi, i minuscoli pacchetti di carta lucida che in realtà cullano cubetti di polistirolo, giusto per far scena, e le ghirlande collocate sul ghiaino delle tombe. Non ci si dimentica mai dei propri morti nei giorni di Natale: le sedie e i posti a tavola vuoti, le decorazioni comprate in quel mercatino tanti anni fa e le statuine del presepe ormai mutilate dai troppi tirarle fuori/riporle dentro la scatola apposita sono una costante richiesta di attenzione da parte di chi, quegli addobbi, li ha tenuti tra le mani per aiutarci a fare l’albero, a preparare il presepe, a adornare la casa come fosse una bomboniera dorata, rossa, luccicante. C’è chi inizia a detestarlo, il Natale, c’è altresì chi ingozza il proprio horror vacui con tanti addobbi quanti ne basterebbero per ornare un buco nero. Non siamo mai capaci di ottemperare alla giusta distanza. Di quella capacità di goderci l’esistenza qui e adesso nell’attesa di ottenere di più, sempre di più, per poi ricordarci in quei giorni in cui andiamo a cambiare l’acqua ai fiori al camposanto che avremmo dovuto assaporare i secondi, i minuti e le ore come un frutto tanto dolce, ma subito pronto a marcire.
Beatrice Roncato Villa