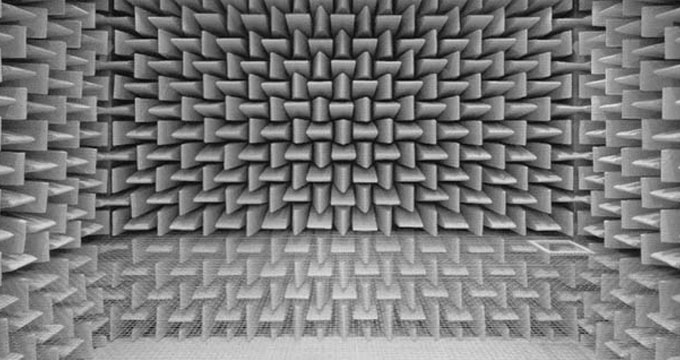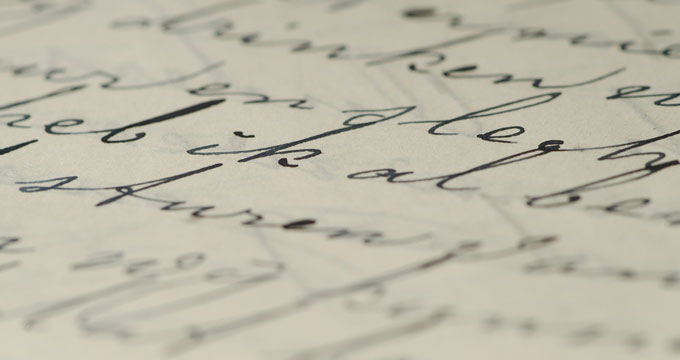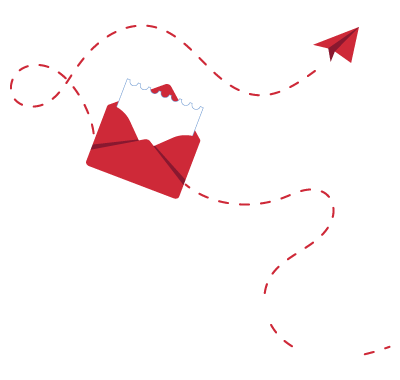Gli abbracci spezzati.
Ottobre… Un mese saturo di cambiamenti più (o meno) radicali. Nascite, rinascite, perdite, ritorni, aperture, chiusure, speranze dal colore delle foglie di alberi che creano un tetto surreale rendendo la città un luogo più confortevole e pronto a ricevere timide nevicate invernali. I primi freddi nascondono sempre qualcosa: i corpi delle persone, come fantocci festosi, si aggirano coperti da mille strati per proteggersi dal vento il cui soffio non è mai sincero: può scompigliarti i capelli, disturbarti la gola, far emozionare gli occhi troppo fragili per accogliere l’aria impalpabile e ghiacciata. I corpi danzano ad un ritmo più veloce: si cerca il tepore di un locale, di un negozio, di una biblioteca. Fermi non si riesce a stare.
Il neonato gelo di ogni anno fa anche questo: nasconde le forme, rimodellandole a suo piacimento sotto cappotti, giacche, giacconi e sciarpe, sciarpette e sciarponi che privano i viandanti di una propria identità e di una forma comportando una sfumatura buffa nell’andamento in cui la volontà non riesce a seguire i ritmi del corpo, troppo infreddolito per mantenere fede a quella voglia di produrre passi più generosi. I cappotti sono utili più volte. Per chi li indossa, per più anni, e per chi rimane. C’è chi in quei cappotti, senza più padrone, ritrova abbracci spezzati, le ultime cure che ci si impone per non raffreddarsi, per non ammalarsi, in ricordo di quegli stessi abbracci che si era soliti scambiarsi. I nostri armadi si ingravidano in un batter d’occhio: mille vestiti per altrettante occasioni, o mille vestiti che non si usano mai, o, ancora, un vestito usato talmente tanto da lasciare tracce della violenza degli anni passati.
È la storia del cappotto del papà di G. Qualche tempo fa, incontrandola a vagare per la città, muta e grigia, mi resi conto che effettivamente quel cappotto era di qualche taglia in più rispetto alle sue forme esili e insicure. La invitai per un caffè, come si fa in quei momenti in cui nella giornata avanza un tempo ritrovato, un tempo che si può ancora sfruttare prima di rivolgersi, nel crepuscolo, ai volti delle proprie case. Nonostante il colore nero stinto del giaccone, replicò con un sorriso che proprio non era in sintonia con quella mise. Il volto di una figlia, per lo più giovane, a cui viene mancare il padre custodisce smorfie e andamenti sepolti in quei tratti non riscontrabili altrove. La sua storia è legata a quel cappotto, al cappotto del papà, di cui porta con fierezza cuciture, scuciture, macchie smacchiate e maniche più lunghe delle braccia. “Perché mai lo indossi?”. “Qui ritrovo i suoi abbracci”. Lo disse in modo tale da farmi sentire il corpo sciogliersi, verso il pavimento, lo disse in modo tale che potei sentire la sensazione di quando abbracci chi di ricambiare quell’abbraccio proprio non ne vuol sapere. Ma non le interessava: il profumo dimorava ancora in quel colletto, in quelle spalle e lungo la schiena. Confidava in un abbraccio invisibile, ma presente. Confidava nel mio accogliere e comprendere quel suo senso di dolore e di vuoto che le divorava lo stomaco e che io non voglio neppure immaginare.
È strano come ci si affezioni agli oggetti, che siano un cappotto o un maglione, un fermaglio, una tazza, un pupazzo, un anello, un paio di orecchini, una coperta, un ciondolo, un pettine, un biglietto scritto. Tutti oggetti passati tra le mani di coloro che amavamo e con i cui fantasmi dobbiamo solamente accontentarci di comunicare. Questi oggetti transizionali altro non hanno che l’effetto di illuderci di una presenza non riposta dove era solita dimorare. Potremmo trovarci i segni delle mani, delle labbra, di lacrime, di emozioni a noi sconosciute, ma appartenute ai nostri cari. Così quel suo cappotto era un abbraccio per lei invisibile, ma sincero. Il ritrovo di un’assenza nata proprio nel mese di ottobre, il mese dove molte sfumature tendono a non accontentarsi più del susseguirsi delle stagioni, di insane abitudini o di vedere il proprio corpo mutare.
Lo dedico a tutti i miei abbracci lasciati a metà, agli abbracci mai dati, a quelli dati senza consapevolezza che sarebbero stati gli ultimi.
Beatrice Roncato Villa
Gli abbracci spezzati.
Ottobre… Un mese saturo di cambiamenti più (o meno) radicali. Nascite, rinascite, perdite, ritorni, aperture, chiusure, speranze dal colore delle foglie di alberi che creano un tetto surreale rendendo la città un luogo più confortevole e pronto a ricevere timide nevicate invernali. I primi freddi nascondono sempre qualcosa: i corpi delle persone, come fantocci festosi, si aggirano coperti da mille strati per proteggersi dal vento il cui soffio non è mai sincero: può scompigliarti i capelli, disturbarti la gola, far emozionare gli occhi troppo fragili per accogliere l’aria impalpabile e ghiacciata. I corpi danzano ad un ritmo più veloce: si cerca il tepore di un locale, di un negozio, di una biblioteca. Fermi non si riesce a stare.
Il neonato gelo di ogni anno fa anche questo: nasconde le forme, rimodellandole a suo piacimento sotto cappotti, giacche, giacconi e sciarpe, sciarpette e sciarponi che privano i viandanti di una propria identità e di una forma comportando una sfumatura buffa nell’andamento in cui la volontà non riesce a seguire i ritmi del corpo, troppo infreddolito per mantenere fede a quella voglia di produrre passi più generosi. I cappotti sono utili più volte. Per chi li indossa, per più anni, e per chi rimane. C’è chi in quei cappotti, senza più padrone, ritrova abbracci spezzati, le ultime cure che ci si impone per non raffreddarsi, per non ammalarsi, in ricordo di quegli stessi abbracci che si era soliti scambiarsi. I nostri armadi si ingravidano in un batter d’occhio: mille vestiti per altrettante occasioni, o mille vestiti che non si usano mai, o, ancora, un vestito usato talmente tanto da lasciare tracce della violenza degli anni passati.
È la storia del cappotto del papà di G. Qualche tempo fa, incontrandola a vagare per la città, muta e grigia, mi resi conto che effettivamente quel cappotto era di qualche taglia in più rispetto alle sue forme esili e insicure. La invitai per un caffè, come si fa in quei momenti in cui nella giornata avanza un tempo ritrovato, un tempo che si può ancora sfruttare prima di rivolgersi, nel crepuscolo, ai volti delle proprie case. Nonostante il colore nero stinto del giaccone, replicò con un sorriso che proprio non era in sintonia con quella mise. Il volto di una figlia, per lo più giovane, a cui viene mancare il padre custodisce smorfie e andamenti sepolti in quei tratti non riscontrabili altrove. La sua storia è legata a quel cappotto, al cappotto del papà, di cui porta con fierezza cuciture, scuciture, macchie smacchiate e maniche più lunghe delle braccia. “Perché mai lo indossi?”. “Qui ritrovo i suoi abbracci”. Lo disse in modo tale da farmi sentire il corpo sciogliersi, verso il pavimento, lo disse in modo tale che potei sentire la sensazione di quando abbracci chi di ricambiare quell’abbraccio proprio non ne vuol sapere. Ma non le interessava: il profumo dimorava ancora in quel colletto, in quelle spalle e lungo la schiena. Confidava in un abbraccio invisibile, ma presente. Confidava nel mio accogliere e comprendere quel suo senso di dolore e di vuoto che le divorava lo stomaco e che io non voglio neppure immaginare.
È strano come ci si affezioni agli oggetti, che siano un cappotto o un maglione, un fermaglio, una tazza, un pupazzo, un anello, un paio di orecchini, una coperta, un ciondolo, un pettine, un biglietto scritto. Tutti oggetti passati tra le mani di coloro che amavamo e con i cui fantasmi dobbiamo solamente accontentarci di comunicare. Questi oggetti transizionali altro non hanno che l’effetto di illuderci di una presenza non riposta dove era solita dimorare. Potremmo trovarci i segni delle mani, delle labbra, di lacrime, di emozioni a noi sconosciute, ma appartenute ai nostri cari. Così quel suo cappotto era un abbraccio per lei invisibile, ma sincero. Il ritrovo di un’assenza nata proprio nel mese di ottobre, il mese dove molte sfumature tendono a non accontentarsi più del susseguirsi delle stagioni, di insane abitudini o di vedere il proprio corpo mutare.
Lo dedico a tutti i miei abbracci lasciati a metà, agli abbracci mai dati, a quelli dati senza consapevolezza che sarebbero stati gli ultimi.
Beatrice Roncato Villa