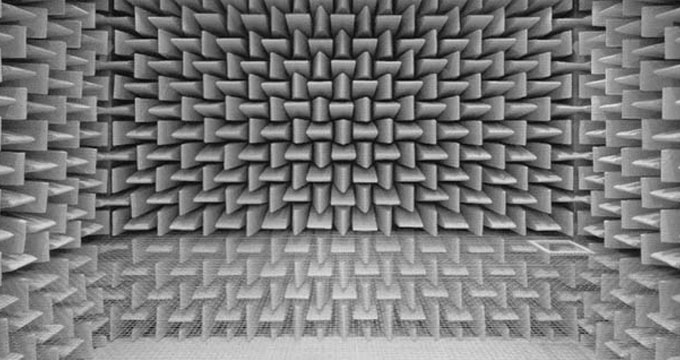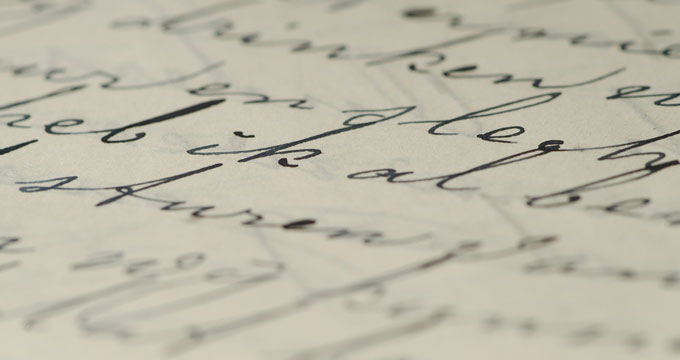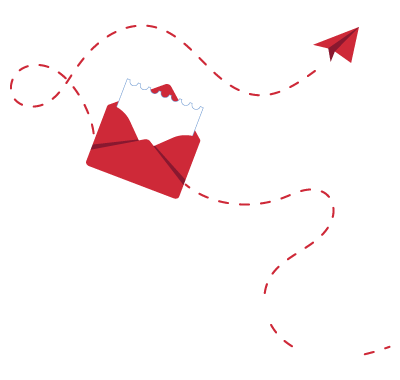E che non sia un’illusione.

L’inerzia del sole di marzo non conosce i limiti dettati dalla ragione umana: le strade si svuotano di nuovo, con qualche eccezione che spunta come un neo sulla nuda pelle, di quelli che non danno fastidio allo sguardo, che passano oltre, ma che impongono la propria presenza.
Così i meccanismi della terra sembrano non curarsi di divieto alcuno: i colori esplodono, persino il mio pesco, con inaspettata dolcezza, ha partorito i primissimi fiori a poco meno di un anno dalla sepoltura delle sue radici nel giardino. Ogni pianta è una piccola fossa, una piccola tomba: segna che lì, proprio lì, vi è sepolto qualcosa, ma che pulsa e che vive nascosto agli occhi troppo impegnati a roteare sui fiori in superficie.
Trovo una sorta di melanconia atavica quando accarezzo i rami o le piante che negli anni ho visto crescere e che a loro volta mi hanno vista mutare: alberi presenti ai pranzi di famiglia nella casa di campagna, il glicine annoiato dalle tendenze suicidarie che rimane sospeso sulla ringhiera del terrazzo, i vasi straripanti di semi raccolti nei viaggi passati di cui si sono persi il conto e la memoria.
Le piante però rimangono, nonostante cambino le mani che le curano, da quelle più giovani e inesperte a quelle che fanno fatica, poco a poco, a potare anche una singola foglia non reggendo alla pesantezza di una cesoia ormai arrogantemente arrugginita.
Guardo piante, piantine, fiori e alberi che mi hanno accompagnata dall’infanzia e involontariamente ripercorro fasi e dispiaceri che mi appartengono. A tale proposito mi accarezzava il pensiero una di quelle frasi che ti corrodono le vene da quanto il dolore si fa materia di seguito a una perdita. Frasi che mi fanno visita dal nulla, ospiti (in)desiderati durante una passeggiata proprio mentre porto i fiori al cimitero.
Dimmi che non è vero, che non te ne sei andato.
Dimmi che è solo uno scherzo di pessimo gusto, di quelli che germogliano da buone intenzioni e che poi, affascinati da sadico divertimento, oltrepassano il confine del gioco.
Dimmi che è solo un sogno, o meglio un incubo, di quelli da cui ti svegli fradicio di sudore e con un cerchio alla testa degno di una caduta dal decimo piano.
E dimmi anche che domani, quando mi sveglierò, tu sarai ancora qui, o lì, tra le tue cose e le tue abitudini più strette, quelle del caffè delle 7 e 30 del mattino dove puoi udire solo il rumore dell’alba.
Dimmi che ti ritroverò in un abbraccio o una carezza, per una telefonata in preda al panico di una giornata malmostosa e indecente, di quelle che ti fanno perdere la pazienza nei confronti del mondo.
Dimmi che puoi ascoltarmi, o che puoi sentirmi, o dimmi che le mie orecchie potranno udire ancora il suono della tua voce a me così familiare e irrinunciabile, come la coperta di quando si è neonati e che puntualmente trasloca ogni volta che viaggio altrove.
Promettimi che il distacco non sarà mai eterno e che non sia un’illusione il ritrovarsi lì, nei nostri luoghi, dove tanto ho imparato e dove molto ho dimenticato.
Alle piante immortali, ai semi ancora da piantare, ai fiori che si rifiutano di morire.
Beatrice Roncato Villa
L’inerzia del sole di marzo non conosce i limiti dettati dalla ragione umana: le strade si svuotano di nuovo, con qualche eccezione che spunta come un neo sulla nuda pelle, di quelli che non danno fastidio allo sguardo, che passano oltre, ma che impongono la propria presenza.
Così i meccanismi della terra sembrano non curarsi di divieto alcuno: i colori esplodono, persino il mio pesco, con inaspettata dolcezza, ha partorito i primissimi fiori a poco meno di un anno dalla sepoltura delle sue radici nel giardino. Ogni pianta è una piccola fossa, una piccola tomba: segna che lì, proprio lì, vi è sepolto qualcosa, ma che pulsa e che vive nascosto agli occhi troppo impegnati a roteare sui fiori in superficie.
Trovo una sorta di melanconia atavica quando accarezzo i rami o le piante che negli anni ho visto crescere e che a loro volta mi hanno vista mutare: alberi presenti ai pranzi di famiglia nella casa di campagna, il glicine annoiato dalle tendenze suicidarie che rimane sospeso sulla ringhiera del terrazzo, i vasi straripanti di semi raccolti nei viaggi passati di cui si sono persi il conto e la memoria.
Le piante però rimangono, nonostante cambino le mani che le curano, da quelle più giovani e inesperte a quelle che fanno fatica, poco a poco, a potare anche una singola foglia non reggendo alla pesantezza di una cesoia ormai arrogantemente arrugginita.
Guardo piante, piantine, fiori e alberi che mi hanno accompagnata dall’infanzia e involontariamente ripercorro fasi e dispiaceri che mi appartengono. A tale proposito mi accarezzava il pensiero una di quelle frasi che ti corrodono le vene da quanto il dolore si fa materia di seguito a una perdita. Frasi che mi fanno visita dal nulla, ospiti (in)desiderati durante una passeggiata proprio mentre porto i fiori al cimitero.
Dimmi che non è vero, che non te ne sei andato.
Dimmi che è solo uno scherzo di pessimo gusto, di quelli che germogliano da buone intenzioni e che poi, affascinati da sadico divertimento, oltrepassano il confine del gioco.
Dimmi che è solo un sogno, o meglio un incubo, di quelli da cui ti svegli fradicio di sudore e con un cerchio alla testa degno di una caduta dal decimo piano.
E dimmi anche che domani, quando mi sveglierò, tu sarai ancora qui, o lì, tra le tue cose e le tue abitudini più strette, quelle del caffè delle 7 e 30 del mattino dove puoi udire solo il rumore dell’alba.
Dimmi che ti ritroverò in un abbraccio o una carezza, per una telefonata in preda al panico di una giornata malmostosa e indecente, di quelle che ti fanno perdere la pazienza nei confronti del mondo.
Dimmi che puoi ascoltarmi, o che puoi sentirmi, o dimmi che le mie orecchie potranno udire ancora il suono della tua voce a me così familiare e irrinunciabile, come la coperta di quando si è neonati e che puntualmente trasloca ogni volta che viaggio altrove.
Promettimi che il distacco non sarà mai eterno e che non sia un’illusione il ritrovarsi lì, nei nostri luoghi, dove tanto ho imparato e dove molto ho dimenticato.
Alle piante immortali, ai semi ancora da piantare, ai fiori che si rifiutano di morire.
Beatrice Roncato Villa