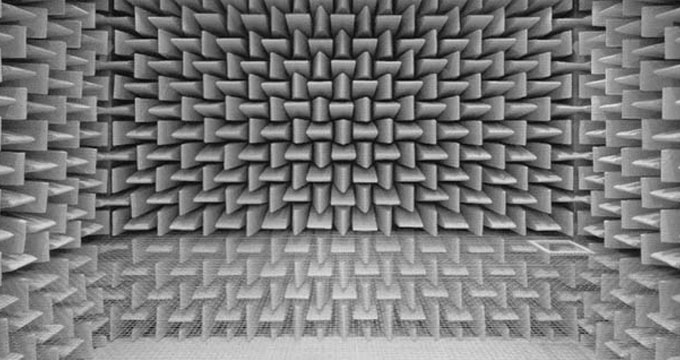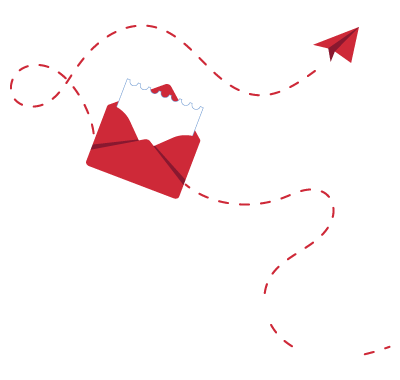Anche se non leggerai.
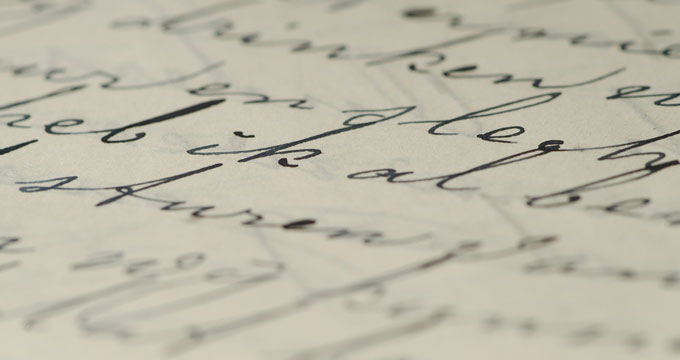
Parlare è poca cosa, spesso è preferibile rinunciare alla parola e avvolgersi nel silenzio: qualcuno diceva “le parole non sono necessarie, fanno solo del male”. Solo che il tempo si sa come galoppa, su quel cavallo di fumo: troppo veloce, troppo violento, a volte troppo lento e traditore, soprattutto quando ci togliamo la pelle nelle attese più meritevoli. E poi, sempre il tempo, porta via, in un cambio di tiro del vento, un affetto. L’anno inizia con un incontro al cimitero, la visita che puntualmente non manca per farmi comprendere che, nonostante le assenze di un tavolo dove mi sedevo sempre con la gamba che mi faceva mangiare ingobbita dalla scomodità, e le ormai mai più possibili telefonate di circostanza, certe presenze non se ne andranno mai.
Gennaio è tenero, accompagnato sempre da quella fermezza e da quella placidità di pensieri molli che mi attraversano la testa: anche se quest’anno la tenerezza sembrava potesse far posto all’incostanza (“e chi mai ha voglia di andare a trovare i parenti al cimitero, per iniziare questo 2021?”), una serie di ricordi si sono presentati, senza ovviamente bussare, alla mente annebbiata e annerita da fuliggine accumulata in un anno di perdite violente come colpi di mitragliatrice. Mi mancano certi abbracci, certe strette di quelle da farti penetrare le unghie nella schiena come per dire “non negarmi mai questo privilegio”, quelle strette che senti aprire un cosmo sotto i piedi appena l’abbraccio si spezza. Mi mancano quelle strette autentiche dopo mesi di assenza alla vista dovute a impegni che sembrano sempre più importanti di tutto il resto.
Ho scoperto l’importanza della parola recentemente, anche se di lettere ne ho sempre scritte, soprattutto a chi ho voluto bene. E il lutto ti riporta a quella dimensione per la quale le mani riscoprono l’inganno di non esser solo capaci di carezze e di pugni chiusi dallo sconforto e dalla rabbia, ma anche di scrivere, scrivere di perdita, di addii terreni e di sospesi soffocati. Sino a un anno fa, quando ancora il via vai era possibile ed entrare in camera ardente era normalità, ho visto passare moltissime lettere. Che fossero riposte con cura dal parente o posate tra le mie mani, come un mandante premuroso, non mi sono mai permessa di leggerle. Ho solo osato immaginare cosa si possa scrivere (anzi, lo so bene) in una lettera di arrivederci, mai di addio, al proprio caro. La carta è ingannevole, le lettere, le parole e le frasi sgomitano per accaparrarsi lo spazio con il dispotismo di non essere spezzate nell’andare a capo: un foglio bianco improvvisamente può divenire coriandolo per tutte le parole che si vorrebbero vomitare e che ci si pente di non aver detto quando ancora si poteva. Ma, lo sappiamo, il tempo del volere è sempre diverso dal tempo del potere: la coincidenza viene sempre persa, come quando manchi un treno nella presunzione di essere in orario ed invece ti ritrovi ad aspettare quello successivo, la cui attesa è estenuante.
Ci chiediamo se servano mai, certe lettere: sarà troppo tardi? Io, nel dubbio, la propongo e la ripongo con cura nel feretro. Magari nel taschino, magari dentro la giacca o magari sotto la schiena. Come quella volta che, più che una lettera, fu un bigliettino arrotolato tanto piccolo da occupare lo spazio di una semplice sigaretta spenta e poco ebbra di tabacco. Carta bianca, bordi rifiniti, non strappati. Giusta giusta per essere cullata sotto il palmo della mano, un piccolo segreto di quelli che sarebbero risorti e al contempo annientati nella morte del fuoco. Perché è questo, il bello: anche se non la leggerai mai, quella lettera racchiude cose, pensieri, scuse, perdoni mai annunciati che solo l’ultimo incontro può accogliere, protetto da una culla di legno che sa prendersi ben cura dei silenzi che in realtà senti rimbombare appena varchi la soglia del camposanto.
Alle mie lettere eterne e alle parole custodite con cura!
Beatrice Roncato Villa
Parlare è poca cosa, spesso è preferibile rinunciare alla parola e avvolgersi nel silenzio: qualcuno diceva “le parole non sono necessarie, fanno solo del male”. Solo che il tempo si sa come galoppa, su quel cavallo di fumo: troppo veloce, troppo violento, a volte troppo lento e traditore, soprattutto quando ci togliamo la pelle nelle attese più meritevoli. E poi, sempre il tempo, porta via, in un cambio di tiro del vento, un affetto. L’anno inizia con un incontro al cimitero, la visita che puntualmente non manca per farmi comprendere che, nonostante le assenze di un tavolo dove mi sedevo sempre con la gamba che mi faceva mangiare ingobbita dalla scomodità, e le ormai mai più possibili telefonate di circostanza, certe presenze non se ne andranno mai.
Gennaio è tenero, accompagnato sempre da quella fermezza e da quella placidità di pensieri molli che mi attraversano la testa: anche se quest’anno la tenerezza sembrava potesse far posto all’incostanza (“e chi mai ha voglia di andare a trovare i parenti al cimitero, per iniziare questo 2021?”), una serie di ricordi si sono presentati, senza ovviamente bussare, alla mente annebbiata e annerita da fuliggine accumulata in un anno di perdite violente come colpi di mitragliatrice. Mi mancano certi abbracci, certe strette di quelle da farti penetrare le unghie nella schiena come per dire “non negarmi mai questo privilegio”, quelle strette che senti aprire un cosmo sotto i piedi appena l’abbraccio si spezza. Mi mancano quelle strette autentiche dopo mesi di assenza alla vista dovute a impegni che sembrano sempre più importanti di tutto il resto.
Ho scoperto l’importanza della parola recentemente, anche se di lettere ne ho sempre scritte, soprattutto a chi ho voluto bene. E il lutto ti riporta a quella dimensione per la quale le mani riscoprono l’inganno di non esser solo capaci di carezze e di pugni chiusi dallo sconforto e dalla rabbia, ma anche di scrivere, scrivere di perdita, di addii terreni e di sospesi soffocati. Sino a un anno fa, quando ancora il via vai era possibile ed entrare in camera ardente era normalità, ho visto passare moltissime lettere. Che fossero riposte con cura dal parente o posate tra le mie mani, come un mandante premuroso, non mi sono mai permessa di leggerle. Ho solo osato immaginare cosa si possa scrivere (anzi, lo so bene) in una lettera di arrivederci, mai di addio, al proprio caro. La carta è ingannevole, le lettere, le parole e le frasi sgomitano per accaparrarsi lo spazio con il dispotismo di non essere spezzate nell’andare a capo: un foglio bianco improvvisamente può divenire coriandolo per tutte le parole che si vorrebbero vomitare e che ci si pente di non aver detto quando ancora si poteva. Ma, lo sappiamo, il tempo del volere è sempre diverso dal tempo del potere: la coincidenza viene sempre persa, come quando manchi un treno nella presunzione di essere in orario ed invece ti ritrovi ad aspettare quello successivo, la cui attesa è estenuante.
Ci chiediamo se servano mai, certe lettere: sarà troppo tardi? Io, nel dubbio, la propongo e la ripongo con cura nel feretro. Magari nel taschino, magari dentro la giacca o magari sotto la schiena. Come quella volta che, più che una lettera, fu un bigliettino arrotolato tanto piccolo da occupare lo spazio di una semplice sigaretta spenta e poco ebbra di tabacco. Carta bianca, bordi rifiniti, non strappati. Giusta giusta per essere cullata sotto il palmo della mano, un piccolo segreto di quelli che sarebbero risorti e al contempo annientati nella morte del fuoco. Perché è questo, il bello: anche se non la leggerai mai, quella lettera racchiude cose, pensieri, scuse, perdoni mai annunciati che solo l’ultimo incontro può accogliere, protetto da una culla di legno che sa prendersi ben cura dei silenzi che in realtà senti rimbombare appena varchi la soglia del camposanto.
Alle mie lettere eterne e alle parole custodite con cura!
Beatrice Roncato Villa