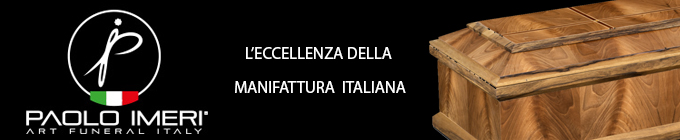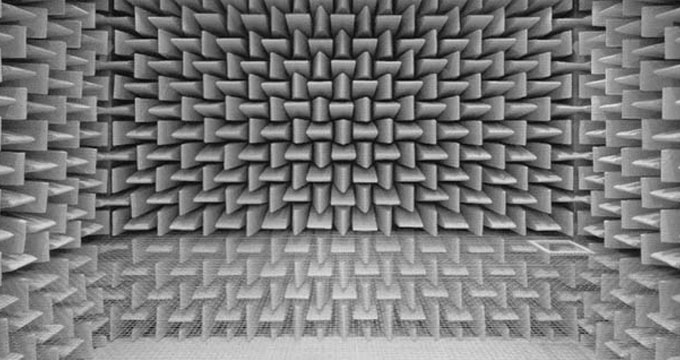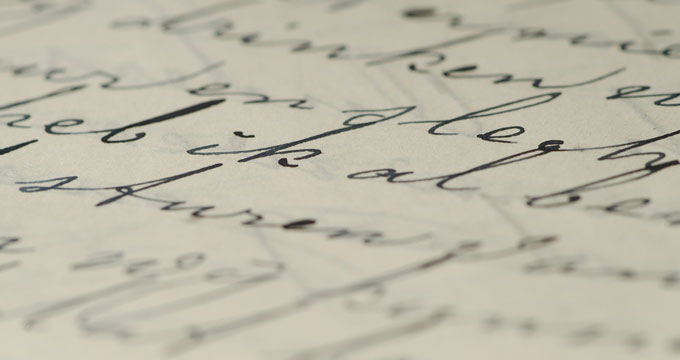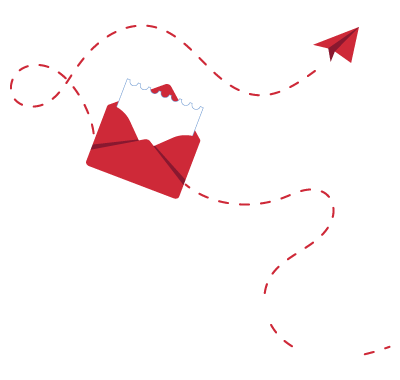Tra le mani.

Osservo spesso le mani delle persone: è un vizio a cui cedo volentieri le mie volontà e che lascio orfano raramente. Mi piace osservare il modo attraverso cui gli oggetti diventano in qualche modo succubi di questi arti: che sia una penna, un pezzo di carta, un fiore o un mucchio di terriccio, il senso di riservatezza delle mani supera di gran lunga quello di qualsiasi altra parte del nostro corpo. In fondo le mani sono fatte anche per questo: stringere, disegnare, deliziare uno strumento, comunicare, fermare, invitare e soprattutto accarezzare, accogliere.
Proprio alle carezze sono maggiormente grata: mi piace impadronirmi di quelle che svelo e che spoglio per strada, tra i passanti. Le carezze d’ingegno, quelle tattiche a seguito di una lite poco chiara e indesiderata, le carezze del padre ad un figlio che, per un passo falso, ha riempito la sua giornata con una caduta dal triciclo per la quale l’unico rimedio è una pronta moina da parte di mani adulte e protettrici.
Le carezze ci accompagnano lungo il corso della vita: penso di poter sentire sulle guance o sulla pelle quelle di mia madre da quando sono al mondo, materne e avvolgenti, o quelle di mio padre, sempre sicuramente troppo centellinate per via del suo spirito timido ed esitante.
Le carezze di conforto, di gioia, di pianto o di disperazione, quelle di benvenuto e quelle di un addio, quelle sulle braccia per confortare, quelle sui capelli per calmare.
Vi sono molti particolari che ci spingono ad amare una persona nel corso di una vita intera. Che sia un neo, di quelli nascosti e posti in un luogo strategico del corpo, o il colore degli occhi o anche il tono della voce. Ho sempre amato, dolcemente, l’usanza bizzarra di donare, per solo amore, una ciocca dei propri capelli al proprio amante. Una parte di te che se ne va, di cui ti privi, una parte di te che vaga per il mondo sfaldandosi e perdendosi. Orbene, di doni e di richieste strani ne ho vissuti e negoziati in molti casi, ma uno mi è rimasto colato nel cuore come lava. Il 2020 è germogliato come un fiore già marcio, di quelli che nonostante una cura ai limiti dell’asfissia proprio non ne vuole sapere di darsi alla vita o, in caso contrario, le si dona in modo storto e sgraziato.
Molti volti ho visti passare tra le mani, tra foto per epigrafi e ultime carezze di un addio, ma quegli occhi e quella camicia, di color rosso acceso a quadri neri che tanto mi ricorda melodie e colori della Scozia, fanno parte di quella raccolta privata di immagini che brutalmente non scorderò mai. Avete presente quando incroci uno sguardo su una foto, e non riesci proprio a staccartene? Nonostante non vi sia mai stato il rispecchiarsi reciproco, di quelli che ti fanno decifrare l’anima. Lessi solo poche parole: “improvvisamente/semplicità/rughe maturate come un’antica montagna senza padrone”. Quella immagine, nella sua incredibile spensieratezza, mi soffocò la voce se non per chiedere alla Vedova: “E qui, dov’era, il Suo E.?”. Nulla più, a dir la verità. E fu così che mi appropriai di un momento privato simile a quelli della mia infanzia, alle feste di compleanno dove incontrarsi era materia di condivisione e tempo inceppato, quello che solo certe ricorrenze riescono a svelare. Nel silenzio una richiesta, molto esile come uno spirito di carta, di quelle che ti straziano il cuore: “Potrei… non so se… potrei… forse no…”. Pausa, silenzio, vuoto, tempo terso. E poi di nuovo: “Potrei avere una sua ciocca di capelli?”. Il vuoto sotto i piedi, salvato solo da una nota amara e commovente fatta di occhi già lucidi, ma grati, mi riportò alla realtà, una realtà troppo intima per disconoscerla alla legittima proprietaria. Quando ci fu il modo, fu premura del collega riporla tra le mani di Lei, quella ciocca. Non mi sarà mai chiaro il meccanismo attraverso il quale ognuno di noi si avvinghia a certi tratti altrui. So solo che quella piccola danza di capelli, nel suo palmo, trovò conforto in una carezza priva di difese, una carezza di quelle entro la quale si riversa tutta la dolcezza del mondo.
Beatrice Roncato Villa
Osservo spesso le mani delle persone: è un vizio a cui cedo volentieri le mie volontà e che lascio orfano raramente. Mi piace osservare il modo attraverso cui gli oggetti diventano in qualche modo succubi di questi arti: che sia una penna, un pezzo di carta, un fiore o un mucchio di terriccio, il senso di riservatezza delle mani supera di gran lunga quello di qualsiasi altra parte del nostro corpo. In fondo le mani sono fatte anche per questo: stringere, disegnare, deliziare uno strumento, comunicare, fermare, invitare e soprattutto accarezzare, accogliere.
Proprio alle carezze sono maggiormente grata: mi piace impadronirmi di quelle che svelo e che spoglio per strada, tra i passanti. Le carezze d’ingegno, quelle tattiche a seguito di una lite poco chiara e indesiderata, le carezze del padre ad un figlio che, per un passo falso, ha riempito la sua giornata con una caduta dal triciclo per la quale l’unico rimedio è una pronta moina da parte di mani adulte e protettrici.
Le carezze ci accompagnano lungo il corso della vita: penso di poter sentire sulle guance o sulla pelle quelle di mia madre da quando sono al mondo, materne e avvolgenti, o quelle di mio padre, sempre sicuramente troppo centellinate per via del suo spirito timido ed esitante.
Le carezze di conforto, di gioia, di pianto o di disperazione, quelle di benvenuto e quelle di un addio, quelle sulle braccia per confortare, quelle sui capelli per calmare.
Vi sono molti particolari che ci spingono ad amare una persona nel corso di una vita intera. Che sia un neo, di quelli nascosti e posti in un luogo strategico del corpo, o il colore degli occhi o anche il tono della voce. Ho sempre amato, dolcemente, l’usanza bizzarra di donare, per solo amore, una ciocca dei propri capelli al proprio amante. Una parte di te che se ne va, di cui ti privi, una parte di te che vaga per il mondo sfaldandosi e perdendosi. Orbene, di doni e di richieste strani ne ho vissuti e negoziati in molti casi, ma uno mi è rimasto colato nel cuore come lava. Il 2020 è germogliato come un fiore già marcio, di quelli che nonostante una cura ai limiti dell’asfissia proprio non ne vuole sapere di darsi alla vita o, in caso contrario, le si dona in modo storto e sgraziato.
Molti volti ho visti passare tra le mani, tra foto per epigrafi e ultime carezze di un addio, ma quegli occhi e quella camicia, di color rosso acceso a quadri neri che tanto mi ricorda melodie e colori della Scozia, fanno parte di quella raccolta privata di immagini che brutalmente non scorderò mai. Avete presente quando incroci uno sguardo su una foto, e non riesci proprio a staccartene? Nonostante non vi sia mai stato il rispecchiarsi reciproco, di quelli che ti fanno decifrare l’anima. Lessi solo poche parole: “improvvisamente/semplicità/rughe maturate come un’antica montagna senza padrone”. Quella immagine, nella sua incredibile spensieratezza, mi soffocò la voce se non per chiedere alla Vedova: “E qui, dov’era, il Suo E.?”. Nulla più, a dir la verità. E fu così che mi appropriai di un momento privato simile a quelli della mia infanzia, alle feste di compleanno dove incontrarsi era materia di condivisione e tempo inceppato, quello che solo certe ricorrenze riescono a svelare. Nel silenzio una richiesta, molto esile come uno spirito di carta, di quelle che ti straziano il cuore: “Potrei… non so se… potrei… forse no…”. Pausa, silenzio, vuoto, tempo terso. E poi di nuovo: “Potrei avere una sua ciocca di capelli?”. Il vuoto sotto i piedi, salvato solo da una nota amara e commovente fatta di occhi già lucidi, ma grati, mi riportò alla realtà, una realtà troppo intima per disconoscerla alla legittima proprietaria. Quando ci fu il modo, fu premura del collega riporla tra le mani di Lei, quella ciocca. Non mi sarà mai chiaro il meccanismo attraverso il quale ognuno di noi si avvinghia a certi tratti altrui. So solo che quella piccola danza di capelli, nel suo palmo, trovò conforto in una carezza priva di difese, una carezza di quelle entro la quale si riversa tutta la dolcezza del mondo.
Beatrice Roncato Villa