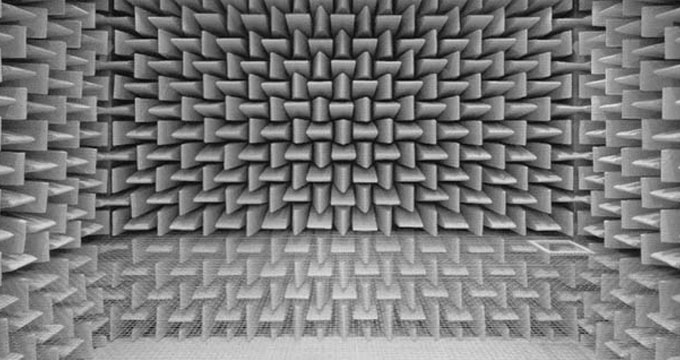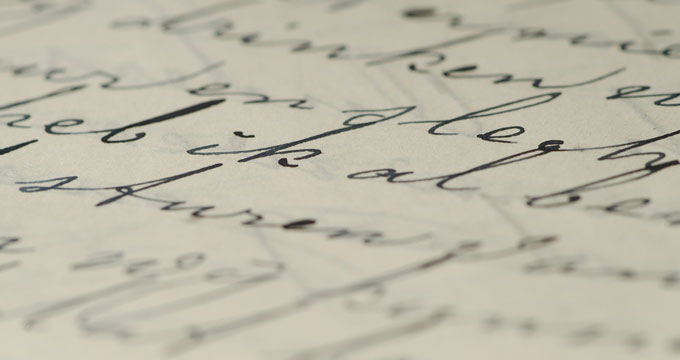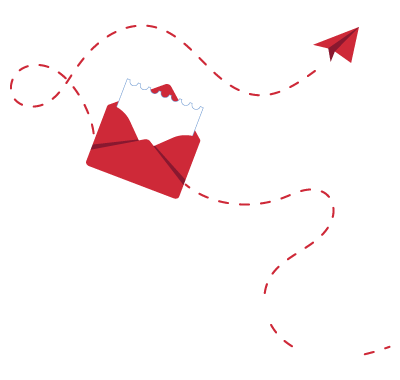La morte disordinata.

Se facessimo un confronto su ciò che può essere definita una buona morte, chiedendolo in primis a noi stessi e poi alle nostre conoscenze, ci sentiremmo rispondere: “ah! Possibilmente nel sonno, così non sento niente…E magari senza avere chissà quale acciacco, nella mia autonomia di sempre”.
In realtà, non sempre è stato così. Ai nostri nonni, ai nostri bisnonni, e facendo un passo indietro temporale nel Medioevo, una buona morte era sicuramente quella attesa, accettata, “addomesticata”, per cui il morente e la società potevano prepararsi all’evento nella (quasi) totale consapevolezza. La morte era un fatto quotidiano, un’amica e una sorella che si prendeva per mano con timore, ma con accettazione. Mi accade spesso di riflettere sul senso che la Morte ha per me, partendo dalle più piccole scomparse – come trovare una bestiola esanime sul ciglio della strada – per arrivare alle perdite che hanno toccato corde tanto profonde da sentirmi raschiare l’anima. Per me la Morte mantiene sempre quella vestigia di mistero e di inopinabilità degne di una serpe a cui è stato molestato il sonno. Evito accuratamente di tornare in quelle case dove abitava un parente che se ne è andato lasciando la propria vita appoggiata sui comò, sugli armadi, sui divani, sulle lenzuola stirate o sulle sedie della sala da pranzo. Rientrare in quei luoghi mi rende la sofferenza insopportabile e imprevedibile: non reggo il peso di non sapermi riconciliare con oggetti presi in mano o con ambienti calpestati da quei passi. Ma, questo, già lo ho raccontato. Per me cala un velo, un muro invalicabile che, se lo oltrepassassi, penso perderei la cognizione di realtà e di accettazione tanto sudate e attese. Come ben si sa, tra volere e dovere, l’oceano è di cristallo, frangibile e ghiotto di anime che non sanno navigare, né tenersi a galla. Io, con i miei lutti, mi sento così. Perché è ben diverso prendersi cura dei lutti altrui.
L’ultima volta che entrai in quella casa, già dall’androne delle scale potevo sentire come l’aria si fosse tramutata in una presenza di carne, di ferro, o di pietra, tanto da poterla sentire e descrivere. Tenere troppo a lungo gli scuri chiusi, non spostare i mobili, non accendere le luci, provoca una morte tra quelle mura che ti viene da scappare, da chiudere la porta sperando che qualcun altro si curi della responsabilità del tuo dolore. Quella persona continua a dimorare lì dentro, ma le pareti sono orfane, così come tutto il resto. L’ultimo pasto, nel frigo, in mezzo a pietanze scadute e dimenticate nella vacanza ospedaliera. Riflettevo sul ritorno all’infanzia che accade quando si invecchia e si perdono le tracce di sé: il trangugiare cibo liquido, per la mancanza di denti, e il tornare a ingurgitarlo, senza appetito alcuno, in età avanzata. Le lenzuola stropicciate, i letti disfatti, i solchi lasciati dalle dita nel barattolo della crema per il viso. Il pettine pieno di capelli, così come gli elastici e i fermacapelli, il dentifricio e lo spazzolino tutto rovinato, dalle setole disperate e impazzite. Flaconi di detersivo a metà, una lavatrice con anime sparse dentro. Il calendario fermo al giorno della partenza, dell’uscita di fretta e di borse preparate per l’occorrenza. E dov’ero io quel giorno?
Cercando un barlume di contatto, appropriandomi di quegli ultimi gesti incompiuti sparsi per la casa, mi fermo ad osservare le larve di polvere che ormai hanno colonizzato anche la cera delle candele delle feste. In realtà, e mi permetto di parlarne, la sensazione di una dimora vuota e spoglia è la stessa che provo quando mi trovo a tu per tu con quelle creature (non ancora) pronte per il loro ultimo viaggio. A chi mi chiede cosa provo in obitorio quando vado a lavorare, potrei rispondere di vivere la stessa sensazione di quando entro in una chiesa vuota, soprattutto quando dentro non vi è il vociferare di vedove allegre le cui parole, talvolta tanto spesse da poterle sfiorare con le dita, riguardano spesso la dipartita di quello che era sempre al bar e che una volta faceva il falegname. Si, insomma, ordinario gossip da panca di legno a pochi metri da un altare. Il silenzio, il tempo incubato in una stanza, la stessa aria che muore e che rimane intrappolata in corridoi la cui luce vive solo al muoversi di passi svelti che lì, proprio lì, non vogliono sostare. E quei corpi, quei corpi sono dimore abbandonate la cui morte, disordinata, altro non ha fatto che passare lasciando tutto com’era, lasciando una scia nera di chi, dopo aver imbrattato un muro, adagia maleducatamente quel corpo di latta a morire senza premura alcuna. O come fa un bambino dopo aver svuotato la scatola dei giochi che non ha voglia di rimettere in ordine. E c’è un caos calmo in quei ciuffi di capelli scompigliati, o in quelle dita le cui unghie sono rimaste un poco noncurate, o in quelle smorfie che sicuramente non attendevano il passaggio di chi avrebbe loro sottratto il sorriso. È un caos che compie scempio anche nella postura, non più armonica e serena, bensì nervosa, ma incapace di riassestarsi.
Prendersi cura di queste dimore umane è prendersi cura di quei loro gesti incompiuti, lasciati a metà. È un rituale armonico, è dare un ordine alle cose, ai gesti, facendoli tuoi: abbottonare la camicia e la giaccia, fare un nodo alla cravatta, pettinare capelli e baffi, barba e sopracciglia, è tirare i tessuti così da non lasciare pieghe dispettose, è posizionare le mani in una forma di attesa che accoglie solo una piccola croce. È il riporre con cura le cose al loro posto, dove dovrebbero essere, dove vorrebbero stare. È la speranza di aver chiuso quel cerchio, un cerchio che incontro spesso per strada quando cammino e che non riesco a chiudere per me.
Beatrice Roncato Villa
Se facessimo un confronto su ciò che può essere definita una buona morte, chiedendolo in primis a noi stessi e poi alle nostre conoscenze, ci sentiremmo rispondere: “ah! Possibilmente nel sonno, così non sento niente…E magari senza avere chissà quale acciacco, nella mia autonomia di sempre”.
In realtà, non sempre è stato così. Ai nostri nonni, ai nostri bisnonni, e facendo un passo indietro temporale nel Medioevo, una buona morte era sicuramente quella attesa, accettata, “addomesticata”, per cui il morente e la società potevano prepararsi all’evento nella (quasi) totale consapevolezza. La morte era un fatto quotidiano, un’amica e una sorella che si prendeva per mano con timore, ma con accettazione. Mi accade spesso di riflettere sul senso che la Morte ha per me, partendo dalle più piccole scomparse – come trovare una bestiola esanime sul ciglio della strada – per arrivare alle perdite che hanno toccato corde tanto profonde da sentirmi raschiare l’anima. Per me la Morte mantiene sempre quella vestigia di mistero e di inopinabilità degne di una serpe a cui è stato molestato il sonno. Evito accuratamente di tornare in quelle case dove abitava un parente che se ne è andato lasciando la propria vita appoggiata sui comò, sugli armadi, sui divani, sulle lenzuola stirate o sulle sedie della sala da pranzo. Rientrare in quei luoghi mi rende la sofferenza insopportabile e imprevedibile: non reggo il peso di non sapermi riconciliare con oggetti presi in mano o con ambienti calpestati da quei passi. Ma, questo, già lo ho raccontato. Per me cala un velo, un muro invalicabile che, se lo oltrepassassi, penso perderei la cognizione di realtà e di accettazione tanto sudate e attese. Come ben si sa, tra volere e dovere, l’oceano è di cristallo, frangibile e ghiotto di anime che non sanno navigare, né tenersi a galla. Io, con i miei lutti, mi sento così. Perché è ben diverso prendersi cura dei lutti altrui.
L’ultima volta che entrai in quella casa, già dall’androne delle scale potevo sentire come l’aria si fosse tramutata in una presenza di carne, di ferro, o di pietra, tanto da poterla sentire e descrivere. Tenere troppo a lungo gli scuri chiusi, non spostare i mobili, non accendere le luci, provoca una morte tra quelle mura che ti viene da scappare, da chiudere la porta sperando che qualcun altro si curi della responsabilità del tuo dolore. Quella persona continua a dimorare lì dentro, ma le pareti sono orfane, così come tutto il resto. L’ultimo pasto, nel frigo, in mezzo a pietanze scadute e dimenticate nella vacanza ospedaliera. Riflettevo sul ritorno all’infanzia che accade quando si invecchia e si perdono le tracce di sé: il trangugiare cibo liquido, per la mancanza di denti, e il tornare a ingurgitarlo, senza appetito alcuno, in età avanzata. Le lenzuola stropicciate, i letti disfatti, i solchi lasciati dalle dita nel barattolo della crema per il viso. Il pettine pieno di capelli, così come gli elastici e i fermacapelli, il dentifricio e lo spazzolino tutto rovinato, dalle setole disperate e impazzite. Flaconi di detersivo a metà, una lavatrice con anime sparse dentro. Il calendario fermo al giorno della partenza, dell’uscita di fretta e di borse preparate per l’occorrenza. E dov’ero io quel giorno?
Cercando un barlume di contatto, appropriandomi di quegli ultimi gesti incompiuti sparsi per la casa, mi fermo ad osservare le larve di polvere che ormai hanno colonizzato anche la cera delle candele delle feste. In realtà, e mi permetto di parlarne, la sensazione di una dimora vuota e spoglia è la stessa che provo quando mi trovo a tu per tu con quelle creature (non ancora) pronte per il loro ultimo viaggio. A chi mi chiede cosa provo in obitorio quando vado a lavorare, potrei rispondere di vivere la stessa sensazione di quando entro in una chiesa vuota, soprattutto quando dentro non vi è il vociferare di vedove allegre le cui parole, talvolta tanto spesse da poterle sfiorare con le dita, riguardano spesso la dipartita di quello che era sempre al bar e che una volta faceva il falegname. Si, insomma, ordinario gossip da panca di legno a pochi metri da un altare. Il silenzio, il tempo incubato in una stanza, la stessa aria che muore e che rimane intrappolata in corridoi la cui luce vive solo al muoversi di passi svelti che lì, proprio lì, non vogliono sostare. E quei corpi, quei corpi sono dimore abbandonate la cui morte, disordinata, altro non ha fatto che passare lasciando tutto com’era, lasciando una scia nera di chi, dopo aver imbrattato un muro, adagia maleducatamente quel corpo di latta a morire senza premura alcuna. O come fa un bambino dopo aver svuotato la scatola dei giochi che non ha voglia di rimettere in ordine. E c’è un caos calmo in quei ciuffi di capelli scompigliati, o in quelle dita le cui unghie sono rimaste un poco noncurate, o in quelle smorfie che sicuramente non attendevano il passaggio di chi avrebbe loro sottratto il sorriso. È un caos che compie scempio anche nella postura, non più armonica e serena, bensì nervosa, ma incapace di riassestarsi.
Prendersi cura di queste dimore umane è prendersi cura di quei loro gesti incompiuti, lasciati a metà. È un rituale armonico, è dare un ordine alle cose, ai gesti, facendoli tuoi: abbottonare la camicia e la giaccia, fare un nodo alla cravatta, pettinare capelli e baffi, barba e sopracciglia, è tirare i tessuti così da non lasciare pieghe dispettose, è posizionare le mani in una forma di attesa che accoglie solo una piccola croce. È il riporre con cura le cose al loro posto, dove dovrebbero essere, dove vorrebbero stare. È la speranza di aver chiuso quel cerchio, un cerchio che incontro spesso per strada quando cammino e che non riesco a chiudere per me.
Beatrice Roncato Villa