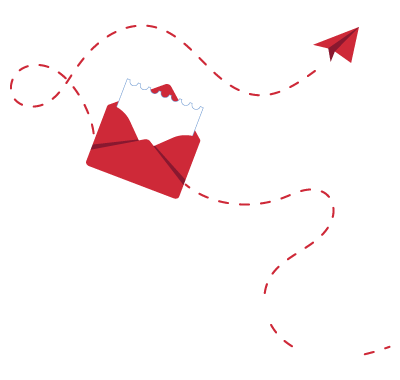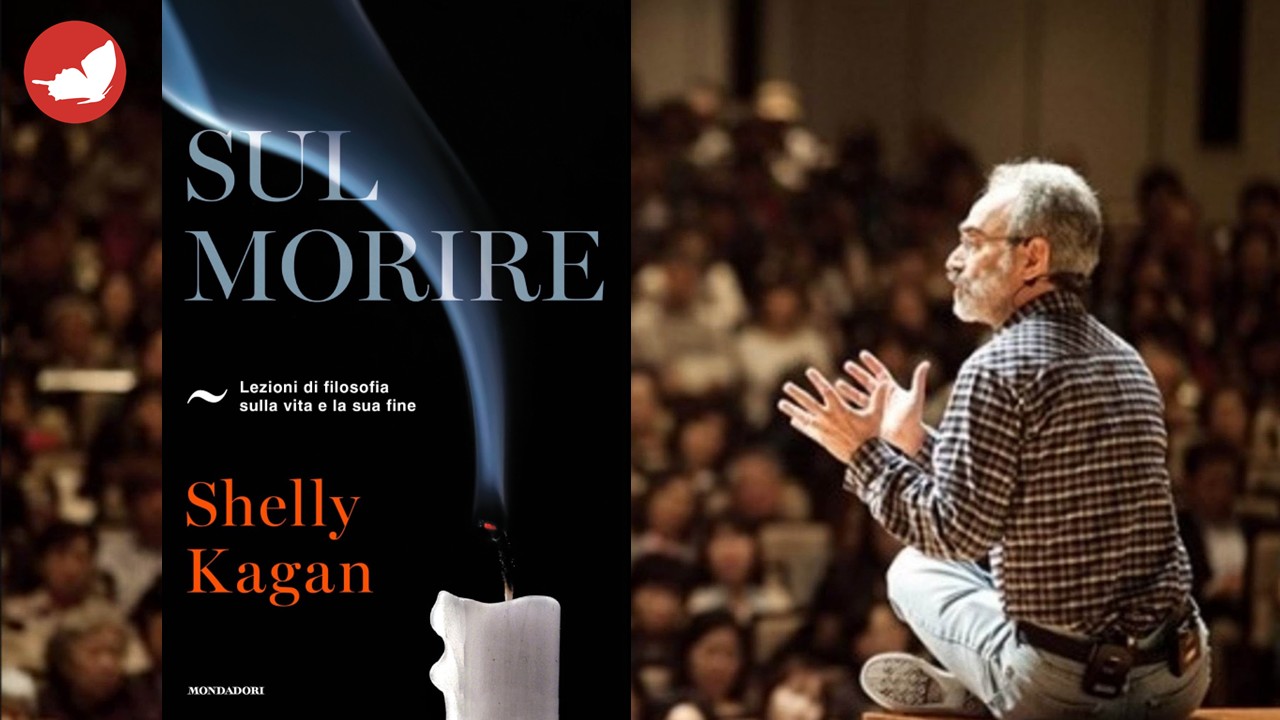La culla delle assenze. Storie di gatti, di alberi e di obitori.

Nel percorso verso l’obitorio, situato poco distante dal Planetario della città, spesso mi accade di imbattermi in una danza caotica dei gatti della colonia che lì dentro dimora. Abbastanza pasciuti, un poco acciaccati, non so mai se avvicinarmi o esitare e continuare per la mia strada, riconoscendo loro quella diffidenza nei confronti di chi non si conosce. Si allontanano, si avvicinano. Ritornano verso di me come un’onda e si ritraggono verso il porticato, al riparo. Un porticato spento, un po’ scrostato, ripopolato solo da questi esseri eleganti e schivi, gli unici capaci di reinventare una reggia entro una discarica. E io come sulla riva del mare li guardo, non mi faccio bagnare le dita perché so già quanto mi dia fastidio provare la sensazione di aver camminato sulla sabbia e sentirmela appiccicare come se avessi la pece. Casomai lasciamo al mio ritorno i grattini, anche se dimentico sempre di mantener fede alla promessa di tornare con dei croccantini per ammaliarli.
La presenza dei gatti nei luoghi di morte mi ha sempre rincuorata: questi piccoli guardiani, soprattutto dove ci sono le colonie feline dei monumentali, hanno il chimerico potere di ricordarti che i tuoi affetti non sono soli. Che puoi trovare amore anche lì, nello sconforto di una lapide appena posata e di un mazzo di fiori ormai marcescente. Faccio dunque mio questo loro scetticismo, lo ripongo nel taschino della camicia e continuo per la mia strada. In fondo è questo, il punto. Basiamo le nostre conoscenze e i nostri legami non sulla prospettiva del dono, ma su quella dello scambio più becero. Ammettiamolo: i gatti in questo sono sovrani. A piccoli passi, munita di valigia e zaino, tengo il ritmo delle mattonelle per accertarmi che Lei (o Lui) siano proprio in quella stanza. La valigetta è pesante: talvolta mi chiedo se si riempia da sé visto che non ho memoria di averla rimpolpata dopo l’ultimo servizio.
C’è un certo non-so-che nella cinta muraria che ammanta l’obitorio. Gli alberi, superbi, ma docili, tendono a nascondere e a cullare quelle piccole celle in serie più comunemente conosciute come “camere mortuarie”. Devo ammettere che hanno sempre suscitato in me emozioni contrastanti: un po’ antiquate e trasandate, mi ricordano passati mai vissuti, ma che osservo con ammirazione; troppo impersonali e scomode, mi provocano un disagio simile a quello che si avverte nell’essere usciti di casa con la costante sensazione di aver dimenticato qualcosa. E arrivo prima che gli altri arrivino. E vado via prima che gli altri arrivino. A volte mi sento un fantasma. Ma ho fatto mio questo non luogo che, seppur vissuto solamente di passaggio, sembra accettare questa mia sofferenza, offrendomi la gentilezza degli operatori con cui condivido il solo “salve sono qui per la Signora” ed un “arrivederci, ho finito”. Un dialogo che inizia con la pressione sul piccolo campanello dell’ingresso, consunto testimone di mille mila impronte accumulate negli anni, e termina con un nuovo avviso al citofono. La nenia è sempre la stessa. Nonostante mi riprometta che un giorno, prima o poi, riuscirò a strappare una frase oltre un “arrivederci a lei, alla prossima, ciao ciao”, troppo sbrigativo e metallico, e sbattuta di porta che ne segue, agli operatori dell’obitorio. Ed è strano, proprio perché con certe persone puoi andare avanti mesi, a volte anni, a mantenere un rapporto imbalsamato di saluti e nulla più.
Non ho mai amato il termine “camera mortuaria”. Quelle stanze, dalle porte socchiuse che invitano ad entrare, ma che non accettano occhi indiscreti, mi hanno sempre fatto pensare a sale “parto”. No, non si fraintenda: Sale “delle partenze”, Sale del “da qui, si parte”. Per dove, non si sa. La tensione accumulata in queste cellette sembra possa esplodere da un momento all’altro. E a me pare di poterla sentire come fosse un suono ben preciso, anche se emesso a chilometri di distanza. Sono concentrazioni di sofferenze che non mi è dato sapere, sono contenitori di silenzi pronti a deflagrare senza pietà alcuna. Mi chiedo spesso quanti passi, passati e trapassati abbiano calpestato quel pavimento. In realtà, a differenza del termine propriamente detto legato alle nascite, qui non vi è alcun via vai di parenti che accorrono per posare gli occhi sulla nuova creatura che si presenta al mondo. Non vi sono domande, così come da chi giace in quelle culle di legno non vengono emessi gemiti o grida. È il silenzio a regnare sovrano: la mancanza di una parola, di un verso, di una parola di ritorno, compromette ogni forma di comunicazione, concentrata tutta su un corpo immobile, presenza di un assente. Se si può, si evita di entrare. Se si può, si decide di ritrovarsi direttamente in chiesa. Se si riesce, si cerca direttamente di evitare la funzione.
Ed è strano non essere visti, è strano essere a tu per tu con una persona che non conosci, ma della quale vorresti però sapere molte cose. Questo accade. Mi chiedo sempre Chi abbia davanti: cosa facesse nella vita, i suoi amori e i suoi progetti, le sue delusioni, i suoi rimpianti. Questa è per me una necessità: simbolizzare quella persona che diventa un rebus che cerco di risolvere dai piccoli, minuziosi, talvolta impercettibili particolari. Un rebus alla cui fine non riesco proprio mai a cogliere un fondo di riscontro di verità. Rimango con le mie supposizioni, per dimenticarle poi come fossero monete nelle tasche dei pantaloni. Talvolta le loro mani dicono molto: mani curate dalle unghie laccate, mani nodose di chi ha lavorato costantemente come se quegli stessi arti fossero strumenti da lavoro. Mani emaciate con ancora l’ombra del passaggio dell’ago cannula. Capelli impeccabili, qualche segno di terapie e di mali, una cicatrice. Capelli assenti, dimenticati, il segno di una fede capace di solcare la carne.
Nonostante sia un luogo gravido di sofferenza, partorita nel momento dell’uscita del feretro, ho imparato a coglierne sfumature di vita e di condivisione più che altrove. Perché proprio in queste celle, la cui vetrata opaca come fosse una serra per corpi, ho notato che la comunione del dolore viene proiettata su un piano a me prima sconosciuto. Ho riscoperto la paziente possibilità di fare conoscenza, seppur frugale, con persone che, come nella sala d’attesa del medico, probabilmente non rivedrò più. O perlomeno, per molto tempo.
Ed è ciò che accade quando, inaspettatamente, entra nella cella il dolente, mentre sono nel caos totale della preparazione della salma. Perché di questo mi occupo. La cura, nel penultimo atto, del dolore altrui. “Mi scusi, posso entrare? Sa, ho portato con me le cose di mia mamma. La camicia rosa, che avrebbe preferito, il suo profumo, i suoi trucchi. Posso?”. Iniziò così la mia conoscenza, sacra e fulminea, con la Signora L. La mascherina non fece trasparire il sorriso che le porsi appena mi sentii dire quelle parole. Perché la Signora L. non si fece problema alcuno: senza giri di parole o esitazioni, mi si rese alleata e mi si avvicinò, mettendosi subito all’opera. E fu come una danza, in cui i nostri passi si incrociarono senza scontrarsi mai, in quegli attimi in cui mi parlò di sua madre, di attese, di un male indomabile e delle sue routine. Mi parlò della scelta dei fiori, gli stessi del giorno del matrimonio, che per la stagione non fu possibile reperire dovendoli dunque sostituire con altri. E il vuoto, le domande sul futuro in cui quell’assenza incomberà facendoti sentire come Atlante con il peso del mondo sulle spalle. Un po’ mi parve, quindi, di conoscerla, ed un po’ mi parve di aver fatto mio quel suo dolore, seppur in modo passeggero. Dopo la messa in piega, con una spina del phon troppo corta per lavorare in serenità, mi parlò delle sue mani, di mani mai tentate da lavori eccessivi, per cui si preferì coprirle con dei deliziosi guanti blu scuro, in pizzo ricamato, per proteggerle nel “viaggio”.
Mi nutro di questi piccoli particolari, ma non so che fine facciano una volta uscita da lì. Li ricordo, ma non li racconto mai. Ho sgretolato questo mio patto personale narrandovi ora (e in futuro) cosa possa passare nei corridoi della mente di una Tanatoesteta.
Beatrice Roncato Villa
Nel percorso verso l’obitorio, situato poco distante dal Planetario della città, spesso mi accade di imbattermi in una danza caotica dei gatti della colonia che lì dentro dimora. Abbastanza pasciuti, un poco acciaccati, non so mai se avvicinarmi o esitare e continuare per la mia strada, riconoscendo loro quella diffidenza nei confronti di chi non si conosce. Si allontanano, si avvicinano. Ritornano verso di me come un’onda e si ritraggono verso il porticato, al riparo. Un porticato spento, un po’ scrostato, ripopolato solo da questi esseri eleganti e schivi, gli unici capaci di reinventare una reggia entro una discarica. E io come sulla riva del mare li guardo, non mi faccio bagnare le dita perché so già quanto mi dia fastidio provare la sensazione di aver camminato sulla sabbia e sentirmela appiccicare come se avessi la pece. Casomai lasciamo al mio ritorno i grattini, anche se dimentico sempre di mantener fede alla promessa di tornare con dei croccantini per ammaliarli.
La presenza dei gatti nei luoghi di morte mi ha sempre rincuorata: questi piccoli guardiani, soprattutto dove ci sono le colonie feline dei monumentali, hanno il chimerico potere di ricordarti che i tuoi affetti non sono soli. Che puoi trovare amore anche lì, nello sconforto di una lapide appena posata e di un mazzo di fiori ormai marcescente. Faccio dunque mio questo loro scetticismo, lo ripongo nel taschino della camicia e continuo per la mia strada. In fondo è questo, il punto. Basiamo le nostre conoscenze e i nostri legami non sulla prospettiva del dono, ma su quella dello scambio più becero. Ammettiamolo: i gatti in questo sono sovrani. A piccoli passi, munita di valigia e zaino, tengo il ritmo delle mattonelle per accertarmi che Lei (o Lui) siano proprio in quella stanza. La valigetta è pesante: talvolta mi chiedo se si riempia da sé visto che non ho memoria di averla rimpolpata dopo l’ultimo servizio.
C’è un certo non-so-che nella cinta muraria che ammanta l’obitorio. Gli alberi, superbi, ma docili, tendono a nascondere e a cullare quelle piccole celle in serie più comunemente conosciute come “camere mortuarie”. Devo ammettere che hanno sempre suscitato in me emozioni contrastanti: un po’ antiquate e trasandate, mi ricordano passati mai vissuti, ma che osservo con ammirazione; troppo impersonali e scomode, mi provocano un disagio simile a quello che si avverte nell’essere usciti di casa con la costante sensazione di aver dimenticato qualcosa. E arrivo prima che gli altri arrivino. E vado via prima che gli altri arrivino. A volte mi sento un fantasma. Ma ho fatto mio questo non luogo che, seppur vissuto solamente di passaggio, sembra accettare questa mia sofferenza, offrendomi la gentilezza degli operatori con cui condivido il solo “salve sono qui per la Signora” ed un “arrivederci, ho finito”. Un dialogo che inizia con la pressione sul piccolo campanello dell’ingresso, consunto testimone di mille mila impronte accumulate negli anni, e termina con un nuovo avviso al citofono. La nenia è sempre la stessa. Nonostante mi riprometta che un giorno, prima o poi, riuscirò a strappare una frase oltre un “arrivederci a lei, alla prossima, ciao ciao”, troppo sbrigativo e metallico, e sbattuta di porta che ne segue, agli operatori dell’obitorio. Ed è strano, proprio perché con certe persone puoi andare avanti mesi, a volte anni, a mantenere un rapporto imbalsamato di saluti e nulla più.
Non ho mai amato il termine “camera mortuaria”. Quelle stanze, dalle porte socchiuse che invitano ad entrare, ma che non accettano occhi indiscreti, mi hanno sempre fatto pensare a sale “parto”. No, non si fraintenda: Sale “delle partenze”, Sale del “da qui, si parte”. Per dove, non si sa. La tensione accumulata in queste cellette sembra possa esplodere da un momento all’altro. E a me pare di poterla sentire come fosse un suono ben preciso, anche se emesso a chilometri di distanza. Sono concentrazioni di sofferenze che non mi è dato sapere, sono contenitori di silenzi pronti a deflagrare senza pietà alcuna. Mi chiedo spesso quanti passi, passati e trapassati abbiano calpestato quel pavimento. In realtà, a differenza del termine propriamente detto legato alle nascite, qui non vi è alcun via vai di parenti che accorrono per posare gli occhi sulla nuova creatura che si presenta al mondo. Non vi sono domande, così come da chi giace in quelle culle di legno non vengono emessi gemiti o grida. È il silenzio a regnare sovrano: la mancanza di una parola, di un verso, di una parola di ritorno, compromette ogni forma di comunicazione, concentrata tutta su un corpo immobile, presenza di un assente. Se si può, si evita di entrare. Se si può, si decide di ritrovarsi direttamente in chiesa. Se si riesce, si cerca direttamente di evitare la funzione.
Ed è strano non essere visti, è strano essere a tu per tu con una persona che non conosci, ma della quale vorresti però sapere molte cose. Questo accade. Mi chiedo sempre Chi abbia davanti: cosa facesse nella vita, i suoi amori e i suoi progetti, le sue delusioni, i suoi rimpianti. Questa è per me una necessità: simbolizzare quella persona che diventa un rebus che cerco di risolvere dai piccoli, minuziosi, talvolta impercettibili particolari. Un rebus alla cui fine non riesco proprio mai a cogliere un fondo di riscontro di verità. Rimango con le mie supposizioni, per dimenticarle poi come fossero monete nelle tasche dei pantaloni. Talvolta le loro mani dicono molto: mani curate dalle unghie laccate, mani nodose di chi ha lavorato costantemente come se quegli stessi arti fossero strumenti da lavoro. Mani emaciate con ancora l’ombra del passaggio dell’ago cannula. Capelli impeccabili, qualche segno di terapie e di mali, una cicatrice. Capelli assenti, dimenticati, il segno di una fede capace di solcare la carne.
Nonostante sia un luogo gravido di sofferenza, partorita nel momento dell’uscita del feretro, ho imparato a coglierne sfumature di vita e di condivisione più che altrove. Perché proprio in queste celle, la cui vetrata opaca come fosse una serra per corpi, ho notato che la comunione del dolore viene proiettata su un piano a me prima sconosciuto. Ho riscoperto la paziente possibilità di fare conoscenza, seppur frugale, con persone che, come nella sala d’attesa del medico, probabilmente non rivedrò più. O perlomeno, per molto tempo.
Ed è ciò che accade quando, inaspettatamente, entra nella cella il dolente, mentre sono nel caos totale della preparazione della salma. Perché di questo mi occupo. La cura, nel penultimo atto, del dolore altrui. “Mi scusi, posso entrare? Sa, ho portato con me le cose di mia mamma. La camicia rosa, che avrebbe preferito, il suo profumo, i suoi trucchi. Posso?”. Iniziò così la mia conoscenza, sacra e fulminea, con la Signora L. La mascherina non fece trasparire il sorriso che le porsi appena mi sentii dire quelle parole. Perché la Signora L. non si fece problema alcuno: senza giri di parole o esitazioni, mi si rese alleata e mi si avvicinò, mettendosi subito all’opera. E fu come una danza, in cui i nostri passi si incrociarono senza scontrarsi mai, in quegli attimi in cui mi parlò di sua madre, di attese, di un male indomabile e delle sue routine. Mi parlò della scelta dei fiori, gli stessi del giorno del matrimonio, che per la stagione non fu possibile reperire dovendoli dunque sostituire con altri. E il vuoto, le domande sul futuro in cui quell’assenza incomberà facendoti sentire come Atlante con il peso del mondo sulle spalle. Un po’ mi parve, quindi, di conoscerla, ed un po’ mi parve di aver fatto mio quel suo dolore, seppur in modo passeggero. Dopo la messa in piega, con una spina del phon troppo corta per lavorare in serenità, mi parlò delle sue mani, di mani mai tentate da lavori eccessivi, per cui si preferì coprirle con dei deliziosi guanti blu scuro, in pizzo ricamato, per proteggerle nel “viaggio”.
Mi nutro di questi piccoli particolari, ma non so che fine facciano una volta uscita da lì. Li ricordo, ma non li racconto mai. Ho sgretolato questo mio patto personale narrandovi ora (e in futuro) cosa possa passare nei corridoi della mente di una Tanatoesteta.
Beatrice Roncato Villa