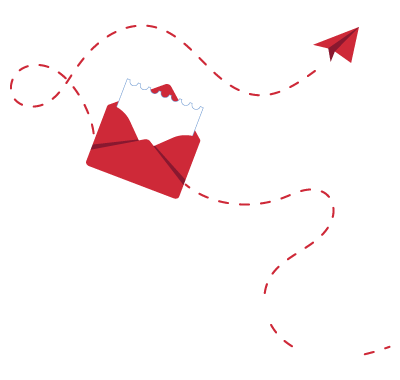In memoria di Marieke Vervoort, morta dopo aver scelto l’eutanasia come ultima cura ad una crudele malattia.

In memoria di Marieke Vervoort, morta dopo aver scelto l’eutanasia come ultima cura ad una crudele malattia.
Vi sono vite segnate da esigenti sventure che le rendono insostenibili. Sono vite scolpite da sciagure o da malattie degenerative che rosicchiano il corpo e logorano il morale, reclamando di più ad ogni giorno che passa. Non è facile scrivere di queste cose senza una certa condivisione che l’autore ha da 32 anni. Se non avesse competenza di certe realtà, non oserebbe andare oltre l’asettica cronaca degli avvenimenti senza inserire opinioni e turbamenti. Perdere la mobilità del corpo è vivere in uno spazio minimo, a volte solo interiore, spesso tra dolori che fanno man bassa di ogni resistenza, di ogni forza morale. Nei momenti più duri, capita di pregare per una benevola morte che non arriva, non ancora.
Lunedì 21 ottobre l’atleta paraolimpica belga Marieke Vervoort, all’età di 40 anni, ha posto fine alla propria vita ricorrendo a una preordinata eutanasia. La Vervoort, vincitrice di un oro e di un argento alle Para Olimpiadi di Londra 2012 e di altre due medaglie a Rio 2016, soffriva di una malattia muscolare degenerativa incurabile che le provocava dolori costanti, crisi epilettiche, paralisi delle gambe e che le impediva di dormire. Da anni viveva insieme a Zenn, un Labrador addestrato per fornirle assistenza, un compagno fedele con il quale amava farsi fotografare. Dal 2008 aveva sottoscritto un documento per consentire ai medici, in futuro, di fare il possibile per garantirle un sereno trapasso.
I trattamenti di fine vita sono legali in Belgio dal 2003, mentre il discorso, in Italia, ha affrontato nel recente passato percorsi commoventi. Sono trascorsi 13 anni da quando Piergiorgio Welby, sconfitto dalla distrofia muscolare, aiutato dai familiari e dall’anestesista Mario Riccio, scelse di spegnere la propria esistenza fermando il respiratore che lo teneva in vita. Ricordo ancora vivo perché fu il primo a colpire le coscienze di un’Italia assopita e poco protestante. Nel 2007 Giovanni Nuvoli, afflitto da Sla, dopo aver visto respinti i propri appelli per porre fine a un’umiliante esistenza, ha scelto la potente decisione di lasciarsi morire nella sua villetta di Alghero dopo un estremo sciopero della fame. Nel 2009 l’opinione pubblica italiana è spaccata dal caso di Eluana Englaro, da 17 anni in coma vegetativo dopo un incidente stradale. È il padre Giuseppe che si è impegnato nel rispettare le volontà della figlia che, quand’era in buona salute, aveva espresso di non desiderare accanimenti terapeutici nel caso fosse incappata in qualcosa di terribile. Altro caso noto è stato quello di DJ Fabo, al secolo Fabiano Antoniani, cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale. Nel 2014 è approdato in una clinica svizzera per poter usufruire del suicidio assistito e liberarsi “di una tortura insopportabile e infinita”.
L’aspetto straziante di una morte a pagamento in un’asettica clinica svizzera, anziché tra l’intimità delle mura domestiche, è una distorsione, un vuoto di rispetto nei confronti di un gesto che reclama omaggio e deferenza. La strada per la Svizzera ha visto altri migranti in cerca di un approdo per l’ultimo gesto. Dopo DJ Fabio, Davide Trentini, ammalato di sclerosi multipla dal 1993, e poi Loris Bertocco, paralizzato dall’età di 18 anni e giunto ai 59.
Nel nostro Paese la legge sul fine vita (biotestamento) del 22 dicembre 2017, n. 219, è entrata in vigore il 31 gennaio 2018: a parere di chi scrive è una buona legge che ha socchiuso la porta a possibilità, depenalizzando pietose intenzioni. Da quel momento è sceso il clamore sui casi nostrani. È un bene lasciare che certe storie non cadano preda dei Tg e della carta stampata, come la triste vicenda di Vincent Lambert, infermiere francese in stato vegetativo, al centro di una faida familiare, religiosa e mediatica, degna d’un gossip, anziché d’un dramma da trattare in punta dei piedi. Storie di incalcolabili dolori che hanno toccato anche la giovane atleta belga Marieke Vervoort. Ora non è più in caccia di record, ha raggiunto l’ultimo traguardo laddove è difficile parlare di vittoria. È un terminal che aspetta ogni forma di vita, diverso è desiderarlo al di là di ogni umana aspirazione, ultima dignità da dedicare a se stessi, ma estremo limite di libertà.
Carlo Mariano Sartoris
Vi sono vite segnate da esigenti sventure che le rendono insostenibili. Sono vite scolpite da sciagure o da malattie degenerative che rosicchiano il corpo e logorano il morale, reclamando di più ad ogni giorno che passa. Non è facile scrivere di queste cose senza una certa condivisione che l’autore ha da 32 anni. Se non avesse competenza di certe realtà, non oserebbe andare oltre l’asettica cronaca degli avvenimenti senza inserire opinioni e turbamenti. Perdere la mobilità del corpo è vivere in uno spazio minimo, a volte solo interiore, spesso tra dolori che fanno man bassa di ogni resistenza, di ogni forza morale. Nei momenti più duri, capita di pregare per una benevola morte che non arriva, non ancora.
Lunedì 21 ottobre l’atleta paraolimpica belga Marieke Vervoort, all’età di 40 anni, ha posto fine alla propria vita ricorrendo a una preordinata eutanasia. La Vervoort, vincitrice di un oro e di un argento alle Para Olimpiadi di Londra 2012 e di altre due medaglie a Rio 2016, soffriva di una malattia muscolare degenerativa incurabile che le provocava dolori costanti, crisi epilettiche, paralisi delle gambe e che le impediva di dormire. Da anni viveva insieme a Zenn, un Labrador addestrato per fornirle assistenza, un compagno fedele con il quale amava farsi fotografare. Dal 2008 aveva sottoscritto un documento per consentire ai medici, in futuro, di fare il possibile per garantirle un sereno trapasso.
I trattamenti di fine vita sono legali in Belgio dal 2003, mentre il discorso, in Italia, ha affrontato nel recente passato percorsi commoventi. Sono trascorsi 13 anni da quando Piergiorgio Welby, sconfitto dalla distrofia muscolare, aiutato dai familiari e dall’anestesista Mario Riccio, scelse di spegnere la propria esistenza fermando il respiratore che lo teneva in vita. Ricordo ancora vivo perché fu il primo a colpire le coscienze di un’Italia assopita e poco protestante. Nel 2007 Giovanni Nuvoli, afflitto da Sla, dopo aver visto respinti i propri appelli per porre fine a un’umiliante esistenza, ha scelto la potente decisione di lasciarsi morire nella sua villetta di Alghero dopo un estremo sciopero della fame. Nel 2009 l’opinione pubblica italiana è spaccata dal caso di Eluana Englaro, da 17 anni in coma vegetativo dopo un incidente stradale. È il padre Giuseppe che si è impegnato nel rispettare le volontà della figlia che, quand’era in buona salute, aveva espresso di non desiderare accanimenti terapeutici nel caso fosse incappata in qualcosa di terribile. Altro caso noto è stato quello di DJ Fabo, al secolo Fabiano Antoniani, cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale. Nel 2014 è approdato in una clinica svizzera per poter usufruire del suicidio assistito e liberarsi “di una tortura insopportabile e infinita”.
L’aspetto straziante di una morte a pagamento in un’asettica clinica svizzera, anziché tra l’intimità delle mura domestiche, è una distorsione, un vuoto di rispetto nei confronti di un gesto che reclama omaggio e deferenza. La strada per la Svizzera ha visto altri migranti in cerca di un approdo per l’ultimo gesto. Dopo DJ Fabio, Davide Trentini, ammalato di sclerosi multipla dal 1993, e poi Loris Bertocco, paralizzato dall’età di 18 anni e giunto ai 59.
Nel nostro Paese la legge sul fine vita (biotestamento) del 22 dicembre 2017, n. 219, è entrata in vigore il 31 gennaio 2018: a parere di chi scrive è una buona legge che ha socchiuso la porta a possibilità, depenalizzando pietose intenzioni. Da quel momento è sceso il clamore sui casi nostrani. È un bene lasciare che certe storie non cadano preda dei Tg e della carta stampata, come la triste vicenda di Vincent Lambert, infermiere francese in stato vegetativo, al centro di una faida familiare, religiosa e mediatica, degna d’un gossip, anziché d’un dramma da trattare in punta dei piedi. Storie di incalcolabili dolori che hanno toccato anche la giovane atleta belga Marieke Vervoort. Ora non è più in caccia di record, ha raggiunto l’ultimo traguardo laddove è difficile parlare di vittoria. È un terminal che aspetta ogni forma di vita, diverso è desiderarlo al di là di ogni umana aspirazione, ultima dignità da dedicare a se stessi, ma estremo limite di libertà.
Carlo Mariano Sartoris