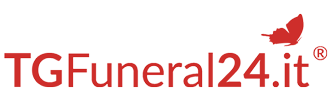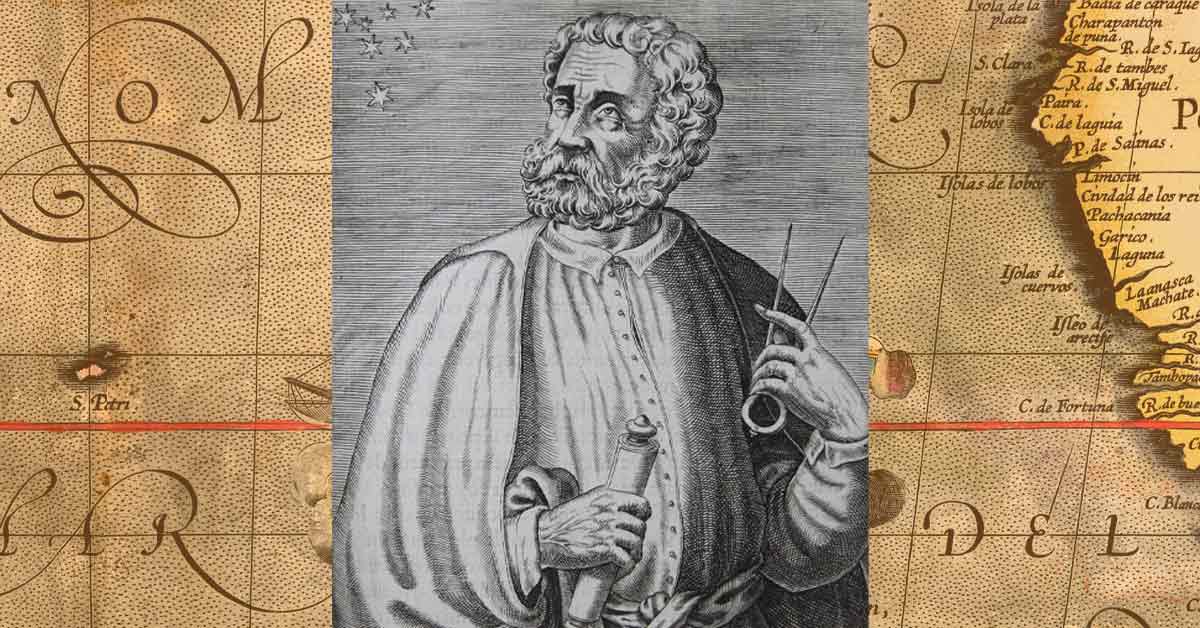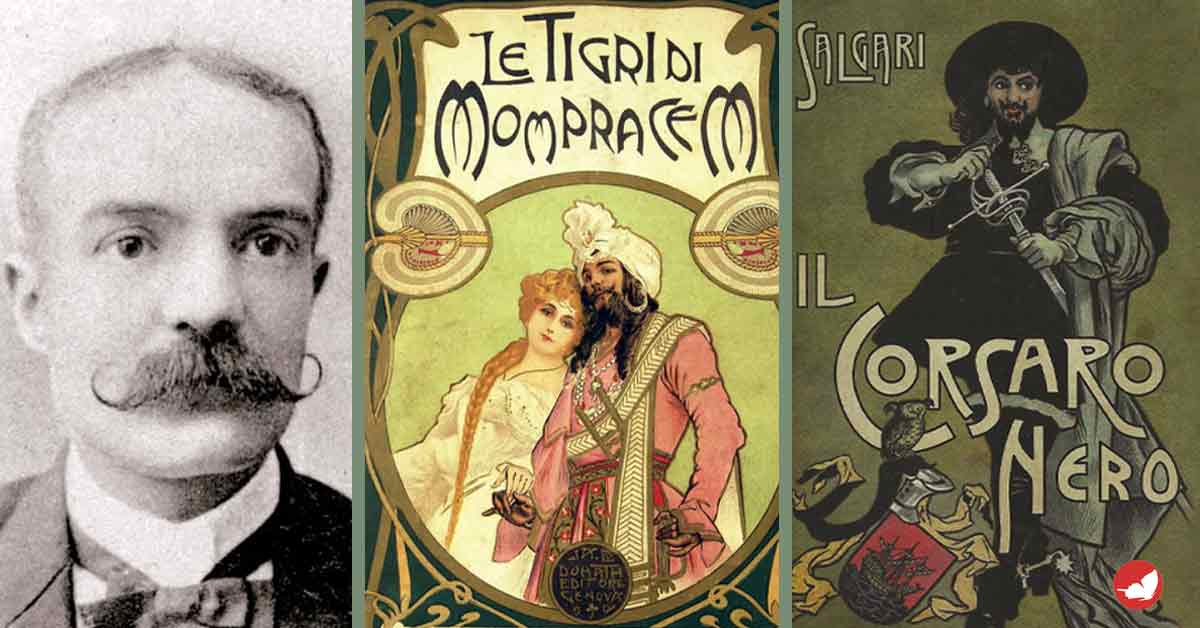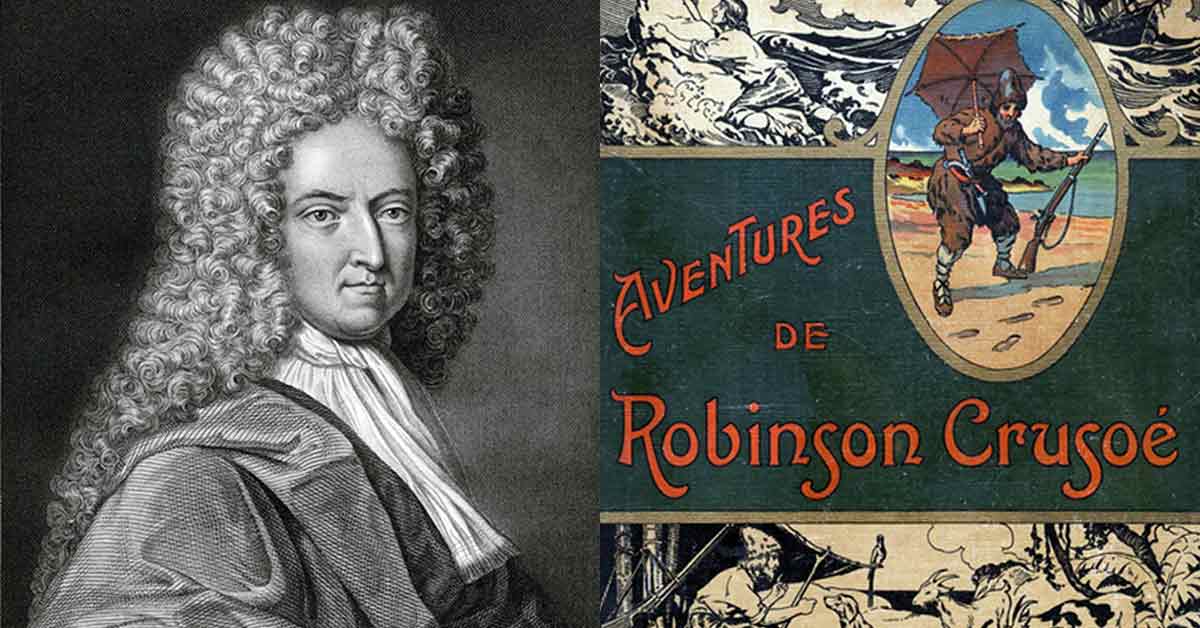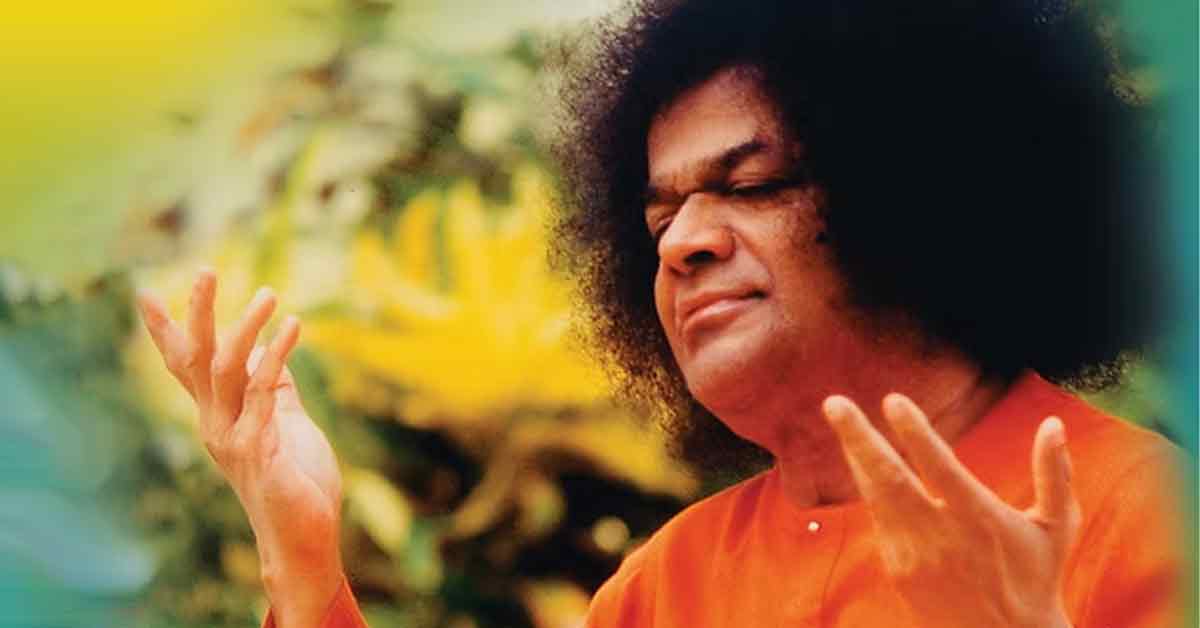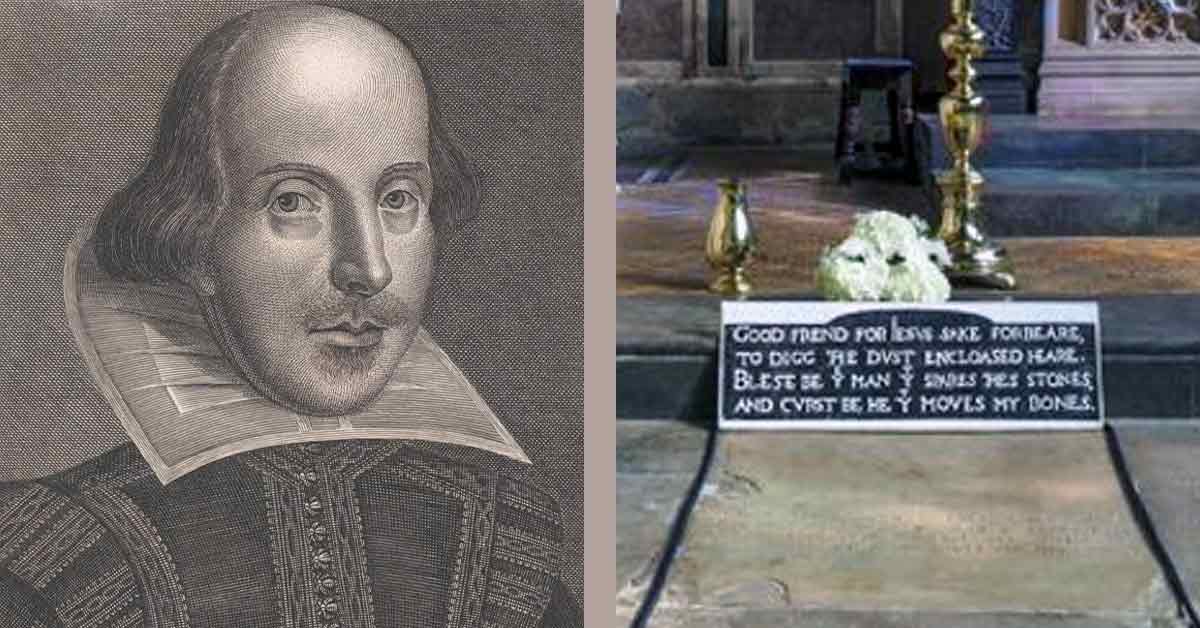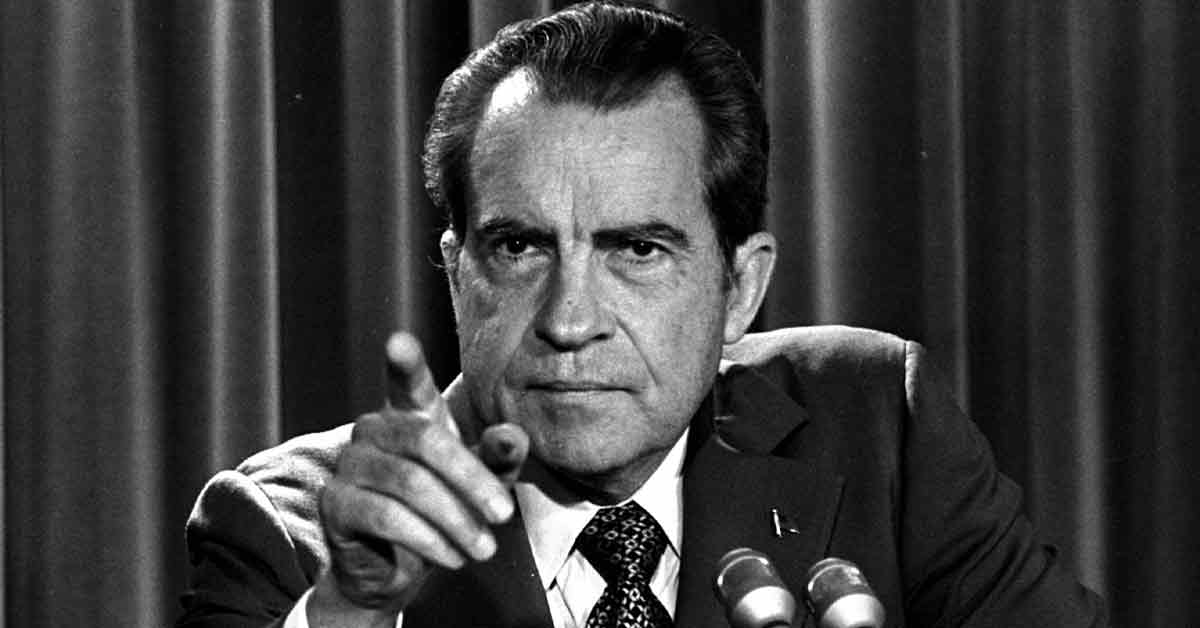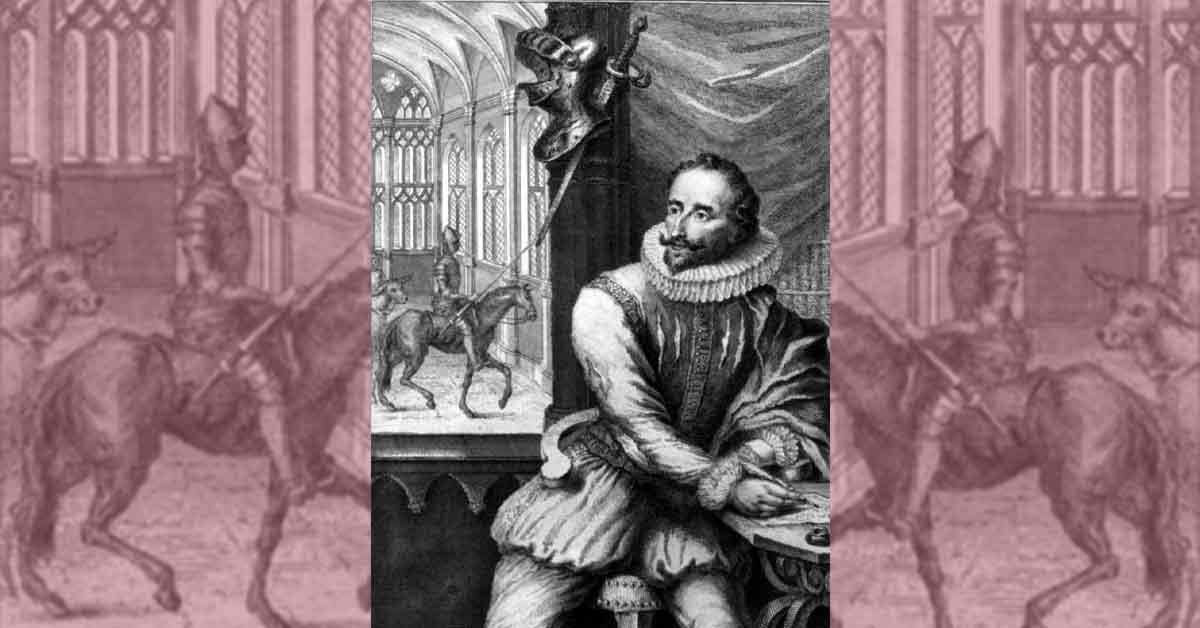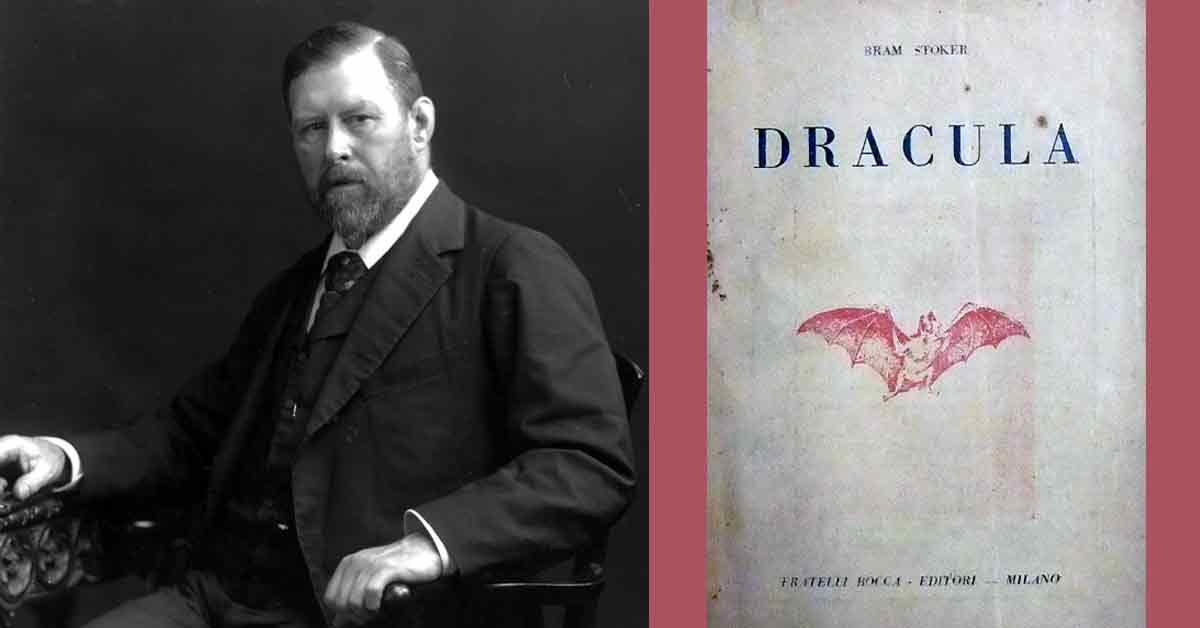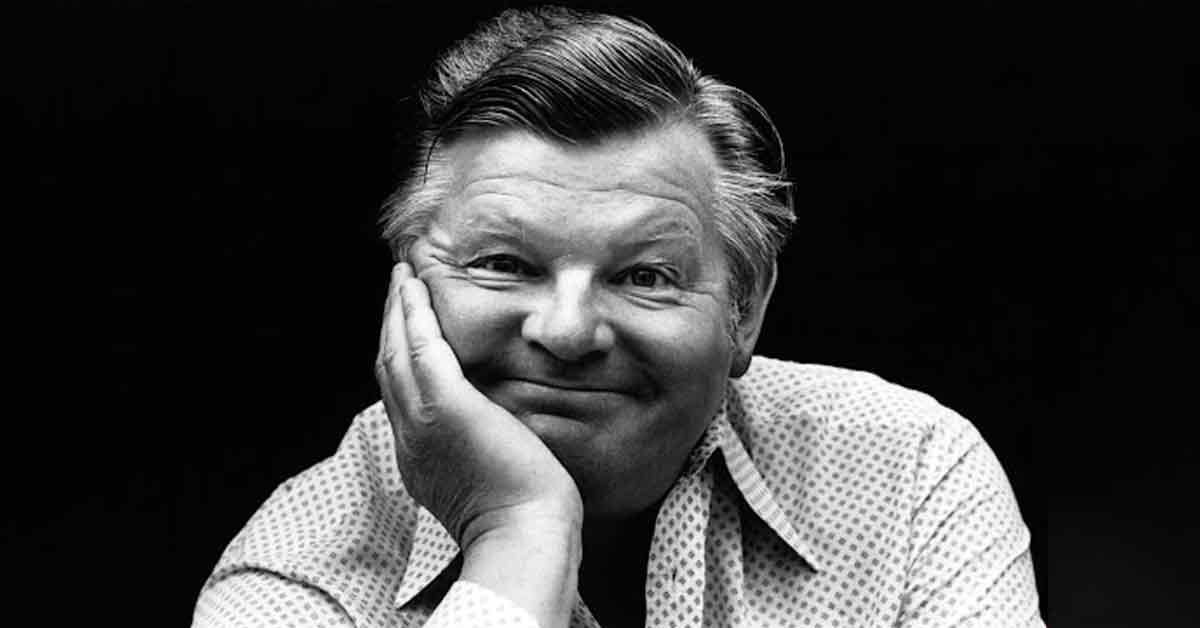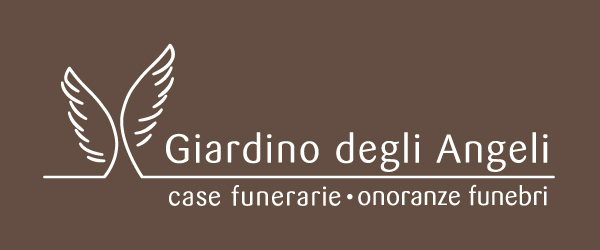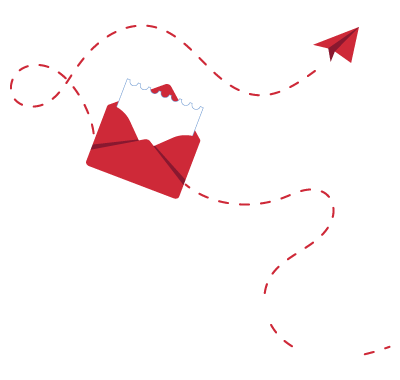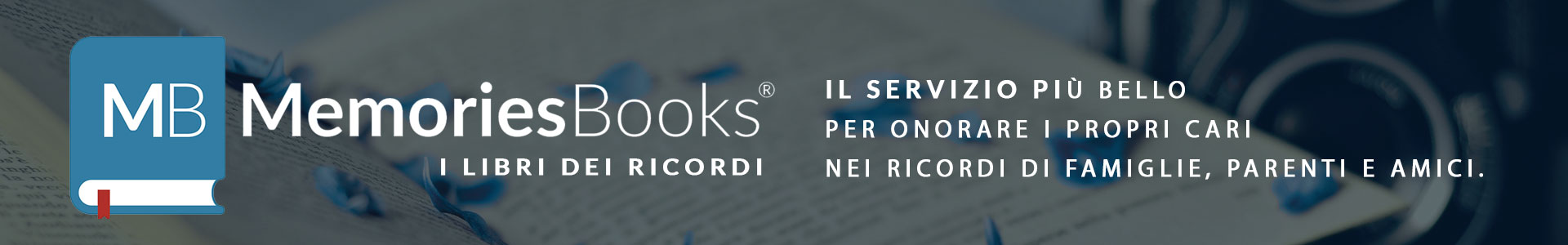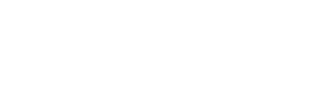15 aprile 1944. Muore Giovanni Gentile, il filosofo del fascismo.

Giovanni Gentile nasce il 29 maggio 1875 a Castelvetrano, in Sicilia.
Cresce in una famiglia numerosa e modesta, ma culturalmente vivace.
Dopo il liceo a Trapani, ottiene una borsa di studio per la Scuola Normale Superiore di Pisa.
Si laurea in Lettere e Filosofia, venendo influenzato da Donato Jaja e dall’idealismo hegeliano.
A Pisa conosce Benedetto Croce, con cui instaura un lungo sodalizio intellettuale.
La carriera accademica e la nascita dell’attualismo
Dopo la laurea insegna nei licei di Campobasso e Napoli.
Nel 1902 ottiene la libera docenza in filosofia teoretica e pedagogia.
Entra nel mondo accademico come professore universitario a Palermo, Pisa e infine Roma.
Nel 1907 fonda con Giuseppe Lombardo Radice la rivista Nuovi Doveri, avviando una riflessione pedagogica profonda.
In questi anni sviluppa l’attualismo: una filosofia in cui realtà e pensiero coincidono nell’atto puro del pensare.
Giovanni Gentile e l’intesa con Croce
Nel 1903 fonda con Croce la rivista La Critica, condividendo la battaglia contro il positivismo.
Giovanni Gentile costruisce un sistema idealistico radicale, fondato sull’autocoscienza.
Per lui esiste solo ciò che è pensato, in un eterno presente dell’atto.
Questa visione permea sia la sua filosofia che la sua pedagogia.
L’ingresso in politica e la Riforma Gentile
Nel primo dopoguerra si avvicina al nazionalismo e al liberalismo risorgimentale.
Nel 1922 è nominato ministro della pubblica istruzione nel governo Mussolini.
L’anno seguente vara la “Riforma Gentile”, che rivoluziona la scuola italiana.
Introduce l’obbligo scolastico fino a 14 anni, l’esame di Stato e la centralità del liceo classico.
Il sistema è gerarchico, meritocratico e orientato alla formazione di un’élite intellettuale.
Le donne vengono escluse dall’insegnamento di alcune materie e dirottate verso un liceo separato.
Giovanni Gentile, il filosofo del regime
Nel 1925 pubblica il Manifesto degli intellettuali fascisti, rompendo con Croce.
Fonda e presiede l’Istituto Nazionale Fascista di Cultura.
Dirige l’Enciclopedia Italiana dal 1925 al 1938, coinvolgendo studiosi di ogni orientamento.
Gentile vede nel fascismo la prosecuzione morale del Risorgimento.
Promuove l’idea dello Stato etico: l’individuo è libero solo obbedendo alla legge.
Rimane sempre fedele a Mussolini, anche nei momenti più difficili del regime.
La Repubblica Sociale Italiana e le ultime scelte
Dopo il 25 luglio 1943 si ritira, ma aderisce alla Repubblica Sociale Italiana.
Diventa presidente della Reale Accademia d’Italia e continua a scrivere e intervenire.
Tiene il celebre Discorso agli Italiani, in cui invita all’unità nazionale.
Nonostante le minacce dei partigiani, rifiuta la scorta armata.
Fino all’ultimo difende l’idea di una cultura unitaria e spirituale.
Critiche e memoria culturale
Dopo la guerra, Gentile viene rimosso dalla memoria ufficiale per il suo legame con il fascismo.
Tuttavia, la sua opera filosofica continua a essere studiata e discussa.
Croce, Gramsci e Bobbio lo criticano, ma ne riconoscono la rilevanza.
Nel 1994 lo Stato italiano gli dedica un francobollo commemorativo.
Il suo pensiero resta una delle colonne del dibattito filosofico italiano del Novecento.
La morte e i funerali
Il 15 aprile 1944 Gentile viene assassinato a Firenze da un gruppo partigiano dei GAP.
Viene colpito davanti alla villa al Salviatino, dove abitava.
La sua uccisione divide il fronte antifascista e suscita polemiche ancora oggi.
Il 18 aprile viene sepolto nella basilica di Santa Croce, accanto ai grandi della cultura italiana.
Il suo ultimo lavoro, Genesi e struttura della società, viene pubblicato postumo.
Giovanni Gentile nasce il 29 maggio 1875 a Castelvetrano, in Sicilia.
Cresce in una famiglia numerosa e modesta, ma culturalmente vivace.
Dopo il liceo a Trapani, ottiene una borsa di studio per la Scuola Normale Superiore di Pisa.
Si laurea in Lettere e Filosofia, venendo influenzato da Donato Jaja e dall’idealismo hegeliano.
A Pisa conosce Benedetto Croce, con cui instaura un lungo sodalizio intellettuale.
La carriera accademica e la nascita dell’attualismo
Dopo la laurea insegna nei licei di Campobasso e Napoli.
Nel 1902 ottiene la libera docenza in filosofia teoretica e pedagogia.
Entra nel mondo accademico come professore universitario a Palermo, Pisa e infine Roma.
Nel 1907 fonda con Giuseppe Lombardo Radice la rivista Nuovi Doveri, avviando una riflessione pedagogica profonda.
In questi anni sviluppa l’attualismo: una filosofia in cui realtà e pensiero coincidono nell’atto puro del pensare.
Giovanni Gentile e l’intesa con Croce
Nel 1903 fonda con Croce la rivista La Critica, condividendo la battaglia contro il positivismo.
Giovanni Gentile costruisce un sistema idealistico radicale, fondato sull’autocoscienza.
Per lui esiste solo ciò che è pensato, in un eterno presente dell’atto.
Questa visione permea sia la sua filosofia che la sua pedagogia.
L’ingresso in politica e la Riforma Gentile
Nel primo dopoguerra si avvicina al nazionalismo e al liberalismo risorgimentale.
Nel 1922 è nominato ministro della pubblica istruzione nel governo Mussolini.
L’anno seguente vara la “Riforma Gentile”, che rivoluziona la scuola italiana.
Introduce l’obbligo scolastico fino a 14 anni, l’esame di Stato e la centralità del liceo classico.
Il sistema è gerarchico, meritocratico e orientato alla formazione di un’élite intellettuale.
Le donne vengono escluse dall’insegnamento di alcune materie e dirottate verso un liceo separato.
Giovanni Gentile, il filosofo del regime
Nel 1925 pubblica il Manifesto degli intellettuali fascisti, rompendo con Croce.
Fonda e presiede l’Istituto Nazionale Fascista di Cultura.
Dirige l’Enciclopedia Italiana dal 1925 al 1938, coinvolgendo studiosi di ogni orientamento.
Gentile vede nel fascismo la prosecuzione morale del Risorgimento.
Promuove l’idea dello Stato etico: l’individuo è libero solo obbedendo alla legge.
Rimane sempre fedele a Mussolini, anche nei momenti più difficili del regime.
La Repubblica Sociale Italiana e le ultime scelte
Dopo il 25 luglio 1943 si ritira, ma aderisce alla Repubblica Sociale Italiana.
Diventa presidente della Reale Accademia d’Italia e continua a scrivere e intervenire.
Tiene il celebre Discorso agli Italiani, in cui invita all’unità nazionale.
Nonostante le minacce dei partigiani, rifiuta la scorta armata.
Fino all’ultimo difende l’idea di una cultura unitaria e spirituale.
Critiche e memoria culturale
Dopo la guerra, Gentile viene rimosso dalla memoria ufficiale per il suo legame con il fascismo.
Tuttavia, la sua opera filosofica continua a essere studiata e discussa.
Croce, Gramsci e Bobbio lo criticano, ma ne riconoscono la rilevanza.
Nel 1994 lo Stato italiano gli dedica un francobollo commemorativo.
Il suo pensiero resta una delle colonne del dibattito filosofico italiano del Novecento.
La morte e i funerali
Il 15 aprile 1944 Gentile viene assassinato a Firenze da un gruppo partigiano dei GAP.
Viene colpito davanti alla villa al Salviatino, dove abitava.
La sua uccisione divide il fronte antifascista e suscita polemiche ancora oggi.
Il 18 aprile viene sepolto nella basilica di Santa Croce, accanto ai grandi della cultura italiana.
Il suo ultimo lavoro, Genesi e struttura della società, viene pubblicato postumo.