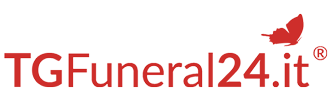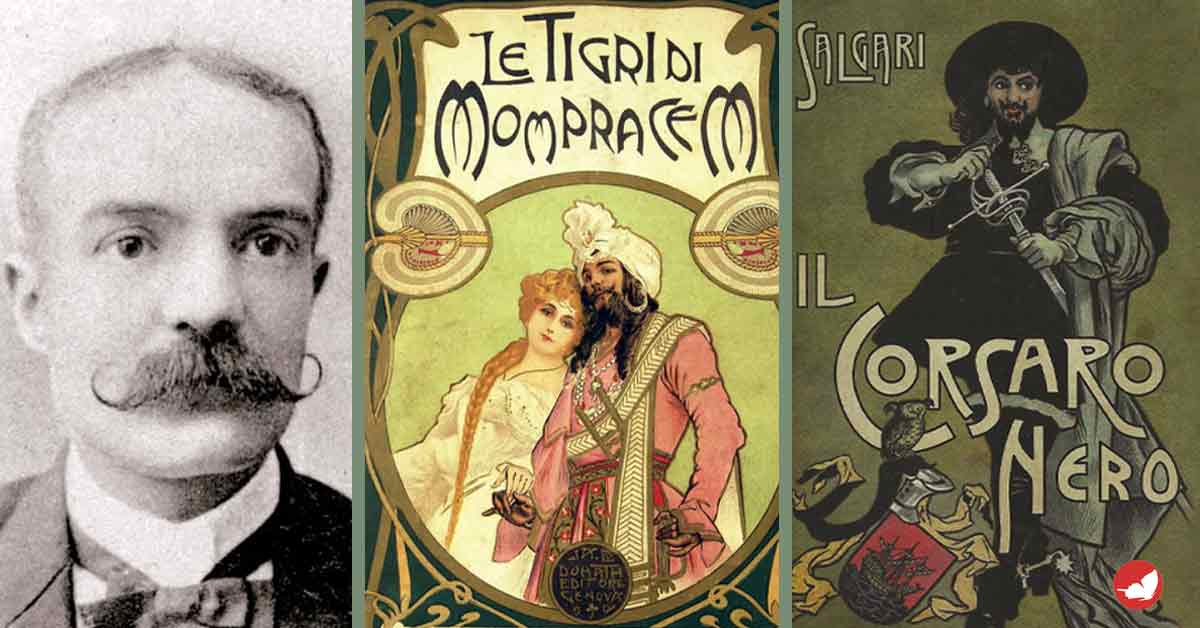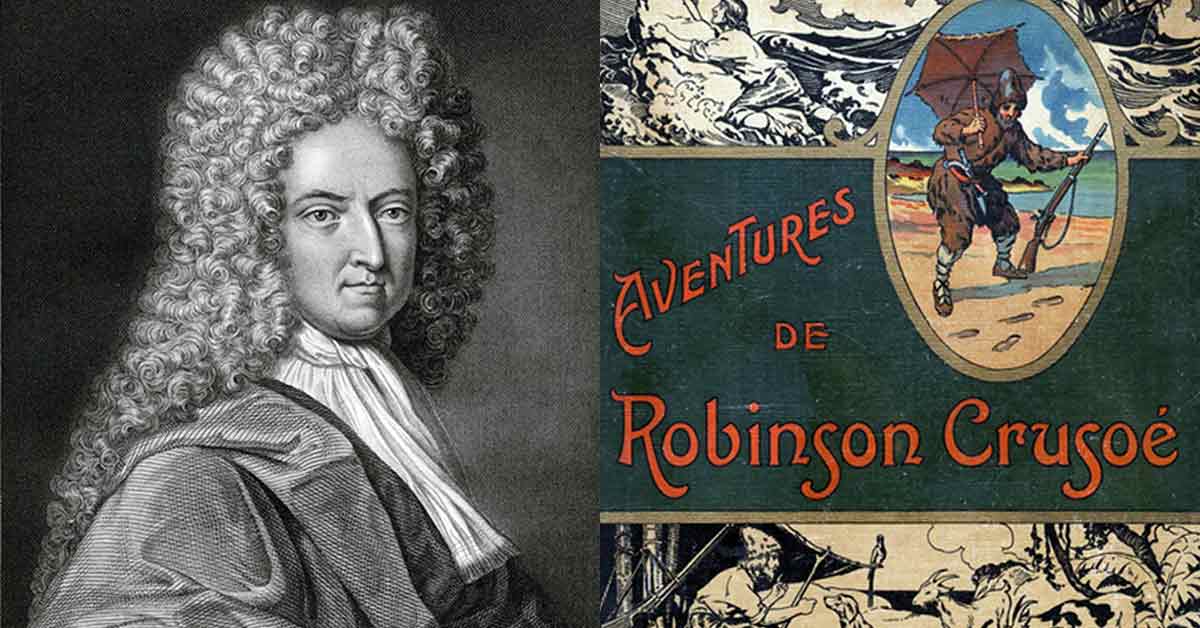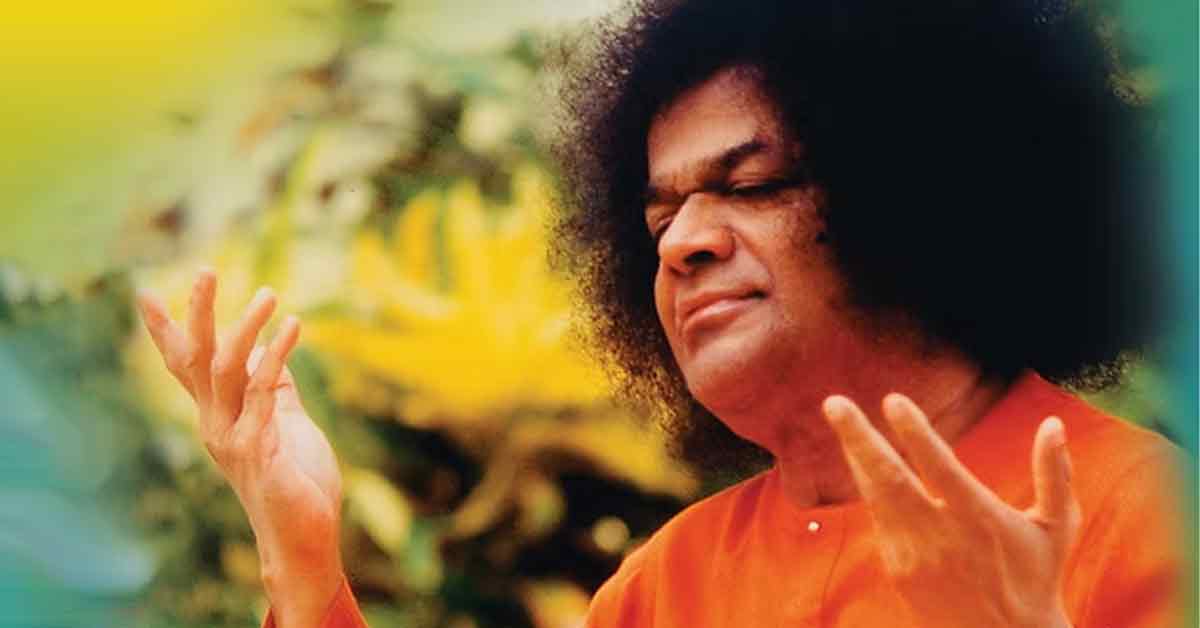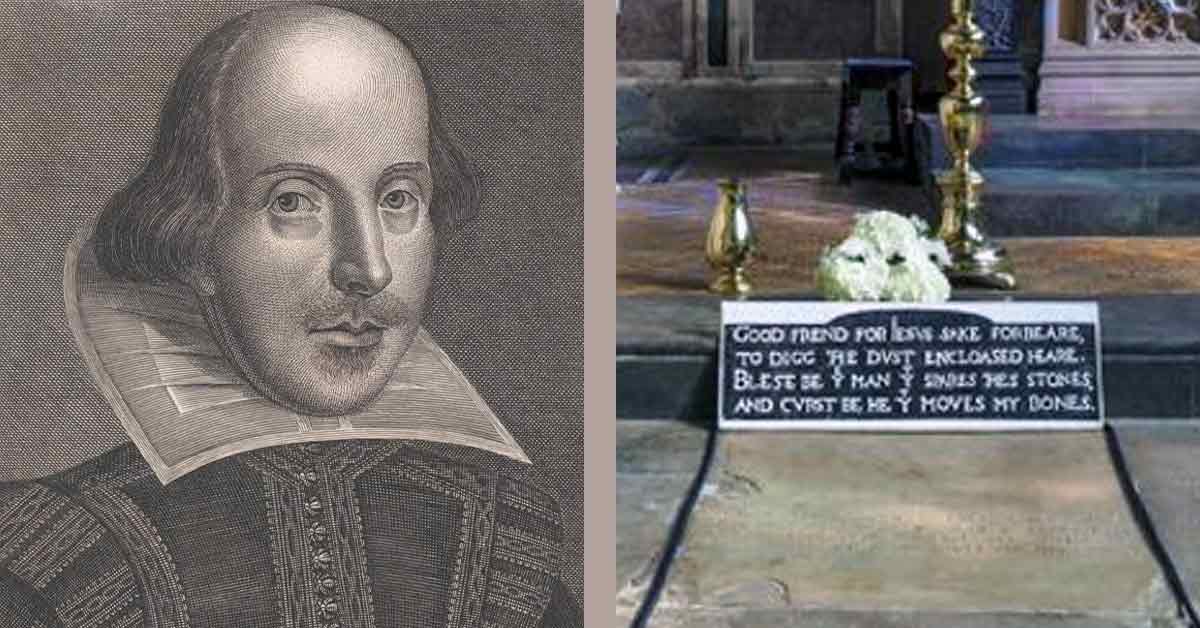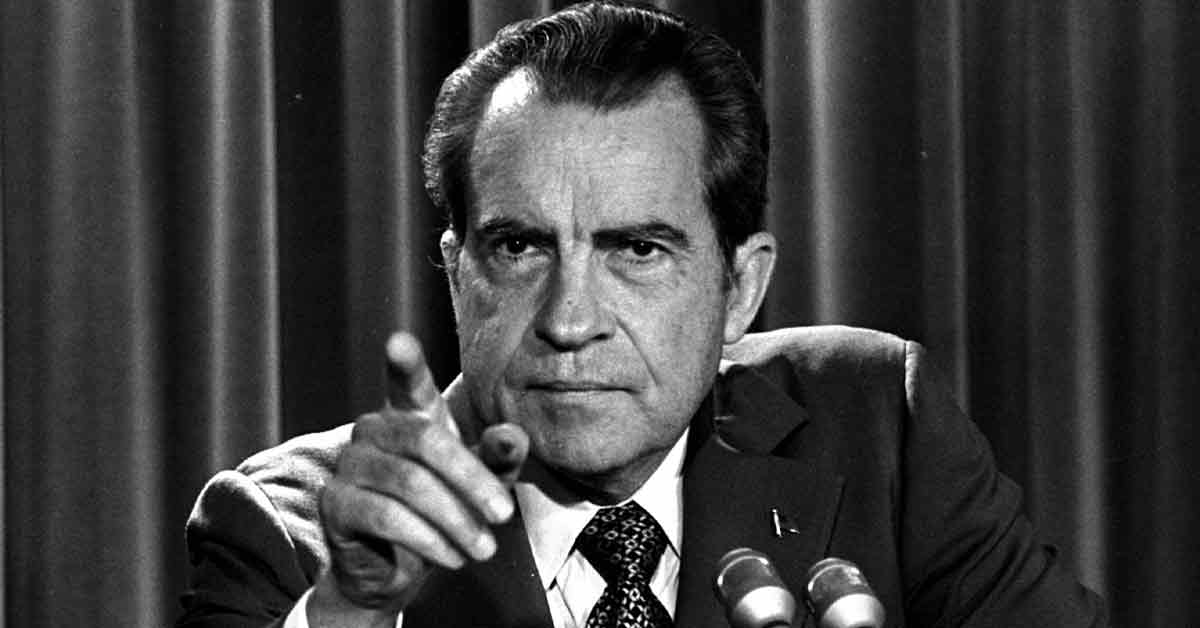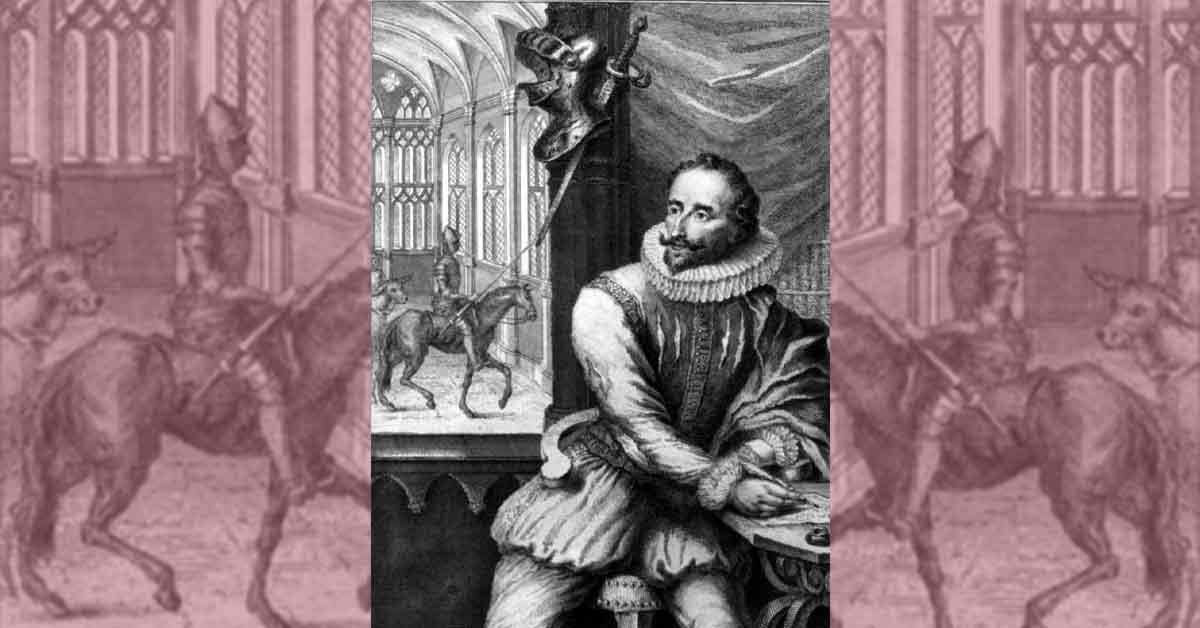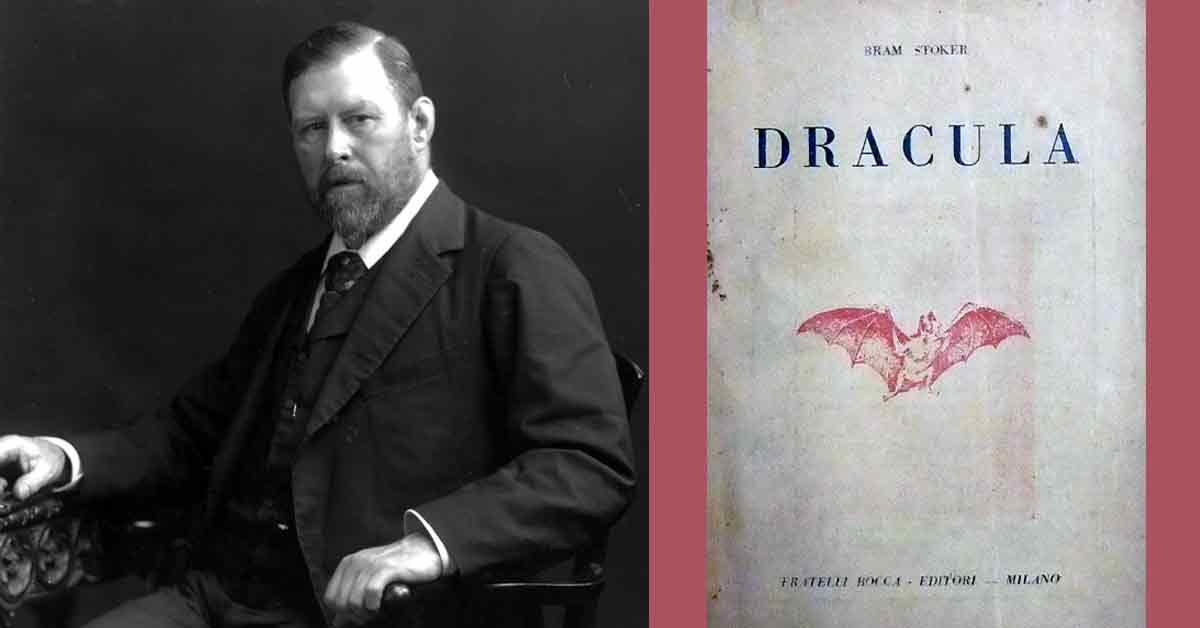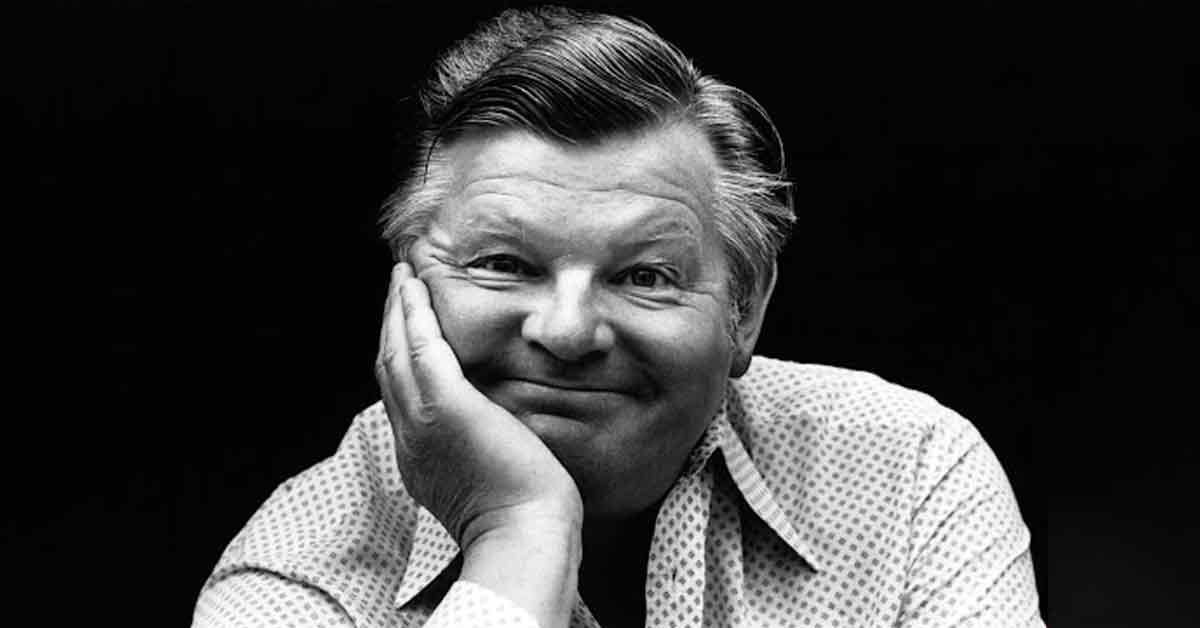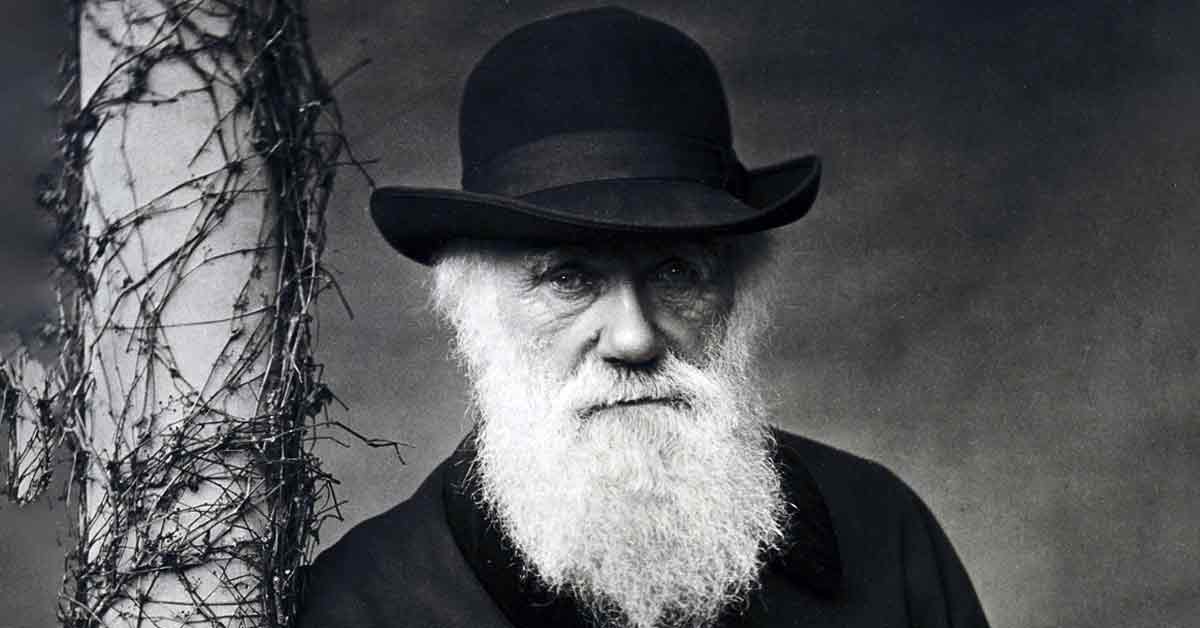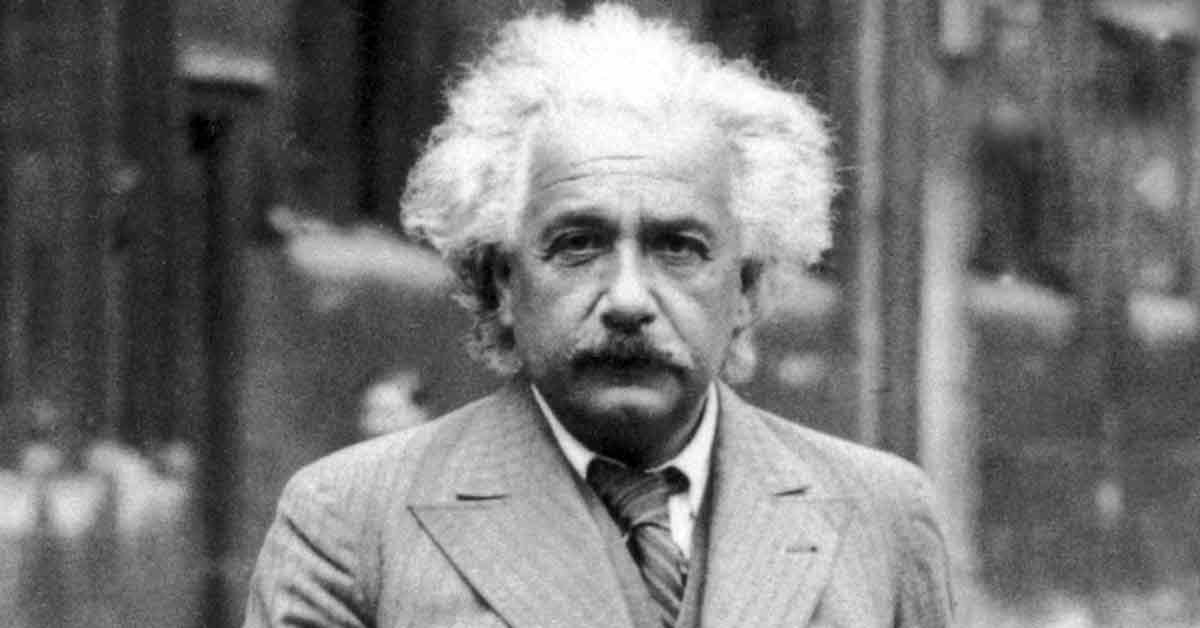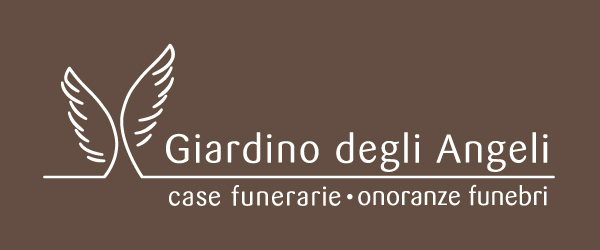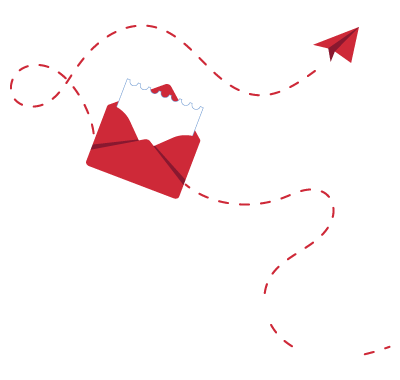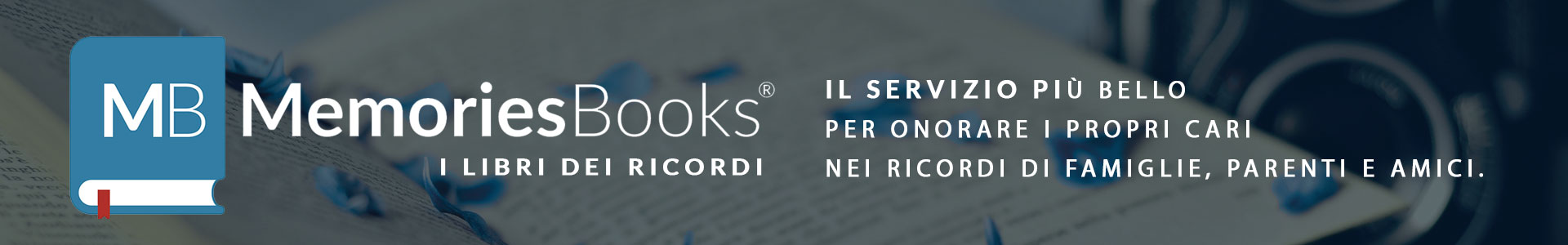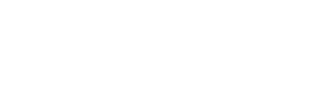15 aprile 1446. Muore Filippo Brunelleschi: arte, scienza e architettura.

Filippo Brunelleschi nasce a Firenze nel 1377.
Figlio di un notaio, cresce in una famiglia agiata e riceve un’ottima istruzione.
Si avvicina all’arte grazie all’apprendistato presso una bottega orafa, dove apprende il disegno, la fusione dei metalli e le tecniche decorative.
Dimostra fin da giovane una grande curiosità per la matematica e la geometria, basi su cui costruisce la sua futura carriera.
Dall’oreficeria alla scultura
Dopo gli studi, si iscrive all’Arte della Seta e inizia a lavorare come orafo.
Partecipa nel 1401 al famoso concorso per la porta nord del Battistero di Firenze con la formella del “Sacrificio di Isacco”.
Pur non vincendo, il confronto con Lorenzo Ghiberti segna l’inizio di una rivalità artistica destinata a durare anni.
Il viaggio a Roma e la scoperta dell’antico
Deluso dall’esito del concorso, si reca a Roma con Donatello per studiare le rovine classiche.
Analizza proporzioni, tecniche costruttive e dettagli architettonici degli edifici romani.
In questo periodo abbandona progressivamente la scultura per dedicarsi all’architettura.
Nasce così la figura dell’architetto moderno, non più semplice capomastro, ma intellettuale e progettista consapevole.
Brunelleschi e l’invenzione della prospettiva lineare
Tra il 1415 e il 1420, Brunelleschi rivoluziona la rappresentazione dello spazio con l’invenzione della prospettiva centrica.
Sperimenta tavolette dipinte con vedute urbane, osservabili attraverso un foro e uno specchio.
Dimostra che lo spazio si può rappresentare matematicamente, ponendo l’osservatore al centro del sistema visivo.
La scoperta influenza tutta l’arte rinascimentale, da Masaccio a Leonardo da Vinci.
L’ospedale degli Innocenti: la nuova architettura
Nel 1419 riceve l’incarico per lo Spedale degli Innocenti, primo edificio rinascimentale costruito ex novo.
Progetta un porticato armonico con colonne in pietra serena, archi a tutto sesto e proporzioni calcolate su moduli geometrici.
Introduce la bicromia grigio-bianca, diventata simbolo dell’architettura fiorentina.
La Cupola di Santa Maria del Fiore: un’impresa epica
Nel 1420 vince il concorso per costruire la cupola del Duomo di Firenze.
Progetta una struttura autoportante, senza armature di legno, con doppia calotta e tecniche murarie innovative.
Costruisce gru, argani e macchinari per sollevare i materiali.
La cupola diventa il simbolo di Firenze e dell’ingegno umano.
Nel 1436 assiste all’inaugurazione della cattedrale, coronando il suo sogno.
Brunelleschi e le altre opere architettoniche
Brunelleschi realizza la Sagrestia Vecchia e la basilica di San Lorenzo, applicando moduli fissi e una rigorosa simmetria.
Apre la strada alla razionalità spaziale del Rinascimento.
Nel 1434 progetta la Cappella dei Pazzi, sintesi tra pianta centrale e impianto modulare.
Dieci anni dopo inizia la ristrutturazione di Santo Spirito, capolavoro di equilibrio e luminosità.
Progetta anche edifici civili come il Palagio di Parte Guelfa e la Rotonda degli Angeli.
La lanterna e le tribune morte
Nel 1436 presenta il progetto per la lanterna del Duomo, approvato dopo un nuovo concorso.
Organizza il cantiere con impalcature girevoli e sistemi ingegnosi per il sollevamento.
Inizia anche la costruzione delle tribune morte, tempietti semicircolari che completano la zona absidale.
Scenografie e spettacoli sacri
Brunelleschi progetta ingegni meccanici per rappresentazioni religiose, come l’Annunciazione o l’Ascensione.
Introduce effetti speciali con angeli sospesi, luci improvvise e strutture rotanti.
Questi allestimenti anticipano il teatro barocco e mostrano la sua versatilità come scenografo.
La morte e i funerali di Brunelleschi
Filippo Brunelleschi muore nella notte tra il 15 e il 16 aprile 1446 a Firenze.
Viene sepolto solennemente nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, un onore riservato ai grandi della città.
Sull’epitaffio si legge il riconoscimento del suo ingegno, paragonato a quello di Dedalo.
La sua tomba, dimenticata per secoli, viene riscoperta nel 1972.
Il busto scolpito dal Buggiano, suo figlio adottivo, lo raffigura all’interno del Duomo, rivolto verso la cupola, suo capolavoro eterno.
Filippo Brunelleschi nasce a Firenze nel 1377.
Figlio di un notaio, cresce in una famiglia agiata e riceve un’ottima istruzione.
Si avvicina all’arte grazie all’apprendistato presso una bottega orafa, dove apprende il disegno, la fusione dei metalli e le tecniche decorative.
Dimostra fin da giovane una grande curiosità per la matematica e la geometria, basi su cui costruisce la sua futura carriera.
Dall’oreficeria alla scultura
Dopo gli studi, si iscrive all’Arte della Seta e inizia a lavorare come orafo.
Partecipa nel 1401 al famoso concorso per la porta nord del Battistero di Firenze con la formella del “Sacrificio di Isacco”.
Pur non vincendo, il confronto con Lorenzo Ghiberti segna l’inizio di una rivalità artistica destinata a durare anni.
Il viaggio a Roma e la scoperta dell’antico
Deluso dall’esito del concorso, si reca a Roma con Donatello per studiare le rovine classiche.
Analizza proporzioni, tecniche costruttive e dettagli architettonici degli edifici romani.
In questo periodo abbandona progressivamente la scultura per dedicarsi all’architettura.
Nasce così la figura dell’architetto moderno, non più semplice capomastro, ma intellettuale e progettista consapevole.
Brunelleschi e l’invenzione della prospettiva lineare
Tra il 1415 e il 1420, Brunelleschi rivoluziona la rappresentazione dello spazio con l’invenzione della prospettiva centrica.
Sperimenta tavolette dipinte con vedute urbane, osservabili attraverso un foro e uno specchio.
Dimostra che lo spazio si può rappresentare matematicamente, ponendo l’osservatore al centro del sistema visivo.
La scoperta influenza tutta l’arte rinascimentale, da Masaccio a Leonardo da Vinci.
L’ospedale degli Innocenti: la nuova architettura
Nel 1419 riceve l’incarico per lo Spedale degli Innocenti, primo edificio rinascimentale costruito ex novo.
Progetta un porticato armonico con colonne in pietra serena, archi a tutto sesto e proporzioni calcolate su moduli geometrici.
Introduce la bicromia grigio-bianca, diventata simbolo dell’architettura fiorentina.
La Cupola di Santa Maria del Fiore: un’impresa epica
Nel 1420 vince il concorso per costruire la cupola del Duomo di Firenze.
Progetta una struttura autoportante, senza armature di legno, con doppia calotta e tecniche murarie innovative.
Costruisce gru, argani e macchinari per sollevare i materiali.
La cupola diventa il simbolo di Firenze e dell’ingegno umano.
Nel 1436 assiste all’inaugurazione della cattedrale, coronando il suo sogno.
Brunelleschi e le altre opere architettoniche
Brunelleschi realizza la Sagrestia Vecchia e la basilica di San Lorenzo, applicando moduli fissi e una rigorosa simmetria.
Apre la strada alla razionalità spaziale del Rinascimento.
Nel 1434 progetta la Cappella dei Pazzi, sintesi tra pianta centrale e impianto modulare.
Dieci anni dopo inizia la ristrutturazione di Santo Spirito, capolavoro di equilibrio e luminosità.
Progetta anche edifici civili come il Palagio di Parte Guelfa e la Rotonda degli Angeli.
La lanterna e le tribune morte
Nel 1436 presenta il progetto per la lanterna del Duomo, approvato dopo un nuovo concorso.
Organizza il cantiere con impalcature girevoli e sistemi ingegnosi per il sollevamento.
Inizia anche la costruzione delle tribune morte, tempietti semicircolari che completano la zona absidale.
Scenografie e spettacoli sacri
Brunelleschi progetta ingegni meccanici per rappresentazioni religiose, come l’Annunciazione o l’Ascensione.
Introduce effetti speciali con angeli sospesi, luci improvvise e strutture rotanti.
Questi allestimenti anticipano il teatro barocco e mostrano la sua versatilità come scenografo.
La morte e i funerali di Brunelleschi
Filippo Brunelleschi muore nella notte tra il 15 e il 16 aprile 1446 a Firenze.
Viene sepolto solennemente nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, un onore riservato ai grandi della città.
Sull’epitaffio si legge il riconoscimento del suo ingegno, paragonato a quello di Dedalo.
La sua tomba, dimenticata per secoli, viene riscoperta nel 1972.
Il busto scolpito dal Buggiano, suo figlio adottivo, lo raffigura all’interno del Duomo, rivolto verso la cupola, suo capolavoro eterno.